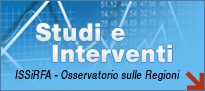AS n. 1476, 16.5.2007, Stiffoni (Modifiche alla Parte II, Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla Provincia di Treviso dello statuto d’autonomia provinciale)
———– XV LEGISLATURA ———–
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1476
d’iniziativa del senatore STIFFONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2007
———–
Modifiche alla Parte II, Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla Provincia di Treviso dello statuto d’autonomia provinciale
—-——-
Onorevoli Senatori. – Presupposti e finalità
Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge in titolo riassume quanto già previsto in precedenza da un disegno di legge di iniziativa popolare, suffragato quindi dalla volontà di 50.000 persone, presentato nella XIII legislatura e perciò decaduto, i cui princìpi ispiratori si ritengono ancora di estrema attualità.
Il disegno di legge intende introdurre nella carta costituzionale il principio della cosiddetta «autonomia a geometria variabile»: la possibilità, cioè, offerta a tutte le Province e non solo a quella di Treviso, di godere di poteri particolari, anche legislativi, più ampi ed incisivi rispetto a quelli corrispondenti ad uno «statuto» ordinario.
Nel rinviare al prosieguo l’esame più analitico del progetto formulato, si può infatti fin da subito sottolineare come il disegno di legge abbia quale oggetto principale la configurazione dei tratti essenziali di tale «regime speciale», regime che potrà (si sottolinea potrà) essere riconosciuto a tutte le province che si candidino a tale assunzione di responsabilità sul presupposto del possesso di condizioni socio-economiche che la giustifichino.
Treviso, ritenendo di possedere già, sulla base di studi fatti, le predette, necessarie condizioni socio-economiche, si propone fin da subito per quell’assunzione di responsabilità, cosicché il disegno di legge contiene una disposizione che la concerne specificamente e nominativamente (vedi l’articolo 5 che prevede l’introduzione dell’art. 116-bis della Costituzione).
Ma il disegno di legge riguarda in realtà – si ribadisce – gli enti intermedi di tutto il territorio nazionale.
La previsione di una «geometria variabile» in relazione specificamente alle Province si giustifica sulla base di varie considerazioni.
Il dibattito sul «diritto all’esistenza» e sul ruolo della Provincia è assai vivo in Italia, sia nella pubblicistica scientifica che in quella dei mass-media. Taluni studiosi sono convinti che questo ente, «intermedio» tra i Comuni e le Regioni, non abbia alcun significato. Altri, al contrario, ritengono il ruolo delle Province significativo ed importante, e fanno riferimento ad uno scenario internazionale in cui livelli di governo omologhi alla Provincia sono ben presenti, e per di più dispongono di bilanci assai più robusti di quelli affidati alle Province italiane.
Nell’ambito della evoluzione della normativa del nostro Paese, chiaramente orientata ad un rafforzamento del ruolo degli enti locali, si può intravedere che la scelta del legislatore italiano è andata nella direzione di assegnare un ruolo più incisivo alle Province.
Oltre alle leggi ordinarie appena richiamate, che rappresentano il fondamento dell’attuale struttura degli enti locali, è necessario richiamare altri due princìpi:
a) principio di autonomia (ex articolo 5 della Costituzione);
b) principio di sussidiarietà (stabilito dal Trattato di Maastricht).
In base all’articolo 5 della Costituzione «la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali». È inserito nella parte prima della Costituzione che stabilisce i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico.
Nell’attuale ordinamento sono già presenti due Province autonome – Trento e Bolzano – caratterizzate dalla potestà legislativa primaria in numerose ed importanti materie e dalla potestà legislativa secondaria in altre materie (al pari delle altre Regioni a statuto speciale), oltre che da quote di devoluzione dei tributi erariali indicate nel loro statuto (approvato con legge costituzionale).
Sulla base di tali considerazioni la richiesta di trasformare Treviso in Provincia autonoma non è improcedibile e nemmeno improponibile.
Tantomeno lo è la previsione della mera possibilità di una trasformazione eventuale di altre Province che ritengano di attivare il procedimento di riconoscimento dello statuto speciale.
Il secondo principio è ribadito dal Trattato di Maastricht sull’Unione europea e quindi rappresenta un principio accolto anche nel nostro ordinamento.
Infatti l’articolo 2(B) del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, stabilisce che l’Unione attua i princìpi indicati nel Trattato medesimo rispettando il principio di sussidiarietà.
In base ai Trattati, debitamente recepiti nell’ordinamento italiano, la Comunità europea, nelle materie che non sono di sua esclusiva competenza, interviene in base al «principio della sussidiarietà» soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. In tale direzione si era autorevolmente mossa la Commissione bicamerale presieduta dall’onorevole D’Alema proponendo di inserire in Costituzione (nuovo articolo 56) il citato «principio di sussidiarietà».
Con l’affermazione di questo fondamentale principio anche gli enti sub-centrali di governo ed in particolare le Province ed i Comuni assumono una maggiore rilevanza poiché lo Stato deve svolgere quelle funzioni ed erogare quei «beni pubblici» che risultano essere più efficaci man mano ci si avvicina ai livelli territoriali più vicini alle rispettive popolazioni.
In effetti il principio di sussidiarietà impone l’esercizio delle funzioni da parte del livello di governo più vicino al cittadino se è in grado di adempiervi in modo efficiente. In base a tale principio l’Unione europea attribuisce, pertanto, ampio riconoscimento alle forme di decentramento, o meglio di autonomia.
È prevista anche una sussidiarietà orizzontale, in base alla quale le funzioni tra gli stessi livelli di governo possono essere ripartite in modo diverso (si parla anche di autonomia a «geometria variabile»).
Questi due princìpi collegano la società reale e le istituzioni perché avvicinano i cittadini ai centri decisionali.
La richiesta di autonomia speciale per la Provincia di Treviso si giustifica per le peculiarità storico-sociali ed economico-finanziarie del territorio trevigiano e va considerata nell’ambito del citato «autonomismo variabile».
Ragioni storico-sociali
L’elemento storico trova la sua origine ai tempi della Repubblica Serenissima di Venezia. In quell’ordinamento, tra l’altro studiato anche da Franklin per applicarne alcuni princìpi al nascente ordinamento americano, la Provincia di Treviso si vede riconosciuto un ordinamento peculiare. E sin da quell’epoca la Provincia si contraddistingue per il suo policentrismo, così come ora Treviso è caratterizzata dal policentrismo soprattutto per ciò che riguarda l’aspetto imprenditoriale.
Da sempre, quindi, i valori dell’autonomia e dell’autogoverno sono assolutamente radicati nel tessuto sociale della Provincia di Treviso. I trevigiani, oltre che essere conosciuti come «il popolo delle partite IVA», con un imprenditore ogni sette abitanti (il che sta ad indicare la capacità di fare impresa), sono una comunità che mal sopporta l’inefficienza dello Stato negli ambiti fondamentali che riguardano la società e che preferisce costituire associazioni di volontariato (un cittadino ogni cinque) per rispondere alle esigenze che lo Stato non riesce a soddisfare, piuttosto che invocarne l’aiuto.
Ragioni economico-finanziarie
Il territorio di Treviso è caratterizzato sinteticamente, dalle seguenti peculiarità:
– ha una popolazione di 784.054 abitanti suddivisa in 95 Comuni;
– dispone di un sistema economico-produttivo che per gli anni 1996-1997 ha rappresentato il 17,5 per cento del prodotto interno lordo (PIL) regionale e che supera del 31 per cento il PIL nazionale pro capite;
– si colloca al quinto posto della graduatoria del PIL provinciale, salendo nel 1998 di ben 22 posti rispetto al 1991;
– ha una movimentazione demografica che, al 1998, è stata la più rilevante delle province venete, segnando un più 8,8 per mille;
– ha un reddito pro capite al di sopra del 20 per cento rispetto alla media europea;
– registra ritmi di crescita del contributo delle attività terziarie al resto dell’economia tra i più elevati d’Italia;
– ha un tasso di attività superiore alla media delle altre Province del Veneto e dell’Italia;
– registra un tasso di disoccupazione praticamente fisiologico, pari al 3,5 per cento;
– annovera 56.408 imprese, di cui 22.598 a carattere artigianale.
Nessuna sorpresa, dunque, che sia stato stimato che il territorio trevigiano fornisca allo Stato italiano un ammontare totale di risorse tributarie e para-tributarie pari (nel 1997) a 8.040 miliardi di lire.
Tale cifra risulta assolutamente «capiente» rispetto a qualsivoglia soluzione autonomistica si volesse costruire a Treviso, in particolare a una soluzione imperniata sull’amministrazione provinciale.
Invero, dallo studio finanziario sulla Provincia di Treviso effettuato da eminenti studiosi emerge che, ove essa assumesse il complesso delle funzioni oggi esercitate dalla Provincia autonoma di Trento – e che sono previste dal disegno di legge presentato, insieme con la devoluzione appropriata di tributi erariali – la Provincia di Treviso potrebbe autonomamente sostenere tutte le spese di parte corrente, pari a circa 2 miliardi di euro, a fronte di un volume di risorse di circa 3 miliardi di euro, derivante dall’applicazione di un regime finanziario del tutto analogo a quello vigente a Trento.
In altri termini: la Provincia di Treviso, avendo a disposizione risorse più che sufficienti per l’esercizio delle proprie (ipotetiche) maggiori funzioni, non inciderebbe in alcun modo sul bilancio dello Stato. Non solo: ma stime preliminari indicano che le residue risorse fiscali originate dal territorio e non utilizzate né dalla Provincia né dai Comuni o dalla Regione (sul territorio provinciale) sarebbero sufficienti per pagare allo Stato i servizi che esso continuerebbe a fornire (difesa nazionale, politica estera, eccetera).
Si rende ora opportuna una considerazione finale per prevenire una sicura domanda, cioè: perché scegliere la Provincia come livello di governo autonomo del territorio provinciale e non invece la Regione?
Le ragioni sono presto dette:
a) la Provincia rappresenta il livello di governo ottimale e più efficiente per il numero di abitanti, l’estensione, ma soprattutto per l’omogeneità dei problemi che il territorio esprime;
b) non si può non tenere conto del nuovo ruolo che viene assegnato alla provincia dalle «leggi Bassanini» e dai relativi decreti delegati nonché delle deleghe che le Regioni dovrebbero attivare nei confronti della Provincia;
c) con riferimento agli aspetti amministrativi, la Provincia di Treviso vanta già da tempo una tradizione consolidata di gestione amministrativa in alcune materie, come per esempio la formazione professionale; e sarebbe sicuramente in grado di agire con maggiore tempestività e snellezza della Regione in qualsiasi nuova funzione le venisse attribuita.
Invero, disponendo di un proprio statuto di autonomia, la Provincia di Treviso sarebbe in grado di soddisfare le richieste che derivano direttamente dalla società civile e che non riescono a tutt’oggi ad avere risposta; si pensi, per fare solo alcuni cenni, al problema impellente delle infrastrutture, alla mancanza di strade necessarie a sopportare il crescente sviluppo economico, ma anche alla richiesta di sicurezza pubblica che potrebbe essere soddisfatta attraverso l’attribuzione (prevista dallo statuto autonomo) all’ente della regolamentazione delle polizia urbana e rurale.
In conclusione, se vi è consenso sulle seguenti proposizioni:
I) che l’Unione europea favorisce, attraverso il principio della sussidiarietà, un maggior ruolo per gli enti locali e quindi anche per le Province;
II) che l’autonomia speciale dovrebbe essere attribuita a tutti gli enti (che ne fanno richiesta) che godono di caratteristiche di sviluppo e di crescita in grado di sopportare ordinamenti e strutture istituzionali di autonomia provinciale;
III) che si dovrebbe poter sperimentare un’autonomia a velocità o «geometria variabile» nella quale gli enti che lo richiedono ricevono dallo Stato funzioni e mezzi necessari per farvi fronte;
IV) che il luogo della tassazione coincida con quello della spesa, per una duplice motivazione: da un lato per responsabilizzare i centri di potere e dall’altro per permettere un miglior controllo da parte dei soggetti tassati, allora l’autonomia provinciale richiesta da Treviso non prefigura alcun privilegio, ma solo l’attuazione di princìpi ormai comunemente condivisi in Europa.
Le norme
L’articolo 1 del presente disegno di legge modifica l’articolo 114 della Costituzione, inserendo un richiamo testuale ai valori dell’autonomia locale come obiettivo da perseguire nella configurazione sia dell’organizzazione pubblica sia dei contenuti dell’attività normativa e amministrativa.
L’articolo 2 introduce l’articolo 114-bis che contiene il principio di sussidiarietà, principio di origine e affermazione comunitaria e che ha trovato nell’ordinamento interno un primo riconoscimento in sede di legislazione ordinaria (legge 15 marzo 1997, n. 59, e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
L’articolo 3, inserendo l’articolo 115-bis della Costituzione, detta i connotati essenziali e di base, propri di tutti gli enti territoriali, del nuovo assetto delle autonomie locali auspicato dai proponenti del disegno di legge.
Viene in particolare prevista, innovativamente, la potestà – come si vedrà, eventuale – legislativa delle Province.
In attuazione del principio di sussidiarietà, inoltre, viene attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative e normative regolamentari assolvibili a livello comunale, con sganciamento della competenza amministrativa rispetto a quella normativa.
Viene eliminata ogni forma di controllo preventivo sugli atti normativi e amministrativi delle autonomie locali.
L’articolo 4, a modifica dell’articolo 116 della Costituzione, conferma l’attribuzione di condizioni particolari di autonomie alle attuali Regioni a statuto speciale, con la sola innovazione del richiamo testuale alle Province autonome di Trento e Bolzano.
L’articolo 5 prevede l’inserimento dell’articolo 116-bis della Costituzione, che attribuisce alla Provincia di Treviso lo statuto «speciale» dell’autonomia provinciale quale delineato dal nuovo articolo 117-bis della Costituzione introdotto dal presente disegno di legge.
L’articolo 6 introduce l’articolo 117-bis della Costituzione regolando in particolare, innovativamente, il rapporto tra legislazione regionale e legislazione delle Province che assumeranno il regime speciale.
Stabilisce al riguardo il principio per il quale nelle Regioni nelle quali alcuna delle Province abbia acquisito il regime differenziato, la legislazione regionale, rispetto a tali Province, può avere contenuto meramente programmatico e di coordinamento e riguardare le materie specificamente indicate nella norma.
L’articolo 7 introduce l’articolo 117-ter della Costituzione e ha un duplice contenuto.
In primo luogo, individua le materie di competenza legislativa e amministrativa delle Province con regime speciale.
In secondo luogo, con disposizione di carattere finanziario, fissa nel 60 per cento (salva la diversa percentuale per specifici tributi, imposta sul valore aggiunto (IVA) interna e per importazione) il livello minimo di devoluzione del gettito fiscale del territorio che, con legge dello Stato, deve essere assicurata al territorio stesso, prevedendo in più, in via surrogatoria, per il caso di mancato intervento normativo statale la possibilità di una trattenuta nei limiti predetti da parte degli uffici finanziari locali.
L’articolo 8 inserisce l’articolo 117-quater della Costituzione, il quale specifica le materie nelle quali è competente la Regione in relazione alle Province non munite di regime rafforzato.
L’articolo 9 aggiunge un comma all’articolo 118 della Costituzione.
L’articolo 10, introducendo l’articolo 133-bis della Costituzione, disciplina il procedimento di attribuzione dello statuto differenziato alle Province.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 114. – La Repubblica, allo scopo di rendere effettivo il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali e di adeguare i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento, è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».
1. Dopo l’articolo 115 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 114-bis. – I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni, stabiliti dalla Costituzione ed articolati secondo il principio di sussidiarietà».
1. Dopo l’articolo 115 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 115-bis. – I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa ed amministrativa.
La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Province e lo Stato.
Alle Province sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa ed amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all’erario secondo specifici statuti di autonomia provinciale adottati con leggi costituzionali.
È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative, anche nelle materie nelle quali la potestà legislativa spetta allo Stato, alle Regioni o alle Province, salve le funzioni espressamente attribuite alle Regioni, alle Province o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali e dalle leggi ordinarie, senza duplicazioni di funzioni e con l’individuazione delle rispettive responsabilità.
Tutti gli atti, normativi o regolamentari, delle Regioni, delle Province e dei Comuni non sono sottoposti, né sono sottoponibili, a controlli preventivi di legittimità o di merito».
1. L’articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 116. – Alle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e alle due Province autonome di Trento e di Bolzano, sono confermate e garantite costituzionalmente le forme e le condizioni di autonomia regionale e provinciale stabilite dai vigenti statuti e dalle relative leggi costituzionali».
1. Dopo l’articolo 116 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 116-bis. – Alla Provincia di Treviso sono attribuite le competenze legislative ed amministrative di cui all’articolo 117-ter, secondo uno statuto di autonomia provinciale adottato con legge costituzionale».
1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 117-bis. – Entro il territorio di una stessa Regione possono coesistere Province con uno statuto di autonomia provinciale e Province con statuto ordinario.
Nei confronti delle Province nelle quali vige lo statuto di autonomia provinciale la Regione emana norme legislative, con esclusivo carattere di programmazione e coordinamento, tenuto conto delle competenze provinciali nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
b) espropriazione per pubblica utilità per le opere pubbliche di propria competenza;
c) regolamentazione dell’ordinamento degli enti preposti alla erogazione delle cure sanitarie o comunque operanti nel campo sanitario ed ospedaliero;
d) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di carattere regionale;
e) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale».
1. Dopo l’articolo 117-bis della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 117-ter. – Ogni Provincia alla quale è attribuito lo statuto di autonomia provinciale ha competenza di legislazione e di amministrazione nelle seguenti materie:
a) indirizzi generali di assetto e coordinamento del territorio provinciale;
b) circoscrizioni comunali;
c) toponomastica provinciale;
d) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
e) tutela, conservazione e sviluppo del patrimonio storico, culturale, artistico e popolare, delle tradizioni, storia, lingue e dialetti;
f) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;
g) organizzazione di manifestazioni e di attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con mezzi radiotelevisivi;
h) urbanistica, piano territoriale provinciale e piani regolatori comunali;
i) difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale e del paesaggio, prevenzione delle calamità;
l) usi civici;
m) ordinamento delle minime proprietà agricole e di quelle di collina e di montagna;
n) artigianato;
o) edilizia comunque sovvenzionata;
p) porti fluviali a lacuali;
q) fiere e mercati;
r) tutela, utilizzazione e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
s) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
t) caccia e pesca;
u) agricoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
v) viabilità, acquedotti e lavori pubblici d’interesse provinciale;
z) comunicazioni e trasporti d’interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l’esercizio degli impianti di funivia;
aa) assunzione diretta o partecipata di servizi pubblici e loro gestioni a mezzo di aziende speciali;
bb) turismo, industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
cc) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
dd) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
ee) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l’assistenza, l’orientamento al lavoro e l’aggiornamento permanente, nonché la riqualificazione dei lavoratori disoccupati;
ff) opere idrauliche, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
gg) assistenza e beneficenza pubblica;
hh) scuola materna;
ii) assistenza scolastica per i settori nei quali le Province hanno competenza legislativa;
ll) edilizia scolastica;
mm) addestramento e formazione professionale, anche post-laurea e di specializzazione;
nn) polizia locale urbana e rurale;
oo) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
pp) commercio;
qq) apprendistato e lavoro;
rr) incremento della produzione industriale attraverso la creazione di poli tecnologici ed incubatoi per l’innovazione;
ss) igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria ospedaliera;
tt) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;
uu) esercizi pubblici;
vv) utilizzazione a livello provinciale delle acque pubbliche escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
zz) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni;
aaa) servizi antincendi;
bbb) sviluppo della cooperazione.
Per consentire alle Province con lo statuto di autonomia provinciale di svolgere adeguatamente le competenze di legislazione e di amministrazione nelle materie indicate nel primo comma, una congrua quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale – e, comunque, non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi, con l’esclusione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) interna, per la quale la devoluzione è del 70 per cento del gettito e dell’IVA per l’importazione, per la quale la devoluzione è pari al 40 per cento del gettito – è attribuita alla Provincia stessa. La devoluzione ha luogo secondo disposizioni approvate con legge dello Stato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto. La mancata emanazione della legge entro il predetto termine comporta l’obbligo, da parte dei competenti Uffici erariali provinciali, di procedere alla trattenuta delle quote indicate ed alla loro immediata devoluzione alla Provincia interessata».
1. Dopo l’articolo 117-ter della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 117-quater. – La Regione emana norme legislative per le seguenti materie nelle Province nelle quali non vige lo statuto di autonomia provinciale:
a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
b) circoscrizioni comunali;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) fiere e mercati;
e) beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
f) istruzione artigiana professionale e assistenza scolastica;
g) musei e biblioteche di enti locali;
h) urbanistica;
i) turismo e industria alberghiera;
l) tramvie e linee automobilistiche d’interesse regionale;
m) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
n) navigazione e porti lacuali e fluviali;
o) acque minerali e termali;
p) cave e torbiere;
q) caccia;
r) pesca nelle acque interne;
s) agricoltura e foreste;
t) artigianato;
u) altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».
1. All’articolo 118 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il secondo e terzo comma non si applicano alle Province aventi uno statuto di autonomia provinciale».
1. Dopo l’articolo 133 della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 133-bis. – L’attribuzione degli statuti di autonomia provinciale è proposta su iniziativa di almeno cinquantamila elettori i quali presentano, secondo la normativa esistente, un apposito progetto di legge costituzionale redatto in articoli secondo quanto disposto dall’articolo 71, secondo comma. Il progetto di legge deve essere corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche comunitarie territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello sviluppo sociale ed economico e della capacità contributiva globale della Provincia per la quale si propone l’attribuzione dello statuto di autonomia provinciale.
Il presidente della Provincia ed il Consiglio provinciale entro dieci giorni dalla pubblicazione del progetto di legge nella Gazzetta Ufficiale, inviano alla Camera presso la quale il progetto di legge di cui al primo comma è stato presentato, disgiuntamente e nella forma di cui all’articolo 50 della Costituzione, un parere obbligatorio ma non vincolante sul merito del provvedimento legislativo richiesto dai cittadini».