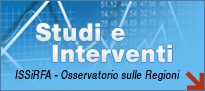AS n. 1740, 25.7.2007, Scalfaro e Altri (Modifica art. 138 Cost.)
———– XV LEGISLATURA ———–
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1740
d’iniziativa dei senatori SCALFARO, FINOCCHIARO, BIANCO, SALVI, ZANDA, VILLONE, ZANONE, D’AMBROSIO, MANZELLA, MACCANICO, BRUTTI Massimo e RUSSO SPENA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2007
———–
Modifica all’articolo 138 della Costituzione
———–
Onorevoli Senatori. – La nostra Costituzione, approvata 60 anni fa dall’Assemblea costituente a larghissima maggioranza, è ancora oggi largamente condivisa dalla grande maggioranza degli italiani e forte nelle loro coscienze, come ha dimostrato la conferma referendaria del 25-26 giugno 2006. È stato scritto che la riforma costituzionale della maggioranza nella XIV legislatura è stata distrutta da un voto popolare frettoloso e disinformato; ma questo giudizio, esso sì superficiale e non corrispondente alla realtà, ignora che spesso la consapevolezza da parte del popolo della minaccia portata ai valori fondamentali della Repubblica democratica è più lungimirante delle approssimazioni di qualche editorialista. E finge di ignorare anche che la valutazione della larga maggioranza degli elettori fu allora condivisa e supportata dalle opinioni di gran parte dei costituzionalisti italiani, di ogni parte politica.
Dunque la Costituzione è forte ed è stata rafforzata dalla convalida referendaria del 2006. Nell’ultimo quindicennio si è indebolita, pertanto, non l’adesione della comunità italiana alla Carta fondamentale, ma la garanzia della sua rigidità: in altre parole, è diventato troppo facile cambiare le norme costituzionali, da quando è stato abbandonato il sistema elettorale che aveva retto la nostra vita politica durante quarantasette anni, e da quando si è attenuata nelle forze politiche la convinzione che in ogni caso alle riforme costituzionali si dovesse procedere solo sulla base di larghe convergenze. Le nuove leggi per l’elezione della Camera e del Senato, sia quelle a prevalenza maggioritaria approvate dopo il referendum del 1993 sia quelle proporzionali con premio di maggioranza adottate nel 2005, consentono a maggioranze relative di elettori di diventare maggioranze assolute dei deputati e senatori; così la quota di voti parlamentari necessaria per l’approvazione in seconda deliberazione di riforme costituzionali (metà più uno degli eletti) è, per così dire, a portata di mano e costituisce di per sé una forte tentazione a cambiare le regole e i principi della costituzione secondo le opinioni o, peggio, le convenienze dei vincitori nell’ultima competizione elettorale. A questa tentazione hanno ceduto, com’è noto, sia la maggioranza di centro sinistra della XIII legislatura, con l’approvazione della riforma del titolo V, sia la maggioranza di centro destra della scorsa legislatura con l’adozione della riforma che investiva l’intera parte seconda della Carta.
Come è noto, il carattere rigido della Carta costituzionale rappresenta, insieme all’indipendenza degli organi di garanzia (Presidente della Repubblica e Corte costituzionale), il presidio più robusto per evitare che la Costituzione diventi uno strumento della politica della coalizione vincitrice nelle elezioni politiche. Ha affermato recentemente Enzo Cheli che «la Costituzione appartiene [...] a tutti i cittadini e va, di conseguenza, sottratta alla disponibilità della maggioranza, anzi deve operare essenzialmente come un sistema di limiti alla maggioranza» (Lo Stato costituzionale, radici e prospettive, Napoli, editoriale scientifica, 2006, p. 15). Le Costituzioni democratiche, infatti, riconoscono ed enunciano i principi e i valori condivisi da tutta la comunità nazionale. Rappresentano l’elemento fondamentale di identità e di unità di una nazione, sottostante alla diversità delle culture e delle opinioni politiche. Esse riconoscono e sanciscono, nel loro contenuto essenziale, i fondamentali diritti civili, economici e sociali, che spettano ad ogni persona umana, e gli inderogabili doveri di solidarietà, che da ciascuno devono essere osservati. Definiscono, inoltre, le regole generali della competizione democratica. Danno la certezza che la dignità umana e i diritti e le libertà che ne sono strumenti imprescindibili non dipendono dalle alterne vicende della competizione politica. Le Costituzioni non sono destinate, dunque, a cambiare ad ogni cambio di maggioranza, come può accadere per le leggi di settore. La stabilità delle Costituzioni serve a dare a tutti, anche alle minoranze, anche agli sconfitti nella competizione elettorale, la certezza che i diritti le libertà e le regole democratiche fondamentali non sono alla mercé del vincitore dell’ultima competizione elettorale.
In quasi tutte le grandi democrazie si è ritenuto e si ritiene dunque che le leggi di revisione costituzionale debbano essere il prodotto di larghe intese fra maggioranza e opposizione. È una conseguenza coerente della esigenza di stabilità, del ruolo di garanzia dei diritti e delle libertà di tutti (e dunque anche delle minoranze) che è proprio delle Costituzioni democratiche. Un Paese non può vivere e crescere se le regole fondamentali della convivenza comune durano una sola legislatura e mutano ad ogni cambio di maggioranza. L’erosione della stabilità costituzionale, registrata in Italia negli ultimi anni, rappresenta uno degli elementi del clima generale di insicurezza e di smarrimento che prevale nel Paese, ed uno dei fattori della sua crisi. Recuperare il valore della stabilità costituzionale (della certezza delle regole, delle libertà e dei diritti) ristabilire il principio della supremazia e rigidità della Costituzione appare oggi una esigenza nazionale, uno dei pochi grandi obiettivi che dovrebbero essere condivisi da tutti, indipendentemente dalle collocazioni politiche.
Orbene, perché questo obiettivo si realizzi è necessario che il procedimento per la revisione della Carta costituzionale (articolo 138 della Costituzione) si differenzi seriamente da quello adottato per la legislazione ordinaria. Ma, come già abbiamo accennato, il passaggio nel 1993 dal sistema proporzionale a quello maggioritario per l’elezione delle due Camere, oltre a produrre, insieme ad altre cause, una forte spinta alla bipolarizzazione degli schieramenti politici, ha provocato anche una crisi della rigidità della nostra Costituzione. L’aggravamento procedurale previsto dalla disposizione ora citata si è rivelato, a partire dal 1994, inadeguato a garantire la superiorità della Costituzione rispetto alla legge ordinaria, giacché le nuove leggi elettorali consentono di raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere anche a coalizioni che rappresentano solo la minoranza più forte del corpo elettorale. Questa situazione non è mutata con l’ultima legge elettorale che prevede pur sempre un premio di maggioranza nel quadro di un sistema ispirato al principio proporzionalistico. In definitiva l’articolo 138, con la disciplina attuale, induce in tentazione le maggioranze ad operare da sole le modificazioni della Costituzione, che il Costituente aveva affidato ad una deliberazione basata su un consenso più ampio, nel contesto di un sistema davvero proporzionale, nelle regole e nei risultati, quale era quello accolto dall’Assemblea costituente con l’approvazione dell’ordine del giorno Giolitti.
L’esame delle soluzioni adottate da altri paesi di democrazia matura consiglia di rendere più difficile le procedure di revisione. Si può ricordare per esempio la Legge fondamentale tedesca (che richiede il voto favorevole dei due terzi del Bundestag e del Bundesrat); o la Costituzione della Norvegia (ancora due terzi dei membri dello Storting); ma soprattutto la procedura di revisione della Costituzione statunitense che può essere avviata su iniziativa o proposta di emendamento approvata dai due terzi dei membri di ciascuna Camera del Congresso, ovvero dal voto della maggioranza di una apposita Convenzione convocata dal Congresso su proposta di due terzi delle assemblee legislative statali; mentre la ratifica dell’emendamento richiede il voto favorevole delle assemblee legislative di almeno tre quarti degli Stati membri ovvero di apposite convenzioni formate su base statale e consenzienti in almeno tre quarti degli Stati.
Per le ragioni ora sinteticamente esposte, con il disegno di legge in esame si propone una modifica dell’articolo 138 della Costituzione, elevando a due terzi dei componenti delle Camere il quorum attualmente previsto per l’approvazione, in seconda votazione, di leggi di modifica o revisione della Costituzione; e di stabilire che non si faccia luogo a referendum se la legge di revisione costituzionale sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti (ora è previsto che ciò avvenga se la legge di revisione è approvata a maggioranza dei due terzi). Il testo è stato predisposto dal Comitato scientifico dell’associazione «Salviamo la Costituzione, aggiornarla non demolirla» (nata dal Comitato promotore del referendum costituzionale del 25-26 giugno 2006), composto da un centinaio di costituzionalisti tra i quali alcuni ex Presidenti della Corte costituzionale (Leopoldo Elia, Valerio Onida, Piero Alberto Capotosti, Riccardo Chieppa), e professori universitari (quali Pizzorusso, Cheli, Carlassare, Luciani, Ferrara, Azzariti, Bassanini, Ciarlo, Sorrentino, De Muro, Giorgis, Grosso, Pace, Balduzzi, Pinelli, Bettinelli, Stammati, Cerulli Irelli, Torchia, Balboni, Ridola).
L’attuale scansione delle maggioranze in relazione al referendum confermativo è mantenuta pur nella elevazione dei due quorum previsti per l’approvazione del disegno di legge di revisione costituzionale. D’altra parte la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera corrisponde a quella stabilita, come si è visto, nelle Costituzioni di importanti democrazie straniere, come quella americana e quella tedesca.
È evidente che elevare il quorum per la modifica di norme costituzionali aumenta il potere deliberativo delle minoranze o, quanto meno, delle minoranze più forti: ma è proprio questo l’obiettivo che si vuole raggiungere con il nostro disegno di legge costituzionale, evitando che la revisione rimanga nella disponibilità della maggioranza vittoriosa nell’ultima elezione. Questa modifica dell’articolo 138 renderà più difficile approvare le riforme necessarie? Si può rispondere che non è stato così in tante altre grandi democrazie (USA, Germania, eccetera), dove da sempre la Costituzione può essere cambiata solo con maggioranze bipartisan. E che l’impossibilità di procedere a colpi di maggioranza renderà più facile, non più difficile, cercare una larga intesa sulle riforme realmente necessarie, e dunque sentite da tutti (o quasi) come tali: la necessità di ottenere una maggioranza più larga toglierebbe infatti alle componenti della maggioranza di governo vincitrice delle elezioni l’illusione di potere imporre riforme di parte.
Il disegno di legge in oggetto ha un precedente nella proposta di legge costituzionale (atto Camera 2115), presentata alla Camera nella XII legislatura, per iniziativa degli onorevoli Bassanini ed Elia, cui si aggiunsero le firme di parlamentari molto autorevoli, quali gli onorevoli Napolitano, Mattarella, Veltroni e Fassino. Quella proposta non poté essere esaminata per lo scioglimento anticipato delle Camere decretato dal Presidente della Repubblica all’inizio del 1996.
Inoltre, il contenuto del disegno di legge costituzionale che si sottopone all’esame delle Camere è stato considerato di importanza prioritaria nel programma sottoposto, a norma di legge elettorale, al giudizio degli elettori dai partiti riuniti nella coalizione di centrosinistra guidata da Romano Prodi. Fa parte dunque del programma di governo della attuale maggioranza, ne costituisce il primo impegno programmatico. Ma anche molti esponenti della Casa delle Libertà hanno sottolineato, nel corso della campagna referendaria del 2006, la necessità di por fine alla stagione delle riforme costituzionali «di parte». L’obiettivo di garantire la stabilità della Costituzione, contro riforme «di parte», è del resto un’obiettivo di interesse comune e generale, naturalmente bipartisan.
È auspicabile che questa proposta consegua un ampio consenso anche se la sua finalità di essenziale garanzia per tutte le minoranze, attuali e future, giustificherebbe comunque la sua approvazione, anche in assenza di un generale consenso.
La Costituzione è, infatti, di tutti i cittadini e quindi non può essere nella disponibilità di una parte sola, ancorché pro tempore maggioritaria. E dovrebbe essere condiviso da tutti che porre in sicurezza la nostra Costituzione è un grande atto di pacificazione nazionale. Infatti non è sufficiente che le parti politiche, come è certamente desiderabile, accrescano la loro reciproca legittimazione: è necessario del pari che queste parti si riconoscano tutte nella Carta costituzionale e nell’impegno di conservarla integra, senza rinunciare a revisioni circondate da largo consenso (come avvenne del resto con l’amplissimo voto dei costituenti il 22 dicembre 1947).
Non c’è modo migliore di questo per ricordare il sessantennio della Costituzione e onorare i grandi meriti dei padri costituenti che ci hanno lasciato.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All’articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti».