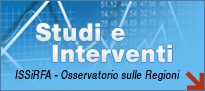Capitolo I - Il completamento del federalismo in Parlamento (Sofia Mannozzi)
Abstract
Questo capitolo del Rapporto ripercorre il dibattito parlamentare sul d.d.l. costituzionale di iniziativa governativa n. 2544, che prevede la modifica di buona parte delle disposizioni della Carta relative all’ordinamento della Repubblica. L’analisi ha come oggetto specifico l’iter legislativo che riguarda la transizione nella forma di stato e costituisce il proseguimento dello studio del law making effettuato nel capitolo del precedente Rapporto in cui è stata esaminata la fase del processo decisionale svoltasi nell’arena governativa, comprendendovi i due rapidi passaggi al Senato e alla Camera del d.d. l. sulla devolution.
La ricostruzione delle dinamiche politiche che possono spiegare le ragioni dell’iniziativa governativa e della tortuosità del percorso conclusosi con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge aveva fornito cospicui indizi circa l’influenza esercitata sulla tempistica e sugli esiti di questa fase del law making dai giochi multilivello, in cui la competizione inter-coalizionale si è intrecciata con quella infra-coalizionale secondo le logiche di funzionamento del “bipolarismo frammentato” che caratterizza la c.d. transizione italiana.
Dall’esame dei lavori delle Camere emerge che pure il processo decisionale in sede parlamentare, al di là delle differenze connesse alla strutturazione di questa arena, alle specifiche regole d’azione ivi vigenti, alla platea degli attori coinvolti, è stato dominato da analoghe logiche d’azione. Anche se per l’individuazione delle opzioni di politica istituzionale si è attinto dal repertorio di proposte di riforma avanzate dalla dottrina e dal dibattito politico nel decennio precedente, l’andamento complessivo del law making e le scelte effettuate sembrano in effetti spiegabili soprattutto alla luce delle contingenti strategie poste in essere dagli attori politici ai fini della competizione politica tra maggioranza e opposizione e tra le diverse componenti dei due schieramenti nella XIV legislatura. La prevalenza dei giochi di potere (powering) sulla ricerca di adeguate soluzioni ai problemi in discussione emerge piuttosto chiaramente dalla minuziosa ricostruzione della fase governativa e di quella parlamentare del processo decisionale, basata sia sui documenti ufficiali sia sulle testimonianza offerte dalla cronaca politica.
Il principale motivo d’interesse presentato nell’insieme dai due studi, a parte quello per gli “addetti ai lavori” ad una esposizione organica di tutte le posizioni espresse e delle successive modificazioni del disegno di legge, non è però costituito dalla conclusione che se ne può trarre, anche se argomentare, sia pure su un piano descrittivo, la pertinenza di una lettura del processo in chiave di politics può rappresentare un contributo di una certa utilità. Spesso infatti la letteratura sulle evoluzioni istituzionali sembra prestare il fianco all’accusa di soffrire di una sorta di distorsione prospettica, consistente nel privilegiare le spiegazioni dei cambiamenti in relazione alle strategie poste in essere dai partiti per acquisire vantaggi nella competizione politica, trascurando l’importanza della dimensione cognitiva e la pressione derivante dall’esigenza della classe politica di cercare soluzioni ai problemi di funzionalità istituzionale. Dall’indagine invece si ricavano significativi elementi per sostanziare l’ipotesi che in questo caso si possa considerare effettivamente secondaria l’influenza di tale tipo di fattori sul processo decisionale e scarso il loro impatto sugli esiti a cui si perviene.
Certamente alla base dell’accanimento con cui la classe politica ormai da molti anni si è infilata nel “tunnel delle riforme”, mettendosi nelle condizioni di dovere a un certo punto riuscire a porre in essere un qualche apprezzabile cambiamento per evitare il rischio di risultare complessivamente delegittimata, c’è l’idea, largamente condivisa nel discorso pubblico e continuamente alimentata da un riformismo declamatorio sparso a piene mani, che la “modernizzazione” della Costituzione costituisca il rimedio palingenetico per il cattivo funzionamento del sistema politico-istituzionale. Per altro è innegabile che, con l’introduzione del maggioritario sotto la spinta del movimento referendario, la questione dell’adeguamento dell’assetto istituzionale alle condizioni create dalle nuove regole elettorali sia stata concretamente avvertita come ineludibile da forze politiche protese a trovare legittimazione nella fondazione della “seconda Repubblica”, basata sulla democrazia dell’alternanza. Quanto alla trasformazione della forma di stato in senso regionalistico, è evidente come il tema, per un insieme di motivi di ordine politico e funzionale, negli anni novanta abbia conquistato un posto di primo piano nell’agenda politica, tanto da essere in parte realizzata, portando ad innovazioni che nel merito hanno costituito un laboratorio per i cambiamenti prospettati anche per la forma di governo e nel metodo hanno rotto il tabù della necessità di ampie convergenze sulle riforme costituzionali, radicato nell’esperienza storica del periodo costituente del dopoguerra. Inoltre alcune delle idee elaborate nel periodo di gestazione infruttuosa delle riforme, in particolare quelle affermatesi nei lavori della Commissione bilaterale presieduta da D’Alema, sono state riprese dalle diverse proposte avanzate ed in parte anche accolte nel law making in esame. Ma i motivo per cui certe idee non altre sono state recepite, le ragioni che spiegano perché sono state ibridate e assemblate senza curasi della congruenza complessiva del testo sono da ricercare nelle logiche d’azione che caratterizzano il bipolarismo frammentato in cui è rimasta incagliata la transizione italiana. Sarebbe inoltre difficile capire come sia stato possibile per la CdL riuscire nell’impresa di portare a termine l’iter di riforma costituzionale, nonostante il contrasto tra gli interessi territoriali rappresentati dai partiti che compongano la coalizione e la distanza tra i loro riferimenti ideologici nello specifico ambito della forma di stato, se non facendo riferimento alle dinamiche della “stabilità senza coesione” dei governi di questa fase e alle particolari connotazioni assunte da quello della XIV legislatura, per effetto della presenza di un Presidente del consiglio dotato di ingenti risorse extraistituzionali e di un partito pivot che ha giocato tutte le sue carte sulla devolution. Le forti discrepanze tra le risposte date in termini di policy e gli obiettivi dichiarati da entrambi gli schieramenti di volere “chiudere la transizione” e “completare il federalismo” sono interpretabili, infatti, solo sul piano della politics, e più specificatamente in relazione alle modalità con cui la strutturazione della competizione politica si è adattata allo schema bipolare in un sistema caratterizzato da una persistente tendenza alla frammentazione partitica.
Il contributo più interessante fornito dall’analisi particolareggiata del processo decisionale non consiste quindi tanto nel fornire un supporto empirico a conferma della diffusa e generica percezione della prevalenza dei giochi di potere nella produzione di cambiamenti istituzionali, quanto nell’offrire elementi utili ad esplorare il campo, poco arato dalla dottrina, del funzionamento del law making nelle dinamiche del bipolarismo imperfetto, a cui ha dato luogo l’introduzione di un sistema elettorale di impronta maggioritaria privo di efficaci disincentivi alla frammentazione partitica, per altro invece incoraggiata dai regolamenti parlamentari e dai meccanismi di finanziamento dei partiti.
In queste condizioni la democrazia dell’alternanza è riuscita ad affermarsi a prezzo della creazione di coalizioni spurie sul piano programmatico e frammentate sotto il profilo organizzativo, in cui ciascun partner dispone di un forte potere di veto, in relazione alla necessità dei poli di essere quanto più possibile inclusivi, per aumentare le possibilità di affermazione nella competizione bipolare, e in ragione della minaccia rappresentata da eventuali defezioni per la stabilità dei governi posti in essere dalla compagine vincente. Se il principale collante tra forze politiche eterogenee è costituito dalla necessità di allearsi per conquistare e conservare il potere, alla sostanziale mancanza di coesione si supplisce puntando sul ricorso esasperato alla logica avversariale, che però impedisce alle formazioni maggiori dei due schieramenti di tentare di accordarsi su regole tendenti alla semplificazione del sistema politico in senso più compiutamente bipolare. D’altra parte le possibilità di evoluzione in questo senso è fortemente limitata dal fatto che i partiti si sono adattati al modello bipolare, attuando però una sorta di “riproporzionalizzazione del maggioritario” applicata ai criteri usati per la spartizione dei collegi tra gli alleati. Il riemergere della logica proporzionale non investe solo le fasi pre-elettorali, ma si manifesta anche nelle continue rinegoziazioni tra i partner per accrescere le rispettive sfere d’influenza sulla base di variazioni delle percentuali di consenso, desunte dai sondaggi e dalla lettura in chiave nazionale dei risultati di tutte le consultazioni popolari che si tengono tra un’elezione politica e l’altra, indipendentemente dal fatto che si tratti di confronti elettorali parziali e/o locali e dalla diversità del sistema elettorale in base al quale si svolgono. Si sono così create le condizioni per perpetuare il carattere spurio delle coalizioni, dato che le singole forze politiche sono incentivate a marcare i tratti distintivi al fine della conservazione del consenso del loro elettorato e a cercare di fare prevalere le proprie preferenze per accrescere la capacità di attrarre voti anche a spese dei partner.
Lo studio del law making nel caso in esame permette di vedere tutti questi meccanismi in azione, nell’ambito di un processo di revisione costituzionale per il quale non è stato creata una sede ad hoc, distinta da quelle dove si svolgono le ordinarie attività del governo e del parlamento. Questa scelta, giustificata dalla deludente esperienza delle Commissioni bilaterali, ha favorito la riduzione della modifica dell’ordinamento a una delle molteplici poste in gioco nell’agenda politica, contribuendo ad indirizzare le strategie delle forze politiche più al perseguimento di convenienze contingenti che all’acquisizione di futuri vantaggi nella riscrittura delle regole della competizione politica.