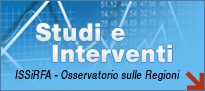Introduzione (Antonio D'Atena)
Come conferma il volume che si licenzia, il genere letterario “rapporto annuale” pone alcuni, non semplici, problemi di metodo. Il maggiore dei quali si collega all’aggettivo che lo qualifica. Per la ragione che, mentre, per certe parti, il rigoroso rispetto dell’anno di riferimento è agevole – se non, almeno da un punto di vista pratico, necessario –, per altre parti, risulta, non solo, difficile, ma anche – in ultima analisi – inopportuno. Infatti, quanto più la riflessione cerca di andare oltre la – ovviamente, imprescindibile – esposizione dei dati, per addentrarsi sul terreno delle interpretazioni, tanto più si accentua la tensione tra i tempi di sviluppo – si sarebbe tentati di dire: il respiro – dei processi rappresentati e la cadenza annuale della pubblicazione.
Di qui, l’inevitabilità di deroghe, più o meno circoscritte, rispetto ai confini temporali che istituzionalmente un rapporto “annuale” deve darsi. Le quali consentono di non forzare innaturalmente, nella gabbia dell’anno, oggetti refrattari a tale costrizione.
Nell’elaborazione del presente Rapporto – il terzo della serie – questa esigenza si è fatta sentire in modo particolarmente pressante.
Infatti, alla distanza di tre anni dall’entrata in vigore della riforma del titolo V Cost., le esperienze accumulate consentono di avanzare valutazioni d’insieme che in precedenza sarebbero state premature. Valutazioni, rese, in qualche misura, ineludibili dalla conclusione della legislatura regionale, avvenuta – com’è noto – nell’aprile del 2005. È, infatti, evidente che il rinnovo degli organi di governo delle Regioni, cambiando uno degli attori (il principale, nella prospettiva di un Rapporto dedicato allo stato del regionalismo), segna un’oggettiva discontinuità nel fluire cronologico degli eventi. E rende, quindi, non arbitraria una periodizzazione centrata su esso. Tanto più quando – come nella specie – il risultato elettorale modifica radicalmente l’assetto delle maggioranze.
È questa la ragione per la quale il Terzo Rapporto sullo stato del regionalismo in Italia costituisce una sorta di numero speciale. Nel quale, ai capitoli dedicati all’anno di riferimento – il 2004 –, si affiancano capitoli che allargano l’obiettivo sull’intera legislatura (talora aspirando a fornire – con le ovvie cautele del caso – gli elementi di un primo bilancio). A questo – tra l’altro – si deve il considerevole aumento della sua mole.
La complessità del quadro che emerge dall’insieme dei capitoli che seguono rende assolutamente sconsigliabile il tentativo di estrapolare da essi il senso complessivo dei processi in atto.
Alcune risultanze meritano, tuttavia, di essere sottolineate.
Le rilevazioni contenute nel Rapporto confermano, anzitutto, che la riforma costituzionale realizzata tra il 1999 ed il 2001 è una riforma “difficile”: difficile, per la radicale novità di alcune scelte; difficile, per la presenza di un notevole numero di nodi non sciolti; difficile, infine, per una qualità tecnica complessivamente non entusiasmante. Di tale “difficoltà” costituisce eloquente conferma l’impressionante crescita del contenzioso costituzionale ed il conseguente aumento delle decisioni ad esso dedicate dalla Corte. Che costituiscono ormai più del 50% delle decisioni adottate dal Collegio.
Il secondo elemento che emerge dai dati raccolti è rappresentato dalla centralità del ruolo assunto dal giudice della costituzionalità. La cui giurisprudenza si sta rivelando il principale fattore di attuazione della costituzione novellata. Il dato, se, per un verso, può ricondursi alla difficoltà di cui si è appena detto, per altro verso, si collega ai ritardi che, su questo terreno, sta accumulando il legislatore ordinario. Ritardi tanto più rilevanti, se si considera l’enorme spazio ad esso riservato dalla nuova disciplina costituzionale (che non di rado si esaurisce nel rinvio alla legge). Il caso della finanza è – a questo riguardo – emblematico.
Il terzo elemento che emerge dal Rapporto è costituito dalla presenza di viscosità, anche culturali, le quali mantengono sotto il segno della continuità dinamiche, che – stando alla lettera della Costituzione novellata – si sarebbero potute sviluppare in termini più fortemente innovativi. Questo tratto trova le sue manifestazioni più vistose a livello statale. Il legislatore centrale, infatti, stenta a metabolizzare la portata del rovesciamento dell’enumerazione delle competenze. Ma il fenomeno è riscontrabile anche a livello sub-statale. È, ad esempio, significativo che le Regioni, pur esercitando la propria competenza residuale, siano riluttanti ad occupare con decisione le materie “nuove”, preferendo concentrare il proprio impegno legislativo sul terreno, sperimentato, delle competenze di cui erano già titolari. A tale viscosita è probabilmente da ricondurre la circostanza che i legislatori regionali si siano finora astenuti dall’introdurre, nei rispettivi sistemi amministrativi, quelle differenziazioni che la riforma avrebbe consentito (e consentirebbe).
Il quarto elemento che il Rapporto evidenzia è rappresentato dal consolidamento della vocazione funzionale delle Regioni. La cui azione si concentra soprattutto su tre aree materiali: quella dei servizi sociali, quella dello sviluppo economico e l’area del governo del territorio (in essa comprendendo gli interventi in materia ambientale). È difficile dire, se, al di sotto di questa vocazione comune, stiano emergendo delle propensioni differenziate su base geografica. In questo senso potrebbero deporre alcuni indicatori quantitativi. Ci si riferisce al fatto che, mentre nelle Regioni meridionali l’impegno legislativo prevalente è nel macrosettore dei “servizi alla persona ed alla comunità”, in quelle settentrionali la prevalenza è accordata al macrosettore “sviluppo economico e attività produttive”. Allo stato, tuttavia, gli elementi disponibili non consentono di costruire sul dato ipotesi interpretative dotate di sufficiente affidabilità.
Ma le vicende su cui il Rapporto riflette non parlano soltanto di Regioni. Parlano anche di Stato: e – si badi – non solo di Stato nei suoi rapporti con le Regioni (e, quindi, di forma di Stato), ma anche di Stato in sé considerato (e, quindi di forma di governo). In proposito, illuminante è il capitolo dedicato all’elaborazione parlamentare della riforma della riforma. Il quale, con riferimento al delicatissimo ambito della revisione costituzionale, offre un eloquente spaccato dei peculiari caratteri che è venuto assumendo il bipolarismo affermatosi nel nostro Paese: il bipolarismo di coalizione. E delle torsioni che esso impone ai processi di decisione politica.
Antonio D’Atena