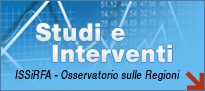Ricorso n. 101 del 17 dicembre 2013 (Regione Veneto)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 dicembre 2013 (della Regione Veneto).
(GU n. 2 del 8.1.2014)
Ricorso proposto dalla Regione Veneto (C.F. …), in
persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Luca
Zaia (C.F. …), a cio' autorizzato con D.G.R. n. 2183
del 3 dicembre 2013 allegata, rappresentato e difeso, giusta mandato
a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente,
dagli avv.ti Ezio Zanon (C.F. …) Coordinatore
dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo (C.F. …)
della Direzione regionale Affari Legislativi e Luigi Manzi (C.F.
…) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo
studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5 (per eventuali
comunicazioni: fax …, posta elettronica certificata
...
Nei confronti del Presidente pro tempore del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91 recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione
e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali.» nel testo
risultante per effetto della conversione della legge 7 ottobre 2013,
n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre
2013.
F a t t o
Con la legge 7 ottobre 2013, n. 112, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2013, e' stato convertito in legge il
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti
per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attivita' culturali.».
In particolare l'articolo 4-bis del decreto-legge citato e' stato
introdotto in sede di conversione, operata con la legge n. 112 del
2013, ed aggiunge il comma 1-bis al comma 1 dell'articolo 52 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il c.d. Codice
dei beni culturali e del paesaggio", assegnando alle Direzioni
regionali per i beni culturali e paesaggistici, «sentiti gli enti
locali», il compito di adottare «apposite determinazioni volte a
vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche
esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le firme di uso
pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le
attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la
necessita', l'uso individuale della aree pubbliche di pregio a
seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di
suolo pubblico.».
Tale intervento sarebbe stato motivato dal legislatore statale in
ragione della dichiarata esigenza di «contrastare l'esercizio, nelle
aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico,
artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali ed artigiane in
forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita'
non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale».
La rigida disposizione si fonderebbe, pertanto, sulla necessita' di
«assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri
immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici
particolarmente rilevanti.».
Infine, l'ambito territoriale della disposizione citata si
estenderebbe, secondo il dettato normativo, anche alle «aree
contermini» ai complessi monumentali ed agli altri immobili del
demanio culturale, mentre l'ambito oggettivo potrebbe riguardare
anche «qualsiasi altra attivita' non compatibile» senza alcuna
indicazione, seppur minima, di criteri o parametri di riferimento
vincolanti il potere discrezionale delle Direzioni regionali per i
beni culturali e del paesaggio e le Sovrintendenze chiamate ad
attuarla.
D i r i t t o
La Regione del Veneto ritiene che l'articolo 4-bis del
decreto-legge n. 91 del 2013, nel testo risultante dalla conversione
operata con la legge n. 112 del 2013, presenti taluni profili di
lesivita' e conflitto con le prerogative garantite all'ente
territoriale dalla Carta fondamentale, per i motivi di seguito
partitamente indicati.
Violazione degli articoli 3 e 97, della Costituzione.
Innanzitutto, per cio' che si presume essere un evidente e non
ancora sanato vizio di tecnica legislativa, la formulazione
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 42/2004, come modificato
dal decreto-legge n. 91/2013 nel testo convertito in legge, presenta
un doppio comma 1-bis e, correlativamente, due disposizioni
completamente diverse, in violazione del principio di certezza del
diritto.
Infatti, il primo comma 1-bis, introdotto dall'articolo 2-bis
della legge di conversione, recita: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano
altresi' i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono
attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali
tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identita' culturale
collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo
articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e
salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di
cui all'articolo 41 della Costituzione.».
La novella in argomento pur avendo imposto, altresi', la doverosa
integrazione della rubrica dell'articolo di cui si tratta con
l'inserimento delle parole «e nei locali storici tradizionali», ha
tuttavia lasciato inalterata la competenza, di cui al comma 1,
assegnata ai comuni circa l'individuazione delle aree pubbliche nelle
quali imporre il divieto o limitazioni all'esercizio del commercio,
per preminenti ragioni di tutela di beni o siti di valenza
archeologica, storica, artistica e paesaggistica. Correlativamente,
peraltro, per effetto del comma 1-bis, attribuisce ai comuni medesimi
anche la potesta' di individuare i locali da destinare ad attivita'
di artigianato tradizionale ed altre attivita' commerciali
tradizionali, con finalita' tutt'altro che impeditive, ma anzi
promozionali, trattandosi di forme di espressione dell'identita'
culturale collettiva, attuata in conformita' ai precetti di rango
costituzionale ed ai consueti principi di derivazione comunitaria,
formalizzati, per giunta, in accordi internazionali.
La suddescritta armonia legislativa, pero', risulta completamente
stravolta proprio a causa della medesima legge di conversione n.
112/2013, atteso che l'articolo 4-bis introduce un ulteriore comma
1-bis nell'art. 52 del d.lgs. n. 42/2004, in assenza del necessario,
basilare coordinamento normativo e con un testo di contenuto
diametralmente opposto a quello immediatamente precedente.
Lungi dal censurare superficialmente eventuali accadimenti di
frettolosa scrittura dei testi normativi, che per cio' stesso
comunque sono facilmente foderi di possibili degenerazioni, quello
che il patrocinio regionale sottopone all'esame di codesto Ecc.mo
Collegio la perdurante inerzia del legislatore statale e la
singolarita' del fenomeno in esame, che incide profondamente nella
certezza del diritto.
Nell'attuale fattispecie, infatti, si registra una sostanziale
differenza rispetto ad altri episodi consimili gia' verificatisi nel
passato, per i quali l'intervento del legislatore statale era stato
diligentemente pronto, oppure non si ponevano rilevanti discrasie
ordinamentali, come nel caso dell'articolo 21-quinquies rubricato
«Revoca del provvedimento» contenuto nella piu' volte modificata
legge 7 agosto 1990, n. 241, nel quale era stata rispettata la
sequenza numerica delle disposizioni, ma il contenuto del comma 1-bis
risultava identico al comma 1-ter. Questo perche' tale ultimo comma
era stato aggiunto dal comma 1-bis dell'art. 12, del D.L. 25 giugno
2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione, per poi essere abrogato, a decorrere dal 6 giugno 2012,
dal comma 1 dell'art. 62 e dalla Tabella A allegata al D.L. 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35.
In riferimento alla novella operata dall'art. 4-bis di cui alla
legge n. 112/2013, il testo dell'art. 52 del d.lgs. n. 42/2004 che ne
risulta presenta notevoli fratture logiche ed ordinamentali e conduce
ad opzioni ermeneutiche differenti che si risolvono in altrettanti
dubbi applicativi e, inevitabilmente, si riflettono sul l'operato
delle pubbliche amministrazioni, siano essi i comuni o gli organi
periferici del Ministero per i beni culturali, con effetti
significativamente pregiudizievoli per le competenze, variamente
declinate, che, particolarmente in materia di commercio e turismo,
intaccano anche le prerogative normative ed amministrative regionali
salvaguardate dalla Costituzione.
Ed invero, nei primi due commi dell'art. 52 predetto, e cioe' il
comma 1, ed il comma 1-bis introdotto dall'articolo 2-bis della legge
n. 112/2013, l'unico ente effettivamente tributario ad esercitare la
competenza amministrativa in materia appare il comune, atteso che
alle Sovrintendenze residuano mere funzioni consultive. Per converso,
il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 4-bis della legge n. 112 del
2013, sovverte le posizioni dei soggetti istituzionali gia'
individuati, assegnando una funzione di amministrazione attiva alle
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici ed alle
Sovrintendenze, relegando contestualmente i comuni in un ruolo di
interlocutore con funzioni consultive obbligatorie ma non vincolanti.
Appare cosi' difficilissimo, se non impossibile, attesa la
distanza dicotomica rinvenibile nelle due norme, tentare di
armonizzare i contenuti precettivi propri delle disposizioni dei due
commi «1-bis», peraltro inseriti dalla stessa legge di conversione.
Infatti, mentre il comma 1-bis di cui all'articolo 2-bis della
legge n. 112/2013 incentiva e promuove le attivita' artigianali e
commerciali tradizionali, in quanto espressione di identita'
culturale collettiva contemplate addirittura da convenzioni
internazionali, per converso, il comma 1-bis di cui all'articolo
4-bis della legge n. 112 del 2013 vieta gli usi da ritenere
incompatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione dei beni
culturali, senza alcuna distinzione od eccezione.
A rigore, quindi, l'articolo 52 del decreto legislativo n.
42/2004, nell'attuale formulazione, al comma 1 obbliga
l'amministrazione comunale ad individuare le aree di particolare
valore culturale in cui imporre vincoli e condizioni limitative
all'esercizio del commercio; al comma 1-bis, introdotto dall'articolo
2-bis della legge n. 112/2013, obbliga il comune medesimo ad
individuare i locali storici tradizionali in cui promuovere
l'artigianato e le attivita' commerciali simbolo dell'identita'
culturale; infine, al comma 1-bis, introdotto dall'art. 4-bis della
legge n. 112/2013, assegna alle Direzioni regionali per i beni
culturali ed alle Sovrintendenze, il potere di adottare ulteriori
provvedimenti interdittivi e regolatori che, nella prima ipotesi, si
aggiungono a quelli comunali e, nella seconda ipotesi, si
sostituiscono a qualsiasi intervento regolatorio autorizzatorio o
concessorio, neutralizzando anche gli effetti promozionali
dell'artigianato e del commercio tradizionale locale. Da cio'
l'assoluta irragionevolezza dell'intervento normativo attuato in
spregio all'articolo 3 della Costituzione.
Appare cosi' utile, traendo lo spunto dall'intervento legislativo
in esame, l'ultimo in ordine di tempo, ripercorrere brevemente
l'excursus ordinamentale che ha interessato le diverse competenze
ripartite tra comuni ed organi statali in subiecta materia, per
effetto di successivi ritocchi normativi.
Risalendo al d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, recante la nuova
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, tuttora
in vigore, si osserva che l'art. 10 prevede, tra l'altro,
relativamente ai «centri storici, aree o edifici aventi valore
storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di
maggiori poteri ai comuni», per cio' che concerne la «localizzazione»
ed «apertura degli esercizi di vendita», soprattutto «al fine di
rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni
territoriali in ordine alla viabilita', alla mobilita' dei
consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure
di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario». Inoltre, il
successivo articolo 28, dello stesso decreto, prevede espressamente
che per la regolamentazione dell'esercizio delle attivita' sulle aree
pubbliche, mediante posteggio o in forma itinerante, i comuni debbano
adottare un'apposita deliberazione che individui le aree culturali
nelle quali l'esercizio del commercio e' vietato o sottoposto a
condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle medesime.
Di poco successivo al decreto considerato e' il d.lgs. 29 ottobre
1999, n. 490, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, il cui articolo 53,
rubricato «Esercizio del commercio in aree di valore culturale»,
assegnava al Sovrintendente il potere di individuare aree di pregio
culturale in cui l'esercizio del commercio fosse vietato, ovvero
sottoposto a particolari limitazioni previo proprio nulla osta. Per
inciso, va precisato che una disposizione di contenuto analogo, gia'
presente nella legge 28 marzo 1991, n. 112, nella parte finalizzata
alla disciplina del commercio nelle aree pubbliche, era stata poi
abrogata proprio dal d.lgs. n. 114/1998, secondo un meccanismo di
rimbalzi disciplinatori quantomeno singolare.
Successivamente, il nuovo ed attuale decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, in ossequio, presumibilmente, anche alla nota
riforma della Costituzione, per quanto specificamente attiene il
novellato art. 114 della medesima, con l'art. 52 riattribuisce la
competenza in materia ai comuni, che, proprio mediante quelle
«deliberazioni previste dalla normativa in materia di rifirma della
disciplina relativa al settore del commercio» di cui al d.lgs. n.
114/1998, sentito il Sovrintendente, devono individuare le aree
pubbliche nelle quali vietare o sottoporre a particolari condizioni
l'esercizio del commercio.
Ed appunto l'art. 52 in argomento ha generato due diverse
direttive emanate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali.
La prima di queste, datata 9 novembre 2007 ed indirizzata alle
Direzioni regionali e alle Sovrintendenze, sostanzialmente traeva
fondamento dalla «situazione di crescente e grave degrado urbano a
causa della crescita del fenomeno del commercio ambulante», e,
conseguentemente, invitava i destinatari ad attivarsi per garantire
la puntuale attuazione delle disposizioni in materia di beni
culturali, in sintonia con le amministrazioni comunali, allo scopo di
conseguire il piu' efficace contemperamento degli interessi
coinvolti.
Ma tale direttiva, peraltro riferita esclusivamente al possibile
degrado cagionato dalla diffusione incontrollata del commercio
ambulante, e' stata recentemente replicata in una seconda direttiva,
datata 10 ottobre 2012, anch'essa ovviamente destinata soltanto agli
organi statali periferici competenti in materia di beni culturali
che, inopinatamente, ha straordinariamente esteso i confini
dell'azione amministrativa rimessa agli organi statali dal contesto
legislativo supra delineato. Per un verso, infatti, si e' ampliato
l'ambito applicativo territoriale della direttiva, laddove le arre
aree pubbliche oggetto di tutela perche' di particolare valore
archeologico, storico, artistico e paesaggistico ove sono presenti i
complessi monumentali o gli altri immobili del demanio culturale, si
sono dilatate sino a ricomprendere le aree ad essi contermini; per
altro verso, e' stato indebitamente allargato l'oggetto
dell'intervento statale che, a termini della Direttiva de qua,
potrebbe colpire in modo indifferenziato ogni attivita' commerciale
ed artigianale esercitata in forma ambulante o su posteggio, nonche'
qualsiasi altra attivita', innominata e generica, laddove sia
ritenuta non compatibile, secondo canoni e parametri peraltro ignoti,
con presunte e generiche esigenze di tutela.
In proposito, si richiama l'attenzione di codesta Ecc.ma Corte
proprio sulla circostanza che il contenuto della Direttiva del 2012
che, si ribadisce, costituisce una mera circolare interna diretta
agli uffici gerarchicamente subordinati al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, e' stata trasfuso nell'articolo 4-bis della
legge n. 112/2013, odiernamente censurato.
Evidentemente siffatta operazione, per quanto poco attenta e poco
meditata, di legificazione dei contenuti di un documento destinato
alle amministrazioni periferiche del dicastero, integra
l'indispensabile presupposto normativo preordinato alla costruzione
dei requisiti di legittimita' della Direttiva stessa, che,
altrimenti, sarebbe addirittura incompatibile con la Carta
Fondamentale, atteso che l'articolo 23 della Costituzione statuisce
il principio per il quale «nessuna prestazione personale o
patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge». E tale
principio e' a fortiori invocabile laddove si tratti di interventi
con effetti caducatori di provvedimenti rilasciati da altre
amministrazioni nel legittimo esercizio delle proprie potesta'
regolamentari e, nel caso delle Regioni, con effetti immediatamente
ricadenti sull'efficacia delle disposizioni normative eventualmente
emanate, senza contare il grave pregiudizio arrecato alle posizioni
giuridiche soggettive proprie degli operatori economici.
In realta', cio' che rileva nella fattispecie in esame e' che
nella direttiva 10 ottobre 2012 si denuncia, indirettamente,
l'assenza totale di vigilanza da parte degli organi periferici
sull'attuazione dei provvedimenti comunali. Infatti, per un verso il
Ministero impone una ricognizione dei provvedimenti di vincolo gia'
emanati, ivi compresi quelli adottati dai comuni proprio ai sensi
dell'articolo 52 del d.lgs. n. 42/2004, e, per altro verso, pare
attribuire agli uffici statali medesimi una funzione di garanzia
circa l'effettivita' della vigilanza posta in essere in ordine al
rispetto delle prescrizioni impartite.
Il particolare fenomeno di jus superveniens su descritto, quindi,
disgiunto dal necessario, conseguente, riordino ordinamentale ed
istituzionale, ha creato un affastellamento normativo, fonte di grave
incertezza giuridica, precludendo, altresi', il ricorso a quei
meccanismi di collaborazione e concertazione posti a presidio della
regolazione di ambiti connotati da un rilevante intreccio di una
pluralita' di interessi pubblici.
L'irragionevolezza che ne deriva e fonda il vizio di legittimita'
di cui all'articolo 3 della Costituzione, e' indiscutibile e
travalica il mero vizio di tecnica legislativa ascrivibile alla
scorretta progressione numerica che evidenzia ancora, allo scadere
dei termini per l'impugnazione del D.L. n. 91/2013, come convertito,
la coesistenza di due commi «1-bis», introdotti da due articoli
diversi della stessa legge di conversione inseriti quasi
simultaneamente nel medesimo articolo 52 del d.lgs. n. 42/2004. Ma,
ad avviso dello scrivente patrocinio, tale incertezza incide
soprattutto sul corretto esercizio della potesta' legislativa
regionale che, specialmente in contesti di potesta' normativa
residuale, quale certamente e' quello relativo al commercio, subisce
restrizioni cosi' rilevanti da risultarne svuotata.
Per quanto specificamente attiene la rilevanza del rispetto del
principio di certezza del diritto, nonche' sulle ricadute lesive che
la violazione di tale principio produce in ordine alle attribuzioni
legislative regionali, ovvero sulle relazioni intercorrenti tra il
vulnus apportato all'art. 3 della Costituzione e la lesione delle
prerogative tutelate ed assicurate dall'art. 117 della medesima, si
richiama quanto riaffermato da codesta Ecc.ma Corte costituzionale
anche nella recente decisione n. 200 del 2012 in relazione
all'articolo 3 del D.L. n. 138/2011. In tale norma, infatti, in nome
del principio di liberalizzazione delle attivita' economiche, il
legislatore statale aveva operato, in assenza di qualsiasi
direttrice, la generalizzata soppressione di disposizioni reputate
genericamente incompatibili con tale principio.
In quella pronuncia e' stato cosi' sancito che «l'automaticita'
dell'abrogazione, unita all'indeterminatezza della sua portata, rende
impraticabile l'interpretazione conforme a Costituzione, di talche'
risulta impossibile circoscrivere sul piano interpretativo gli
effetti della disposizione impugnata ai soli ambiti di competenza
statale.
Infine, poiche' la previsione censurata dispone la soppressione
per incompatibilita', senza individuare puntualmente quali normative
risultino abrogate, essa pone le Regioni in una condizione di
obiettiva incertezza, nella misura in cui queste debbano adeguare le
loro normative ai mutamenti dell'ordinamento statale. Infatti, le
singole Regioni, stando alla norma censurata, dovrebbero ricostruire
se le singole disposizioni statali, che presentano profili per esse
rilevanti, risultino ancora in vigore a seguito degli effetti
dell'art. 3, comma 3, primo periodo. La valutazione sulla perdurante
vigenza di normative statali incidenti su ambiti di competenza
regionale spetterebbe a ciascun legislatore regionale, e potrebbe
dare esiti disomogenei, se non addirittura divergenti. Una tale
prospettiva determinerebbe ambiguita', incoerenza e opacita' su quale
sia la regolazione vigente per le varie attivita' economiche, che
potrebbe inoltre variare da Regione a Regione, con ricadute dannose
anche per gli operatori economici.
Di conseguenza, l'art. 3, comma 3, appare viziato sotto il
profilo della ragionevolezza, determinando una violazione che si
ripercuote sull'autonomia legislativa regionale garantita dall'art.
117 Cost., perche', anziche' favorire la tutela della concorrenza,
finisce per ostacolarla, ingenerando grave incertezza fra i
legislatori regionali e fra gli operatori economici.».
Ad avviso della difesa regionale, la situazione gia' vagliata da
codesta Ecc.ma Corte non risulta sostanzialmente difforme rispetto
all'altra odiernamente interloquita, in quanto l'art. 4-bis non
delimita correttamente l'ambito applicativo della disposizione, ne'
per quanto si riferisce all'individuazione delle «aree contermini» ai
complessi monumentali ed agli altri immobili del demanio culturale;
ne' con riferimento all'identificabilita' certa e pacifica di
«qualsiasi altra attivita' non compatibile». Per di piu', la
disposizione non offre neppure canoni e parametri omogenei che
consentano alle Direzioni regionali per i beni culturali ed alle
Sovrintendenze l'esercizio uniforme del potere discrezionale di cui
si ritrovano ad essere tributari e che, in assenza dei necessari
criteri regolativi, risulta talmente ampio ed incondizionato da
generare il sospetto che sia suscettibile di generare abusi, in
violazione dell'articolo 97 della Costituzione.
L'illegittimita' di un simile assetto amministrativo, privo di
limiti e contemperamenti, e' gia' stata stigmatizzata da codesta
Ecc.ma Corte nella sentenza n. 115 del 2011 in relazione alla
facolta' riconosciuta ai sindaci di adottare, in qualita' di
ufficiali di governo, ordinanze «anche» non contingibili ed urgenti.
In quell'occasione, codesto Ecc.mo Collegio non ha mancato di
osservare che: «si deve rilevare la violazione di legge dell'articolo
97 della Cost., che istituisce anch'esso una riserva di legge
relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialita' della pubblica
amministrazione, la quale soltanto puo' dare attuazione, anche con
determinazioni ulteriori, a quanto in via generale e' previsto dalla
legge. Tale limite e' posto a garanzia dei cittadini, che trovano
protezione rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro
legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile
in sede di controllo giurisdizionale.» (...) «L'assenza di limiti,
che non siano genericamente finalistici, non consente pertanto che
l'imparzialita' dell'agire amministrativo trovi, in via generale e
preventiva, fondamento effettivo, ancorche' non dettagliato, nella
legge.».
Gli assunti pronunciati da codesta Ecc. Corte dispiegano
particolarissima valenza proprio in relazione alla potesta'
inibitoria prepotentemente riconosciuta alle Direzioni regionali del
Ministero ed alle Sovrintendenze in ordine ad attivita' commerciali o
artigianali, che pure erano state preventivamente autorizzate
dall'autorita' competente in osservanza della legge in vigore in quel
momento.
Alla discrasia normativa che ne consegue non puo' reputarsi
estraneo il disallineamento nelle fonti del diritto che l'ha
cagionata. Infatti, la sostanziale identita' di contenuto tra il
comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 42 del 2004,
come introdotto dall'articolo 4-bis della legge n. 112 del 2013, e la
direttiva del Ministero datata 10 ottobre 2012, puo' al piu' dare
ragione di un intervento redazionale approssimativo, ma pone, nel
contempo, la questione della compatibilita' delle previsioni della
direttiva con il principio di legalita' e, quindi, della conformita'
della norma, successivamente posta a fondamento e legittimazione
della direttiva, con i precetti costituzionali.
Dunque, la cristallizzazione normativa del contenuto di una
circolare interna, operata mediante l'introduzione nel tessuto
ordinamentale dell'articolo 4-bis del D.L. n. 91/2013, come
convertito, laddove sottende e genera la previsione di potesta' sia
legislative che amministrative in capo ad organi di estrazione
statale, produce necessariamente violazioni dei precetti
costituzionali, qualora la novella incida in ambiti nei quali
sussistono consolidate attribuzioni legislative regionali, a potesta'
concorrente o residuale, ovvero competenze amministrative, anche,
sicuramente regionali.
Violazione degli articoli 117 commi terzo e quarto e 118 della
Costituzione.
Premesso quanto suesposto, perche' indefettibilmente prodromico
all'analitica trattazione delle numerose norme contenute nella
disposizione censurata, la difesa regionale contesta radicalmente le
finalita' apoditticamente enunciate dal legislatore statale nel
testo, nel tentativo, a dire il vero velleitario, di ricondurre le
previsioni dell'articolo impugnato nell'alveo dell'articolo 117 della
Costituzione, quale legittima espressione di una competenza
legislativa esclusiva statale.
Innanzitutto, nell'incipit della disposizione medesima e'
enunciato il proposito di «contrastare l'esercizio» (...) «delle
attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su
posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile» allo
scopo dichiarato di «assicurare il decoro dei complessi monumentali e
degli altri immobili del demanio culturale (...) nonche' delle aree a
essi contermini.».
Orbene tale finalita', piu' che ad esigenze di tutela del
patrimonio culturale riservata allo Stato dall'art. 117, comma
secondo lettera s) della Costituzione, pare piuttosto ascrivibile
alla c.d. valorizzazione dei beni culturali di cui al comma terzo
della Costituzione, e l'assunto trova, oltretutto, puntuale conferma
proprio nel testo della disposizione in esame che le menziona
espressamente.
In realta', ad avviso dello scrivente patrocinio, per
circoscrivere correttamente l'ambito materiale di cui si tratta,
enucleandolo in ragione della competenza funzionale esercitabile in
relazione all'amplissima categoria costituita dal patrimonio
culturale, appare utile richiamare la sentenza n. 212 del 2006, nella
quale codesta Ecc.ma Corte ha chiaramente delineato l'elemento
qualificante il profilo sussumibile nel termine «valorizzazione»,
argomentando nel contesto dei beni ambientali. Nello specifico, e'
stata individuata la competenza regionale, ai sensi dell'articolo
117, comma terzo della Costituzione, in tema di valorizzazione del
patrimonio tartuficolo, quale risorsa ambientale della Regione
suscettibile di razionale sfruttamento.
Conseguentemente, senza alcun diaframma logico od ermeneutico, se
si considera che il precetto costituzionale di cui all'articolo 117,
comma terzo, della Costituzione pone la «valorizzazione dei beni
ambientali» in endiadi con la «valorizzazione dei beni culturali»,
appare ragionevole supporre che rappresenti un criterio distintivo
certo, ai fini della demarcazione della competenza in materia, la
suscettibilita' del patrimonio culturale ad essere oggetto di un
razionale sfruttamento, anche attuato mediante le attivita'
turistiche, commerciali ed artigianali contigue a tale patrimonio ed
indotte dall'afflusso turistico che in tali aree risulta alquanto
consistente, il che vale a dire che il patrimonio culturale e'
indubitabilmente una risorsa la cui valorizzazione compete alla
Regione.
Sul punto, peraltro, gia' nella sentenza n. 9 del 2004, codesto
Ecc.mo Collegio non aveva mancato di individuare le direttrici
normative della materia de qua anche per quanto attiene le funzioni
amministrative correlate, particolarmente laddove affermava che: "Il
quadro complessivo della disciplina dei beni culturali va ricostruito
sulla base di molteplici dati normativi, eterogenei per il loro
contesto specifico e per il rango della fonte. In particolare,
benche' il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sia stato
emanato in un momento antecedente la riforma di cui alla legge
costituzionale n. 3 del 2001, questa Corte ha gia' riconosciuto (V.
sentenza n. 94 del 2003) che utili elementi per la distinzione tra
tutela e valorizzazione dei beni culturali possono essere desunti
dagli artt. 148, 149, 150 e 152 di tale decreto. L'art. 148
stabilisce che ai fini del decreto stesso s'intende per tutela «ogni
attivita' diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni
culturali e ambientali»; per gestione «ogni attivita' diretta,
mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare
la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al
perseguimento delle finalita' di tutela e valorizzazione»; per
valorizzazione «ogni attivita' diretta a migliorare le condizioni di
conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad
incrementarne la fruizione». L'art. 149, comma 1, prescrive che «ai
sensi dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei
beni culturali
la cui disciplina generale e' contenuta nella legge 1° giugno
1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni».
L'art. 150 disciplina il trasferimento della gestione di alcuni beni,
secondo il principio di sussidiarieta', alle regioni, alle province o
ai comuni. L'art. 152 prevede al comma 1 che lo Stato, le regioni e
gli enti locali curino, ciascuno nel proprio ambito, la
valorizzazione dei beni culturali e che, ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera c), della legge n. 59 del 1997, la valorizzazione venga di
norma attuata mediante firme di cooperazione strutturali e funzionali
tra Stato, regioni ed enti locali, secondo guanto previsto dagli
articoli 154 e 155 dello stesso decreto legislativo. Il comma 3
dell'art. 152 stabilisce che le funzioni e i compiti di
valorizzazione comprendono, in particolare, le attivita' concernenti:
«a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro
sicurezza, integrita' e valore; b) il miglioramento dell'accesso ai
beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante
riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; c)
la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno
favorite; d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative
scientifiche anche in collaborazione con universita' ed istituzioni
culturali e di ricerca; e) l'organizzazione di attivita' didattiche e
divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione; j)
l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati; g) l'organizzazione di eventi culturali connessi
a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro
o ad acquisizione; h) l'organizzazione di itinerari culturali,
individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali
diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per
il turismo». A sua volta il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali),
all'art. 10, comma 1, lettera b-bis) - disposizione aggiunta con
l'art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, successivamente
quindi all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del
2001, e poi modificata dal comma 52 dell'art. 80 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e dall'art. 6 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
- nel prevedere la possibilita' di dare in concessione a soggetti
diversi da quelli statali la gestione di servizi relativi ai beni
culturali di interesse nazionale, tramite l'emanazione di un
regolamento che disciplini tali concessioni, indica tra i criteri e
le garanzie cui il regolamento dovra' uniformarsi la salvezza della
riserva statale sulla tutela dei beni.
7. - I dati normativi riferiti permettono di affermare quanto
segue.
La tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative
anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del
2001, sono state considerate attivita' strettamente connesse ed a
volte, ad una lettura non approfondita, sovrapponibili. Cosi' l'art.
148 del d.lgs. n. 112 del 1998 annovera, come s'e' visto, tra le
attivita' costituenti tutela quella diretta «a conservare i beni
culturali e ambientali», mentre include tra quelle in cui si
sostanzia la valorizzazione quella diretta a «migliorare le
condizioni di conservazione dei beni culturali e ambientali». La
gestione, poi, nella definizione che ne da' il medesimo articolo, e'
funzionale sia alla tutela sia alla valorizzazione. Il menzionato
art. 152 dello stesso decreto legislativo considera la valorizzazione
come compito che Stato, regioni ed enti locali avrebbero dovuto
curare ciascuno nel proprio ambito. Tuttavia le espressioni che,
isolatamente considerate, non denotano nette differenze tra tutela e
valorizzazione, riportate nei loro contesti normativi dimostrano che
la prima e' diretta principalmente ad impedire che il bene possa
degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto
culturale; ed e' significativo che la prima attivita' in cui si
sostanzia la tutela e' quella del riconoscere il bene culturale come
tale. La valorizzazione e' diretta soprattutto alla fruizione del
bene culturale, sicche' anche il miglioramento dello stato di
conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la
fruizione ed ai modi di questa. Occorre infine rilevare che in nessun
atto normativo precedente la modifica del Titolo V della Parte II
della Costituzione la tutela dei beni culturali viene attribuita a
soggetti diversi dallo Stato; successivamente a questa, anzi, il
citato comma 1, lettera b-bis), dell'art. 10 del d.lgs. n. 368 del
1998, nel prevedere le concessioni per la gestione dei servizi
relativi ai beni culturali di interesse nazionale, stabilisce, come
s'e' detto, che deve restare ferma la riserva statale sulla tutela
dei beni. Alla luce delle suesposte considerazioni la riserva di
competenza statale sulla tutela dei beni culturali e' legata anche
alla peculiarita' del patrimonio storico-artistico italiano, formato
in grandissima parte da opere nate nel corso di oltre venticinque
secoli nel territorio italiano e che delle vicende storiche del
nostro Paese sono espressione e testimonianza. Essi vanno considerati
nel loro complesso come un tutt'uno, anche a prescindere dal valore
del singolo bene isolatamente considerato. Nel modificare il quadro
costituzionale delle competenze di Stato e Regioni per la parte che
qui interessa, il legislatore costituente ha tenuto conto sia delle
caratteristiche del patrimonio storico-artistico italiano, sia della
normativa esistente, attribuendo allo Stato la potesta' legislativa
esclusiva e la conseguente potesta' regolamentare in materia di
tutela dei beni culturali e ambientali (art. 117, secondo comma,
lettera s, Cost.) ed alla legislazione concorrente di Stato e Regioni
la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (art. 117, terzo
comma, Cost.).
Se ne deduce che la valorizzazione e' diretta soprattutto alla
fruizione del bene culturale, sicche' anche il miglioramento dello
stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui
avviene la fruizione e con riferimento ai modi di questa.
Conseguentemente, i divieti o i limiti imponibili, come previsti
nella norma interloquita, laddove finalizzati alla maggior fruizione
dei beni monumentali o degli altri immobili interessati da flussi
turistici, e' ascrivibile ineludibilmente alla materia
«valorizzazione dei beni culturali.».
L'esaustiva ricostruzione rinvenibile nell'articolata disamina
che precede, come parzialmente riportata, evidenzia
inequivocabilmente come il fulcro della questione consista non tanto
nell'apposizione di vincoli all'esercizio di determinate attivita',
quanto piuttosto nell'individuazione dei soggetti istituzionali
competenti, sinora normativamente indicati secondo una metodologia
ondivaga, oscillante nel tempo tra Stato ed enti locali, senza tenere
in debita considerazione la molteplicita' delle diverse potesta'
correlate alla cura degli interessi pubblici, nei differenti ambiti
del commercio e della cultura, in una logica di necessario
contemperamento delle posizioni eventualmente contrapposte.
I limiti apponibili all'esercizio del commercio, infatti, sono
plurimi e attualmente contemplati all'articolo 3 del D.L. n. 138 del
2011, gia' supra evocato, il cui comma I viene riportato di seguito.
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012,
adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei
soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e
contrasto con l'utilita' sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute
umana, la conservazione delle specie animali e vegetali,
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta di giochi
pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza
pubblica.».
Appare pleonastico sottolineare come la predetta norma si
configuri, principalmente, quale limite alla liberta' di iniziativa
economica sancita all'articolo 41 della Costituzione e, come tale, e'
correttamente correlata alla salvaguardia di beni integranti
altrettanti valori della Costituzione perche' ritenuti di preminente
rilevanza, quali la sicurezza, la salute, l'ambiente e la finanza
pubblica.
E, in proposito, in forza dell'elementare principio di
sussidiarieta' applicato in subiecta materia, e' quella comunale
l'amministrazione deputata a presidiare, mediante l'esercizio di
un'adeguata potesta' regolamentare, il rispetto delle norme
disciplinatorie stabilite dai soggetti titolari della potesta'
legislativa, e necessariamente emanate in conformita' ai precetti
costituzionali. A tale posizionamento istituzionale devono essere
ricondotti i poteri enunciati nell'articolo 54 del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 che il Sindaco esercita in qualita' di ufficiale del
Governo e che sono connotati da un'ampiezza tale da non subire
compromissioni o contenimenti neppure in ossequio ai noti, prevalenti
e talvolta prevaricanti principi di liberta' di iniziativa economica,
tutela della concorrenza e del mercato e liberalizzazione
commerciale.
E l'indiscutibile estensione delle anzidette potesta' sindacali
trova un'ulteriore, recentissima conferma proprio nella circolare
esplicativa n. 3644/C del 28 ottobre 2011, con la quale,
successivamente all'abrogazione dei limiti di orario e degli obblighi
di chiusura degli esercizi commerciali, avuto specifico riguardo
all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero
dello sviluppo economico ha espressamente riconosciutola legittimita'
di «eventuali specifici atti provvedimentali, adeguatamente motivati
e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di
chiusura correlati alla tipologia e alle modalita' di esercizio
dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande per motivi
di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela» (...)
«potendosi legittimamente sostenere che trattasi di «vincoli»
necessari ad evitare «danno alla sicurezza» (...) «e indispensabili
per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del
paesaggio e del patrimonio culturale».
In ogni caso, alla potesta' amministrativa comunale senza dubbio
tuttora sussistente, non soltanto nelle linee generali ed amplissime
sopra cennate, ma anche a termini dello stesso comma 1 dell'articolo
52 del d.lgs. n. 42/2004, si aggiunge una potesta' legislativa
regionale ai sensi del decreto legislativo n. 114 del 1998 che
individua le Regioni quali soggetti istituzionali titolari del potere
normativo in materia di commercio, con previsione, peraltro,
convalidata dalla successiva giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte,
che ha espressamente ricondotto l'ambito settoriale in argomento nel
quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione. Ed in punto, la
Regione ha esercitato tale potere inserendo il comma 4-bis
nell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 «Nuove
norme in materia di commercio su aree pubbliche» introdotto
dall'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7. La
disposizione, ancora in vigore ed oggetto di applicazione, prevede
espressamente il divieto di esercitare il commercio su aree pubbliche
in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione
superiore ai cinquantamila abitanti. La norma e' stata censurata con
giudizio promosso in via incidentale dal TAR Veneto che ha sollevato
la questione di legittimita' costituzionale perche' discriminatoria
nei confronti di una vasta platea di piccoli imprenditori.
La sentenza n. 247 del 2010, conclusiva del giudizio de quo,
appare significativamente rilevante per l'odierna controversia
poiche', per un verso, ribadisce la competenza regionale nella
materia commercio "Per non limitarsi alla, pur inequivoca,
intitolazione («Nuove norme in materia di commercio su aree
pubbliche»), appare indubbio che le disposizioni della legge in esame
- avendo quale oggetto specifico la normativa regionale del commercio
su aree pubbliche - siano riconducibili immediatamente alla materia
«commercio», di competenza residuale delle regioni (sentenze n. 165 e
n. 64 del 2007); "e, per altro verso, ha riscontrato la coerenza
della norma regionale rispetto alla ratio," essendo del tutto
naturale che, nell'ambito di una generale regolamentazione della
specifica attivita' del commercio in forma itinerante, vada
ricompresa anche la possibilita' di disciplinarne nel concreto lo
svolgimento, nonche' quella di vietarne l'esercizio in ragione della
particolare situazione di talune aree metropolitane (centri storici
dei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, di
modo che l'esercizio del commercio stesso avvenga entro i limiti
qualificati invalicabili della tutela dei beni ambientali e
culturali. Infatti, la ratio del divieto trova altresi'
giustificazione nello scopo di garantire, indirettamente, attraverso
norme che ne salvaguardino la ordinata fruizione, la valorizzazione
dei maggiori centri storici delle citta' d'arte del Veneto a forte
vocazione turistica."
La correttezza dell'operato del legislatore regionale e' stata
valutata in ragione dalla determinatezza e puntualita'
dell'intervento che, in quanto circoscritto a specifiche condizioni,
e' risultato essere proporzionale e ragionevole rispetto
all'obiettivo perseguito. Nella pronuncia, infatti, si legge che «La
norma censurata, pertanto, non produce alcuna lesione di regole a
tutela della concorrenza, giacche' il divieto sancito dalla Regione
Veneto non incide, ne' direttamente ne' indirettamente, sulla
liberta' di concorrenza; esso si colloca infatti - senza introdurre
discriminazioni fra differenti categorie di operatori economici che
esercitano l'attivita' in posizione identica o analoga - nel diverso
solco della semplice regolamentazione territoriale del commercio
(disciplinata in coerenza con la salvaguardia dei beni culturali
caratterizzanti la specifica realta' del territorio regionale) ed
appare razionalmente giustificato dalle concrete e localizzabili
esigenze di tutela di altri interessi di rango costituzionale.
Come gia' detto, la disposizione censurata assicura un
contemperamento ragionevole fra la liberta' dell'esercizio del
commercio su aree pubbliche in forma itinerante (la cui
autorizzazione, peraltro, abilita all'esercizio della relativa
attivita' in tutto il territorio nazionale: art. 4, comma 2, della
legge regionale n. 10 del 2001) e l'introduzione di limitate
eccezioni, oggettivamente motivate dall'esigenza di non superare i
limiti posti a tutela dei centri storici delle grandi citta' d'arte
della Regione.
Ma tutto quanto prima esposto alimenta il dubbio che la
disposizione regionale vigente e quella odiernamente censurata dalla
regione Veneto siano suscettibili di sovrapposizioni quantomeno
potenziali e possano generare perplessita' ermeneutiche circa
l'individuazione della normativa concretamente applicabile perche'
prevalente ed assorbente entrambi i profili disciplinatori afferenti
tanto il commercio quanto la cultura, senza conflitti di competenze.
In tal senso, la norma regionale menzionata si configura come
correttamente delimitata tanto territorialmente, essendo riferita ai
centri storici dei comuni con popolazione superiore a «cinquantamila
abitanti», quanto oggettivamente, poiche' concerne appunto il
«commercio su aree pubbliche in forma in itinerante». Anche sotto
tale profilo la disposizione statale appare incidente con la
disciplina regionale, proprio perche', a differenza della norma
regionale veneta, contempla indistintamente tutte le aree pubbliche
di particolare valore archeologico, storico, artistico e
paesaggistico, senza alcun criterio discretivo, ulteriore rispetto
alla presenza di complessi monumentali o di altri immobili del
demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente
rilevanti.
Per effetto della novella statale oggetto del presente giudizio,
quindi, la portata precettiva delle disposizioni regionali, che
avessero trovato puntuale attuazione nelle conseguenti e
consequenziali determinazioni comunali, potrebbe subire
un'inammissibile compromissione a seguito di un atto provvedimentale
emanato dal Sovrintendente nell'esercizio di potesta' amministrative
connotate da un'estensione tale da travolgere qualsiasi competenza
costituzionalmente garantita, sino a rasentare l'arbitrio. Cio' che
sconcerta sono appunto le modalita' indiscriminate, e destrutturanti
il contesto ordinamentale, con le quali l'intervento de quo e' stato
legislativamente concepito, non certo le esigenze di valorizzazione e
migliore fruibilita' del patrimonio culturale allo stesso sottese. E'
per riaffermare tali esigenze, salvaguardando tuttavia gli assetti
disciplinatori regionali gia' vigenti ed efficacemente operanti, che
la difesa regionale ha promosso in via principale la presente
questione di legittimita' costituzionale, sollecitando la pronuncia
di codesta Ecc.ma Corte affinche' chiarisca la reale portata
legislativa della disposizione impugnata ed eventualmente la espunga
dal quadro non-nativo di riferimento perche' con esso incompatibile,
restituendo certezza giuridica agli operatori economici del settore e
ricomponendo in termini di coerenza quello che attualmente e' un
insieme frammentario e non coordinato di una pluralita' di competenze
soggettivamente ed oggettivamente simultaneamente interferenti.
Tale esigenza chiarificatrice pare corroborata anche dall'inciso
contenuto nella disposizione statale che, specificando ulteriormente
l'area suscettibile di valorizzazione in termini di presenza di
«immobili interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti»,
attrae nell'alveo materiale delle norme anche la disciplina del
turismo, che e' esso pure ambito soggetto alla potesta' legislativa
residuale regionale.
Se dunque, sia la potesta' normativa in tema di commercio, che
quella in materia di turismo sono di attribuzione regionale; se,
parimenti regionale e' la competenza legislativa, seppure
concorrente, in ordine agli interventi destinati alla valorizzazione
del patrimonio culturale, nei cui confronti si configurano come
insussistenti tanto una potesta' trasversale statale ricondotta alla
tutela della concorrenza di cui alla lettera e) del comma secondo
dell'articolo 117 della Costituzione, quanto la stessa potesta'
esclusiva afferente la tutela del predetto patrimonio di cui all'art.
117, comma secondo, lettera s) della vigente Costituzione,
trattandosi di limiti e divieti all'esercizio di attivita'
piccolo-imprenditoriale, risulta incomprensibile e sistematicamente
inaccettabile il disallineamento afferente l'esercizio delle potesta'
amministrative che la disposizione impugnata determina.
Sul punto, e' certamente indiscutibile che possa ed anzi debba
essere esercitata la potesta' amministrativa comunale anche in
riferimento alla vastissima categoria dei beni qualificabili come
«culturali», che, come precisato nell'articolo 10 del d.lgs. n.
42/2004, include i beni immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ivi comprese le
pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di
interesse artistico o storico. Ma gli anzidetti poteri comunali
presentano altresi' profili di presidio e preservazione, laddove, ad
esempio, devono garantire l'osservanza di norme particolarmente
rigorose, quali l'art. 20 del medesimo decreto, che sanziona
autonomamente, qualificandoli di peculiare gravita', gli atti di
distruzione, deterioramento o danneggiamento di beni culturali, i
quali, peraltro, sono normativamente sottratti anche ad usi non
compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da
recare pregiudizio alla loro conservazione.
Indubbiamente, sino all'intervento legislativo in esame, tutte le
cennate potesta' amministrative sono state esercitate nel rigoroso
rispetto del potere consultivo di cui sono tributari gli organi
statali, che, ora, invece, per effetto della novella, diventano i
protagonisti dell'amministrazione attiva, secondo un modello di
rovesciamento prospettico che emargina le amministrazioni comunali ad
un ruolo meramente valutativo, e neppure vincolante, con riverberi
decisivi sulla restante e rilevantissima attivita' di governo del
territorio, sia pianificatoria che organizzativa. Correlativamente,
la potesta' legislativa regionale rimane paralizzata a causa
dell'indeterminatezza dei parametri di riferimento e della concreta
impossibilita' di statuire norme destinate a disciplinare ambiti nei
quali la potesta' esercitata e' di rango statale.
Nella gia' citata decisione n. 247 del 2010, codesto Ecc.mo
Collegio ha appunto riconosciuto la competenza comunale in materia in
relazione al disposto dell'articolo 52, comma 1, del d.lgs. n.
42/2004, nel testo all'epoca vigente, affermando che: D'altronde, di
tale esigenza si e' fatto carico anche il legislatore statale con il
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137), che - rendendo esplicito che le pubbliche piazze, le vie, le
strade e gli altri spazi urbani di interesse artistico o storico
rientrano fra i beni culturali, e che essi sono pertanto oggetto di
tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e del
decoro urbano (art. 10, comma 4, lettera g) - ha ribadito, in
conformita' di quanto gia' stabilito dall'art. 28, comma 16, del
d.lgs. n. 114 del 1998, che i Comuni «individuano le aree pubbliche
aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle
quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del
commercio» (art. 52).
Non possono, quindi, condividersi, perche' oltretutto immotivate,
le ragioni fondanti la trasmigrazione della competenza amministrativa
attiva dagli enti locali allo Stato, in assenza di qualsiasi
coordinamento istituzionale con la potesta' amministrativa comunale,
che a tutti gli effetti rimane, ed incidendo surrettiziamente sulle
attribuzioni legislative regionali, utilizzando a pretesto un ambito,
quale quello della «valorizzazione dei beni culturali»,
particolarmente duttile per la complessita' dei profili che involge.
E cio', sebbene proprio l'articolo 1, comma 3 del d.lgs. n. 42/2004
assegni espressamente alle Regioni un ruolo determinante appunto per
la valorizzazione dei beni culturali come gia' abbondantemente
evidenziato.
Ecco perche' anche a voler ammettere una diversa valutazione
degli interessi pubblici correlati ai contesti attratti dal
legislatore statale nella regolamentazione in argomento, comunque
l'intervento normativo in esame appare contrario al terzo comma
all'articolo 117 della Costituzione, ove e' allocata la
valorizzazione dei beni culturali, atteso che, trattandosi di ambito
soggetto a potesta' legislativa concorrente, esso avrebbe dovuto
essere contenuto nei margini che gli sono propri e cioe' nei limiti
dell'enucleazione dei principi fondamentali.
Invece, la disposizione interloquita ha attribuito ad un organo
statale un potere coercitivo generale ed indeterminato, del tutto
analogo a quello previsto nel previgente testo unico in materia di
beni culturali di cui al d.lgs. n. 490/1999, senza porre la minima
attenzione al riparto di competenze di estrazione costituzionale
attualmente esistente.
Infine, ad avviso dello scrivente patrocinio, e' giuridicamente
preoccupante la previsione, pure contenuta nell'articolo 4-bis della
legge n. 112/2013, che, in riferimento alle aree individuabili per
l'applicazione dei provvedimenti statali regolatori o inibitori, non
si limita alle locuzioni utilizzate, che gia' risultano singolarmente
indeterminate e non identificabili, come supra eccepito, ma include,
altresi', le «aree a essi contermini», laddove «essi» puo' indicare
anche i complessi monumentali o semplicemente i beni immobili.
Correlativamente, non meno criptica si configura la possibilita' di
estendere l'oggetto dell'intervento amministrativo statale sino a
ricomprendere «qualsiasi altra attivita' non compatibile», in spregio
dell'art. 97 della Costituzione.
E sicuramente, si ribadisce, tale indeterminatezza non puo' non
riflettersi negativamente anche sulla potesta' amministrativa
regionale di cui all'articolo 118 della Costituzione, laddove
quest'ultima sia finalizzata alla pianificazione e programmazione
delle attivita' sia commerciali, che artigianali, che turistiche,
rilevata l'assenza di qualsiasi parametro di valutazione, nonche' di
qualsivoglia meccanismo di raccordo istituzionale, che consenta il
legittimo esercizio delle predette attribuzioni secondo i noti
criteri di economicita', efficacia ed efficienza, senza spreco di
risorse, perseguendo quegli obiettivi di valorizzazione del
patrimonio culturale che non possono essere disgiunti da metodi di
ottimizzazione e finalita' di sviluppo. Si rammenta, infatti, che la
consultazione obbligatoria, ma non vincolante, e' prevista
esclusivamente con le amministrazioni comunali.
Violazione dell'articolo 120 della Costituzione.
I dubbi ermeneutici e l'incertezza delle pluriformi normative che
si sono progressivamente sovrapposte hanno, tra l'altro, generato
notevoli cesure tra i vari livelli di governo che risultano tuttora
alieni dal pieno e soddisfacente utilizzo degli strumenti di
concertazione strutturati per essere destinati nelle sedi deputate al
necessario confronto ed alla collaborazione interistituzionale.
Ed invero, come e' noto, al comma 6 dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131 «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». e'
espressamente previsto che il Governo possa promuovere intese in sede
di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a
favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni. Va adeguatamente considerato che esempi attuativi di tale
disposto normativo si ravvisano anche in settori, quale quello del
turismo, di competenza esclusiva regionale. In tale contesto,
infatti, le forme di leale collaborazione tra Stato e Regioni si sono
sviluppate sino a divenire lo strumento privilegiato di coordinamento
delle diverse legislazioni regionali e di definizione di standard
comuni in tutto il territorio nazionale.
In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34
dell'11 febbraio 2009, e' stato emanato in attuazione dell'articolo
2, comma 193, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
prevedeva, appunto, l'adozione di un decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri per definire
«le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a
cui vi e' necessita' di individuare caratteristiche similari e
omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione
dei contesti territoriali», d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano.
In termini piu' generali, la necessita' di una convergenza in
questo particolare ambito di legislazione, nel quale i settori del
commercio e del turismo si intrecciano con quello afferente la
valorizzazione dei beni culturali, appare di indiscutibile pregnanza,
attesa la ragionevolezza ed assoluta condivisibilita' di interventi
regolatori dell'attivita' imprenditoriale per contemperare le
esigenze di salvaguardia del diritto di impresa con quelle afferenti
altri valori costituzionalmente garantiti. D'altro canto, la
necessita' di avviare il confronto interistituzionale e'
espressamente indicata anche nelle stesse premesse della
ripetutamente evocata direttiva del Ministero datata 10 ottobre 2012
laddove, oltre a ribadire che «lo svolgimento di attivita' non
compatibili puo' impedire di assicurare livelli di valorizzazione
qualitativamente adeguati allo straordinario valore dei beni
interessi, con effetti pregiudizievoli anche sullo sviluppo e la
promozione del turismo culturale», si precisa, nel contempo, che «il
conseguimento degli obiettivi e il soddisfacimento delle esigenze,
sopra indicati, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
richiede la piena e leale collaborazione tra le diverse Istituzioni
pubbliche a vario titolo competenti, nell'esercizio dei rispettivi
poteri e attribuzioni.». Ma, in realta', l'intero testo della
predetta direttiva e' costellato da riferimenti al principio di leale
collaborazione, e cosi', al punto 3.1 della medesima si legge che
«gli Uffici del Ministero collaboreranno con le Amministrazioni
locali»; ed ancora «L'esercizio congiunto dei poteri in questione
potra' essere opportunamente racchiuso nella forma dell'accordo tra
pubbliche amministrazioni volto a disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; ed infine al
punto 3.2.3, con riferimento all'individuazione dei soggetti titolari
di diritti di uso individuale, e' imposta agli uffici governativi la
collaborazione con i competenti enti territoriali.
Al riguardo, si sottolinea come l'articolo 5 del decreto
legislativo n. 42/2004 abbia cristallizzato in norma il principio di
leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione
proprio in riferimento all'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di beni culturali, utilizzando il termine atecnico di
«cooperazione». E tale norma si aggiunge ad altre disposizioni del
medesimo decreto legislativo, che declinano una multiforme varieta'
di modelli di intesa e coordinamento tra lo Stato e le Regioni
stabilite per l'esercizio delle rispettive competenze amministrative.
In dettaglio, l'articolo 17, comma 1, del decreto in argomento,
in relazione alle funzioni amministrative di catalogazione,
stabilisce che «Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni
culturali e coordina le relative attivita'»; ed ancora, il successivo
articolo 18, al comma 2, in riferimento alle funzioni di vigilanza
sulle cose su cui sussiste un interesse culturale, prevede che «Sulle
cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e
agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla
vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le
regioni medesime.».
Ne' pare potersi obiettare, a contrariis, che, vertendosi in tema
di potesta' legislativa concorrente, lo Stato, nella complessa
disposizione odiernamente interloquita, avrebbe dettato semplicemente
i principi fondamentali, per i quali non puo' essere invocato il
rispetto del principio di leale collaborazione. E' di tutta evidenza,
invece, come, in realta', nella fattispecie in esame lo Stato abbia
travalicato il proprio ambito di intervento astrattamente
ammissibile, dettagliando le statuizioni ed attribuendo agli organi
statali un potere prescrittivo ed operativo che diverge notevolmente
dalla semplice indicazione dei principi fondamentali (cfr., la
sentenza n. 222 del 2008).
Infine, non si puo' non rinviare al terzo comma dell'art. 118
della Costituzione, ove si impone alla legge statale la disciplina di
forme di intesa e di coordinamento tra Stato e Regioni proprio nella
materia della tutela dei beni culturali. Con cio' si intende, salvo
il contrario avviso di codesto Ecc.mo Collegio, che qualora si reputi
riconducibile la disposizione censurata all'ambito di competenza
esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s)
della Costituzione, si impone una pronuncia interpretativa che
armonizzi gli assunti, ripetutamente espressi da codesta Ecc.ma
Corte, che escludono il principio di leale collaborazione nelle
materie di competenza esclusiva statale o concorrente, limitatamente
all'individuazione dei principi fondamentali, ed il precetto di rango
costituzionale evocato che riafferma la necessita' di coordinare
l'esercizio delle potesta' amministrative in tale materia mediante
forme di intesa e coordinamento. E quanto prospettato tiene conto
dell'orientamento ermeneutico secondo il quale la certezza,
dell'ascrivibilita' di una disposizione impugnata in un ambito
materiale riservato alla potesta' legislativa statale, preclude
l'obbligo di istituire meccanismi concertativi tra Stato e Regione,
atteso che gli stessi debbono, in linea di principio, essere
necessariamente previsti solo quando vi sia una concorrenza di
competenze nazionali e regionali, per la quale non possa ravvisarsi
la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri( v.
le sentenze n. 234 del 2012, n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005). Al
riguardo, per le considerazioni proposte relativamente alla
disposizione impugnata, proprio perche' non e' sicura la prevalenza
di un complesso normativo rispetto ad altri, mentre e' sicuramente
identificabile solo l'intreccio di una pluralita' di competenze, si
configura come indefettibile un adeguato e fruttuoso confronto tra i
vari livelli di governo.
P. Q. M.
Per tutto quanto sopra esposto e con riserva di ulteriormente
dedurre ed argomentare con memoria aggiuntiva da depositare in
prossimita' dell'udienza di discussione, la Regione del Veneto ut
supra rappresentata e difesa, chiede
1. che codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza,
voglia accogliere il suesteso ricorso e, per l'effetto, dichiari
l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 4-bis del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela,
la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita'
culturali.» nel testo risultante per effetto della conversione della
legge 7 ottobre 2013, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
236 dell'8 ottobre 2013 per violazione degli articoli 3, 97, 117,
commi terzo e quarto, 118 della Costituzione, nonche' del principio
di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione.
Si deposita copia conforme all'originale della D.G.R. n. 2183 del
3 dicembre 2013 di autorizzazione alla proposizione del ricorso e
affidamento dell'incarico di patrocinio per la difesa regionale.
Venezia-Roma, addi' 9 dicembre 2013
Avv. Zanon - Avv. Palumbo - Avv. Manzi