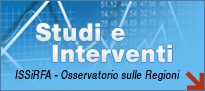Ricorso n. 11 del 16 gennaio 2015 (Regione Veneto)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 16 gennaio 2015 (della Regione Veneto).
(GU n. 8 del 2015-02-25)
Ricorso per la Regione Veneto (c.f. …; p.iva
…), in persona del Presidente pro tempore della Giunta
regionale Dott. Luca Zaia, con sede in Venezia, Palazzo Balbi,
Dorsoduro 3901, rappresentata e difesa, giusta deliberazione della
Giunta regionale n. 2471 del 23 dicembre 2014 e pedissequo mandato
speciale a margine del presente ricorso, dagli avv.ti prof. Mario
Bertolissi del Foro di Padova (c.f. …; pec:
…; fax: 049 83 60 938), Ezio
Zanon coordinatore dell'Avvocatura regionale (c.f. …;
pec: …; fax: ..) e dall'avv. Luigi
Manzi del Foro di Roma (c.f. …; pec:
…; fax: ..), con domicilio
eletto presso lo studio legale del terzo, in Roma, via F.
Confalonieri n. 5;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (c.f.
..), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale
dello Stato (c.f. …), con sede in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt.
4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9; 7, commi 2 e 3; 42, commi 1, 2, 3 e
4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, rubricato «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive», convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata nel Supplemento ordinario
n. 85 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 del
11 novembre 2014, per violazione degli artt. 2, 3, 97, 114, comma 1,
117, comma 3, 118 e 119 della Costituzione.
Fatto
Con il d.l. n. 133 del 12 settembre 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 164 dell'11 novembre 2014, il
legislatore statale e' intervenuto in diversi settori con
disposizioni finalizzate a consentire al nostro Paese il superamento
della situazione di grave crisi economica che lo attanaglia, tant'e'
che tale decreto-legge e' meglio conosciuto come decreto c.d. Sblocca
Italia.
La Regione Veneto ha individuato, nel corpo del provvedimento,
una serie di disposizioni normative che appaiono lesive
dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita: in una
prospettiva che guarda all'avvenire del Paese.
In ragione di cio', la Regione Veneto deve chiedere a codesto
ecc.mo Collegio la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
delle disposizioni normative in epigrafe indicate per i seguenti
motivi di
Diritto
I. Premesse
1. Nonostante rappresenti ormai, senz'altro a parole, un luogo
comune la denuncia di un'evasione fiscale e contributiva enorme e di
tassi insostenibili di inefficienza (1) , tali da porre il Paese in
condizione di non essere in grado di escogitare rimedi da opporre a
un doloroso, preoccupante declino; nonostante sia noto a tutti che
misure indifferenziate - c.d. lineari, che si ricollegano alla spesa
storica di ciascun ente - siano, sul versante delle entrate e delle
spese, destinate non a ridurre, ma ad incrementare gli squilibri
territoriali; nonostante tutto cio', i Governi che si sono succeduti,
l'uno all'altro, pare procedano secondo una logica deterministica,
vale a dire in assenza di cio' che illumina le scelte, rendendole, ad
un tempo, razionali e ragionevoli.
Certo, non sono mancate le sollecitazioni. Per rimanere fermi
all'ottica del giudizio di legittimita' costituzionale delle leggi,
proprio la Regione Veneto ha sottoposto a codesto Ecc.mo Collegio -
da cinque lustri almeno, con garbo e precisione millimetrica,
attraverso questo patrocinio - il problema costituzionale della
differenziazione, il cui principio e' stato formalizzato con la
novella costituzionale del 2001, che ha modificato l'art. 118 Cost.;
mentre, per l'innanzi, poteva dirsi espressione dell'art. 3, comma 2,
Cost., che e' sicuro presidio di un'eguaglianza che non vuole mai
trasformarsi in egualitarismo, anche ai sensi di cio' che dispone - e
impone - l'art. 97 Cost.
Simili prospettive - che hanno dato voce a pulsioni istituzionali
coerenti, ad un tempo, con principi politici e costituzionali di alto
profilo - si ricollegavano e si ricollegano tutt'ora a una
preoccupazione risalente di tanti (2) , i quali, pur nella
"diversita' delle opinioni", hanno "espresso la medesima
preoccupazione, e cioe' che i settori parassitari della societa'
italiana, che traggono i loro privilegi dal rapporto con il potere
politico, abbiano raggiunto una massa critica, che mette seriamente a
repentaglio le possibilita' di crescita e di sviluppo civile
dell'Italia" (3) .
A distanza, pur cosi' grande, di tempo, e' necessario ripartire
da qui: da questa inascoltata sollecitazione, visti gli esiti
negativi cui si e' giunti, avendone trascurato il senso profondo;
viste le prospettive, che non si possono alimentare di ragionamenti
che si basano su premesse ordinamentali prive di fondamento. Infatti,
la rilevanza costituzionale e il significato normativo dei principi
di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, di cui all'art.
118, comma 1, Cost., non possono prescindere da cio' che e' ed
accade: da quella che Francesco De Sanctis denominava la "cosa
effettuale" (4) Con la conseguenza - dovrebbe, finalmente, divenire
scontata - che la legge non puo' disporre trascurando, oltretutto in
nome dell'irresponsabilita', azioni positive e negative, meriti e
demeriti, in violazione, tra l'altro, degli artt. 2, 3, 97, 117, 118
e 119 Cost., che vorrebbero, prefigurandola sottotraccia, una
Repubblica coesa. Non soltanto formalmente una e indivisibile, come
promette l'art. 5 Cost., sulla carta (5) .
2. Sostiene il Presidente del Consiglio - Matteo Renzi - che, nei
decenni che lo hanno preceduto, forieri dell'attuale tracollo del
sistema-Paese, Parlamenti, Governi e relative maggioranze non hanno
saputo risolvere alcun problema strutturale. D'altra parte, con i
consueti, collaudati e ripetuti criteri di giudizio non c'e'
riuscita, ancorche' incolpevolmente, la Corte costituzionale (6) e
neanche, per parte sua, questa difesa della Regione Veneto. Tuttavia,
e' indispensabile, per almeno tentare di uscire dalle secche,
ripensare portata e limiti delle disposizioni
costituzionali-parametro qui fatte valere - gli artt. 2, 3, 97, 117,
118 e 119 Cost. - le quali non possono continuare a misurarsi con
riferimenti di indole astratta e, per cio' solo, irreali; dovendosi
confrontare, invece, con dati di fatto che riassumono in se' la vita
quotidiana di cio' che l'art. 114 Cost. definisce come Repubblica:
insieme di enti e, soprattutto, di collettivita' (7)
Per costruire un percorso limpido nelle sue premesse e nei suoi
sviluppi, e' opportuno, comunque, ricordare, in estrema sintesi, quel
che e' accaduto quanto meno a partire dal 2001: spartiacque tra il
testo originario del Titolo V della Parte II della Costituzione e il
nuovo testo, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001. Prima,
i rapporti Stato-Regioni sono stati regolati sulla base del limite
dell'interesse nazionale (e delle altre Regioni) che, abbinato al
limite territoriale, e' stato concepito, contrastando nettamente le
intenzioni del Costituente e la lettera stessa della Legge
fondamentale, come limite di legittimita'. La potesta' regionale
finanziaria e' stata ridotta, non a caso, a potesta' sostanzialmente
regolamentare (8) Dopo, le materie-funzione hanno sostituito
l'interesse nazionale e il risultato non e' mutato: fatta eccezione
per l'ulteriore amministrativizzazione del contezioso costituzionale,
cui e' indispensabile ridare slancio sul piano qualitativo. Avrebbe
dovuto concorrere a realizzare un simile programma l'attuazione del
c.d. federalismo fiscale, ma gli sviluppi istituzionali sono stati
ben altri: piu' precisamente, del tutto diversi. Di cio' bisogna
essere consapevoli, se si intende concorrere alla riforma della
Repubblica, che esige un netto cambio di rotta (9) .
Per il momento, vale la pena di accennare a quel che si era
auspicato: di concepire il federalismo fiscale quale strumento di
contrasto del "declino [dell'Italia] che ha imboccato nell'ultimo
decennio: la produttivita' ristagna, l'occupazione aumenta solo nella
componente straniera, la pressione e l'evasione fiscale restano fra
le piu' alte al mondo, i servizi pubblici permangono inefficienti, il
welfare continua a privilegiare i padri e penalizzare i figli..."
(10) ; quindi, si sarebbe dovuto evitare di "aumentare le funzioni ad
essi [enti regionali] delegate", funzioni destinate "ad attrarre
maggiori risorse pubbliche, in cambio della promessa di usarle meglio
in futuro" (11) ; piuttosto, avendo di mira l'interesse del Paese,
"il ceto politico" avrebbe dovuto rendersi conto "che l'unica
possibilita' che ha l'Italia di fermare il declino e' di rimettere in
movimento le sue locomotive, ossia i territori produttivi",
attenuando progressivamente il "parassitismo dei territori piu'
spreconi" (12) Tutto cio', sul presupposto che il regionalismo
italiano era, fin dall'origine, a macchia di leopardo (13) ,
disancorato da qualunque responsabilita', e che vi erano stati
massicci trasferimenti di risorse a favore del Sud (14) , senza
risultati degni di nota, come testimoniano le vicende che hanno
interessato, da ultimo, il Comune di Roma (15)
Ma l'auspicio non si e' tradotto in realta'. Ed e' per questo che
la questione va affrontata muovendo da quel che si e' sempre
trascurato: la valorizzazione dei "territori produttivi",
nell'interesse del Paese, che non puo' continuare a sopportare il
"parassitismo dei territori piu' spreconi". Non si e' finora tradotto
in realta' perche' il federalismo istituzionale e fiscale sono stati
fraintesi. Infatti, "se andiamo alle radici e lasciamo da parte il
folclore... e' piuttosto chiaro che la ratio principale del
federalismo non era, all'origine, quella di rendere piu' efficiente
la Pubblica amministrazione, o di restituire alle regioni
settentrionali il maltolto (circa 50 miliardi di euro, secondo le
stime piu' prudenti contenute in questo libro). No, la funzione e lo
scopo del federalismo erano piu' semplici e piu' fondamentali:
permettere ai territori piu' dinamici e produttivi del Paese di
tornare a crescere a un ritmo ragionevole, liberandoli da
un'oppressione fiscale che - nei primi anni Novanta - stava ormai
soffocando l'economia italiana, sempre meno capace di espandere
l'occupazione, reggere la concorrenza internazionale, innovare
prodotti e processi" (16) . Insomma - lo si ribadisce - "il
federalismo ... fiscale doveva ... rimettere i produttori in
condizioni di produrre" (17) . Un modo concreto per realizzare la
giustizia (18)
Se e' cosi', e' evidente che le leggi dello Stato vanno valutate,
nell'ottica costituzionale, alla luce di queste ragioni sostanziali
connesse con il bene comune, dopo aver reso espliciti gli elementi
che concorrono a identificarlo e a costituirlo. In gioco vengono le
competenze e il relativo riparto; ma, soprattutto, i contenuti
imposti dalle deliberazioni legislative, la cui legittimita' va
riscontrata - come si e' accennato - in base a presupposti che devono
essere individuati tenendo ben presente la "cosa effettuale, come te
la porge l'esperienza e l'osservazione" (19) Il che significa: e'
necessario prescindere dall'ente quale persona giuridica astratta e
guardare, invece, all'ente in concreto. A come legifera, amministra,
reperisce risorse e spende: bene o male sono aspetti imprescindibili
di un qualunque serio discorso "costituzionale".
3. La "giustizia territoriale" (20) , infatti, e' un problema -
forse, il problema dei problemi - attorno al quale ruota l'intero
Titolo V della Parte II della Legge fondamentale. Titolo che,
attraverso l'elenco delle materie di cui all'art. 117, richiama
l'intera Parte I, per ragioni che non e' neppure il caso di
enunciare. Richiama, in particolare, l'art. 53, secondo il quale
"tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacita' contributiva". Tutti - e' noto - equivale a cittadini
e stranieri; persone fisiche ed enti, territoriali e no. Quanto agli
enti territoriali, il loro concorso non puo' essere definito in modo
arbitrario, ma deve tenere conto di alcune regole fondamentali,
valide per tutti: piu' precisamente, per tutti i soggetti di cui e'
"costituita" la Repubblica, secondo quanto dispone l'art. 114, comma
1, Cost. Il criterio deve essere quello della solidarieta' (art. 2) e
dell'eguaglianza (art. 3), per cui ogni deroga deve corrispondere a
un valore costituzionalmente protetto, da scrutinare secondo l'ottica
della ragionevolezza. Ragionevole non e' privilegiare il
"parassitismo dei territori piu' spreconi", a danno dei "territori
piu' produttivi", pena la "decrescita" (21) : che e' quel che si e'
puntualmente verificato. D'altra parte, il legislatore statale ha
preferito l'eguaglianza formale e l'entificazione, non dando alcun
seguito a richieste volte ad affrontare, seriamente, il tema della
"giustizia territoriale".
4. Provvedimenti legislativi statali che dettano regole uniformi,
quando tra ente ed ente sussistono gradi anche elevati di
differenziazione; misure che agevolano oppure sanzionano, secondo
schemi incentrati su una determinazione cronologica casuale e,
comunque, di carattere astratto; revoche o attribuzioni di risorse
svincolate da ragioni in grado di spiegare e giustificare
comportamenti disomogenei; irrilevanza dei riscontri fattuali
relativi al quando e come si e' intervenuti; conferimento, piuttosto
che di poteri, di obblighi sostanziali e procedurali di adempimento
di compiti eterodeterminati con irresponsabilita' conseguente di chi
decide, vale a dire dello Stato: tutto questo ed altro ancora - se ne
riparlera' ex professo, tra poco - concorrono a svilire la logica
fatta propria dal Costituente, che ha pensato all'autonomia, al
pluralismo, alla responsabilita' e, dal 2001, anche alla
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza (art. 118, comma 1,
Cost.).
Per evitare simili esiti, che pongono a repentaglio, oltretutto,
presente e futuro della Repubblica, e' necessario individuare alcuni
elementi di fatto, cui riportarsi, senza se e senza ma (22) : essendo
indispensabile - come si e' notato (23) - che, "se l'Italia vuole
fermare il declino e tornare a crescere, di quei 50 miliardi almeno
una parte deve rientrare al Nord, e deve servire a rimettere i
produttori in condizione di fare il loro mestiere" (24) . Detto anche
in altro modo, si tratta di ridurre "l'oppressione fiscale dei
territori piu' produttivi" (25) . La Regione vi puo' concorrere sia
attenuando la propria leva tributaria sia impiegando le maggiori
risorse disponibili ad essa spettanti in spese di investimento: a
motivo di quel che si denomina residuo fiscale e per ragioni
elementari di giustizia, dipendenti dalla riduzione di inefficienze e
sprechi, che si realizza allocando diversamente i mezzi che lo Stato
da' alle Regioni, secondo quel che la Costituzione si attende.
5. La Costituzione, infatti, non puo' trascurare alcuni
essenziali dati di fatto (26) . Oggi, non ci si puo' permettere di
non essere lungimiranti, proiettando il futuro della Repubblica oltre
se stessi, rinunciando a punti di vista che hanno mutilato ogni
prospettiva. Serve un nuovo ordine - l'"ordine delle autonomie" (27)
- che salvaguarda, ripensandolo, il pluralismo: non piu' anarchico,
ma responsabile. Per dare voce istituzionale alla categoria della
responsabilita', e' opportuno riflettere ed apportare alcune
rettifiche, rispetto ad omissioni - gravi, deleterie omissioni - che
rappresentano consolidati luoghi comuni (28) .
(a) Allo scopo, serve un differente ancoraggio, che corrisponde a
un inusuale punto di vista, costituito dagli squilibri territoriali.
Infatti, "l'idea e' che, per capire i mali dell'Italia occorra
partire dagli squilibri territoriali, ma che per vedere nitidamente
tali squilibri non basti guardare il Paese a occhio nudo, o secondo
le solite lenti della contabilita' nazionale. Quello di cui abbiamo
bisogno e' una radiografia molto accurata, una sorta di TAC
(tomografia assiale computerizzata) che mostri - e misuri nel modo
piu' preciso possibile - l'anatomia economico-sociale del Paese. E'
questo il compito della contabilita' nazionale liberale" (29)
Infatti, la contabilita' nazionale trascura cio' che consente di
"descrivere adeguatamente un territorio" (30) . Trascura, in
particolare: il parassitismo (perche' non distingue "fra settore
produttivo e settore improduttivo") (31) , l'evasione (perche' si
disinteressa della "pressione fiscale effettiva sopportata
dall'economia regolare": "l'evasione fiscale non entra in alcun modo
nella contabilita' nazionale") (32) , la sottoproduzione e lo spreco
(dove "sottoproduzione significa che con la stessa spesa, si potrebbe
generare un output maggiore. Spreco significa che, il medesimo output
potrebbe essere prodotto con una spesa minore") (33) , il livello dei
prezzi ["non sappiamo nulla sulle differenze territoriali (ad esempio
regionali) nel livello generale dei prezzi. Possiamo dire che nel
2008 i prezzi erano saliti del 2,3% rispetto al 2007, ma non siamo in
grado di dire, per un dato anno, di quanto i prezzi del Veneto
superino o siano inferiori a quelli della Calabria"] (34)
Una diversa contabilita', invece (35) , considera attentamente il
tasso di parassitismo, il tasso di evasione, il tasso di
sottoproduzione e spreco, il livello dei prezzi (36) . Essa si
configura come "una descrizione completa degli scambi che determinano
- congiuntamente - il bilancio della Pubblica amministrazione e il
suo doppio, ossia i suoi effetti sul settore market [e' il settore
produttivo] dell'economia". In particolare, per quanto attiene
all'evasione fiscale, proprio essa da' "i frutti piu' interessanti a
livello territoriale, stante che i tassi di evasione variano
drasticamente da una regione all'altra" (37) .
(b) Veniamo, dunque, agli squilibri territoriali, per come li
coglie e li descrive la contabilita' nazionale liberale. Da questo
punto di vista (38) , ove si considerino peso della popolazione in
eta' di lavoro, tasso di occupazione e prodotto per occupato del
settore market (attivita' produttive), ci si trova di fronte a "un
quadro sconcertante, specialmente se lo si osserva in una prospettiva
di lungo periodo: il deficit di sviluppo del Mezzogiorno e' enorme,
e' cresciuto nel tempo, e forse non c'era prima dell'Unita' d'Italia"
(39) . D'altra parte, enorme e' il peso dell'amministrazione, che
intermedia rilevanti quantita' di risorse senza apprezzabili
risultati (40) , dal momento che sulla "spesa nominale per consumi
pubblici" gravano "gli sprechi che avvengono nella erogazione di
servizi" (41) . Da analisi serie, per quanto sempre discutibili, si
ricava che "il tasso medio di spreco e' prossimo a zero in Lombardia
(2,8%), e' molto basso (sotto il 15%) in tutto il Nord eccetto la
Liguria, e poi sale piuttosto regolarmente scendendo da Nord a Sud,
fino ad attestarsi vicino al 50% in Sicilia, Calabria, Basilicata e
Sardegna". Altro dato: "la spesa pro capite del Sud e' del 13% piu'
alta di quella del Nord, mentre i servizi pro capite prestati -
nonostante la maggiore spesa - sono inferiori di quasi il 30%" (42)
Se ne puo' prescindere, sempre e comunque, quando si da' e si
toglie? (43) . Oggi - si rileva - "il peso del settore improduttivo
dell'economia - ovvero l'interposizione pubblica 'in crescita' -
sfiora il 50% del PIL market". Ci si domanda, non certo
retoricamente: "questo carico e' distribuito in modo territorialmente
equo oppure no? (44) . E "quanto guadagnerebbe o perderebbe ogni
regione se il tasso di parassitismo fosse uniforme in tutta l'Italia?
(45) . Ecco un appunto sintetico, che trova conferma in massime di
esperienza (46) : "Si vede bene che, di fatto, il peso del
parassitismo dei territori ad alta spesa pubblica grava in massima
parte su tre sole regioni, che per la dimensione delle loro economie
e per la capacita' di contenere la spesa improduttiva reggono i
disavanzi di tutte le altre. Si tratta della Lombardia, che cede
qualcosa come 24,9 miliardi all'anno, del Veneto, con 8,8 miliardi,
dell'Emilia-Romagna, con 8,0 miliardi. In tutto fa 41,7 miliardi
all'anno, pari a circa l'85% delle risorse che ogni anno passano
dalle regioni parsimoniose verso tutte le altre. Aggiungendo le
risorse trasferite dalle altre tre regioni virtuose - Piemonte,
Toscana, Marche - si arriva a un totale di oltre 49,5 miliardi, ossia
l'equivalente di due o tre Finanziarie" (47)
E poi: "Quanto e' grande il sommerso in Italia? A quanto ammonta
l'evasione fiscale e contributiva?". "Rispondere a queste domande e'
essenziale, perche' il differenziale di evasione e' uno degli
squilibri territoriali fondamentali" (48) . Ferme restando tutte le
difficolta' del caso (49) , si sostiene (50) che "il valore aggiunto
sommerso si aggira intorno ai 250-300 miliardi di euro, e l'evasione
(mancato gettito) e' compresa fra 100 e 150 miliardi". Questa stima
e' stata ottenuta - qui sta il pregio - "regione per regione, e
consente quindi di farci un quadro degli squilibri territoriali
nell'intensita' dell'evasione" (51) . Il risultato e' sconcertante ed
e' il seguente: "La Lombardia ha un'intensita' di evasione inferiore
al 13%. Cio' significa che il contribuente lombardo, per ogni 100
euro di tasse pagate, ne occulta meno di 13 (12,5 per la precisione).
- All'estremo opposto, il contribuente calabrese ne occulta 85, ossia
sette volte piu' del suo compatriota lombardo. A una certa distanza
dalla virtuosa Lombardia si situano l'Emilia-Romagna e il Veneto, con
un'intensita' attorno al 19%. Poco piu' in la', ma sempre al di sotto
della media italiana (26,4%), incontriamo altre quattro regioni del
Centro-nord: Friuli, Lazio, Piemonte e Trentino. - E al di sopra
della media italiana? - Qui troviamo tutte le regioni del Sud, ma
anche due regioni del Nord (Valle d'Aosta e Liguria) e tre regioni
del Centro (Toscana, Marche e Umbria). La regione meridionale piu'
virtuosa e' l'Abruzzo con un'intensita' pari al 30,5%. Fra le
restanti regioni meridionali, infine, si nota il primato negativo
delle tre regioni di mafia: Calabria (85,3%), Sicilia (63,4%),
Campania (55,3%)" (52)
Luca Ricolfi conclude cosi': "In barba ai proclami leghisti, la
regione del Paese con la resistenza fiscale piu' bassa [id est: con
il tasso piu' alto di fedelta' fiscale] e' la Lombardia, mentre le
regioni con la resistenza fiscale piu' alta [id est: con il tasso
piu' basso di fedelta' fiscale] sono quelle di mafia (38,4%), con una
punta del 46% in Calabria. Come dire che un cittadino lombardo
protesta ma alla fine versa 1'89% del dovuto, un cittadino calabrese
non protesta ma versa solo il 54% del dovuto" (53) . Il che pone una
questione non proprio irrilevante, ove si rifletta avendo ben
presenti i principi di solidarieta' (di cui agli artt. 2 e 53 Cost.)
e di unita' e indivisibilita' della Repubblica (di cui all'art. 5
Cost.), declinati dal punto di vista della "cosa effettuale" (54) :
la quale mette a nudo l'ipocrisia interessata delle declamazioni
formali non accompagnate -come ebbe a notare Ettore Passerin
D'Entreves - da "cose attuose", dalle quali "soltanto puo' scaturire
una nuova realta'" (55)
(c) La realta', invece, continua a esibire dati dalle
implicazioni istituzionali perverse, di cui il Giudice delle leggi
deve finalmente occuparsi. Il cosiddetto residuo fiscale e' un
elemento quantitativo con il quale e' indispensabile misurarsi. O con
quel che, comunque, gli si accosta, in nome di riflessioni che ne
rivelano un qualche limite, non idoneo a scalfirne, peraltro, il
significato istituzionale (56) . Basti considerare le analisi
compiute da due studiosi della Banca d'Italia su dati 2004-2006 (57)
: "le iniquita' denunciate ... nell'anno di transizione fra prima e
seconda Repubblica paiono essere una sorta di invariante della nostra
storia repubblicana, qualcosa che riscopriamo ciclicamente ma che
nessun governo e nessuna politica hanno mai veramente scalfito" (58)
.
Il residuo fiscale - cui si fara' riferimento anche in seguito
per le ragioni poc'anzi accennate (59) - lo si e' voluto meglio
precisare quando si e' parlato di "teoria della giustizia
territoriale", che guarda - per stabilire se "un territorio e' in
debito o in credito di un certo ammontare" di risorse - a
"un'allocazione 'giusta' delle risorse disponibili" (60) . In questa
prospettiva, vi sono quattro capisaldi da rispettare: il principio di
equita' fiscale, il principio di responsabilita' territoriale e il
principio di solidarieta', nonche' il principio di convergenza (61) .
Tre, invece, sono le "componenti fondamentali del credito (debito) di
ogni territorio": il credito fiscale, il credito da efficienza e il
credito da parsimonia (62) , di una evidenza lapalissiana. Si possono
seguire criteri diversi e, finanche, antitetici nel combinare tra
loro solidarieta' e responsabilita'. Comunque sia, in concreto
esistono Regioni "aiutate", Regioni "assistite" e Regioni "spoliate":
"regioni cioe' che, pur essendo deboli, anziche' ricevere di piu' di
quel che loro spetterebbe in base al loro prodotto (solidarieta')
ricevono addirittura di meno (spoliazione)" (63) . Ovviamente, "il
fatto che i territori deboli beneficino di meccanismi ridistributivi
di tipo solidaristico implica ... che vi siano ... territori
donatori'. L'indagine dimostra che "in una situazione di spoliazione
... si trovano Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e
Marche"; mentre usufruiscono di una "appropriazione ... tutte le
regioni a statuto speciale del Nord, la Liguria e il Lazio (che
tuttavia e' un caso speciale, perche' include la capitale Roma)" (64)
.
In breve: il Centro d'Italia "non si discosta troppo
dall'equilibrio contabile" (il riferimento e' a Toscana, Umbria e
Marche); "completamente squilibrata, invece, risulta la situazione
contabile del Nord e del Sud, con il Nord che e' in attivo in tutti
gli ambiti e cede complessivamente 50,6 miliardi di euro all'anno
(circa 3 punti di PIL), e il Sud che e' in passivo in tutti gli
ambiti e si appropria di 41,2 miliardi". Ed ecco la conclusione, da
brivido, ove si guardi alla Repubblica e al suo avvenire: "il
trasferimento di risorse, dunque, e' essenzialmente un trasferimento
da Nord a Sud, che priva ogni anno il Nord di un ammontare di risorse
che corrisponde a qualcosa come il 7% del PIL market da esso
prodotto. Un saccheggio silenzioso e invisibile che non puo' non
fiaccare la capacita' delle Regioni del Nord di produrre ricchezza,
ossia precisamente la materia prima su cui poggia la redistribuzione
a favore delle regioni deboli" (65) .
Se "produrre ricchezza" e' un problema che non interessa
l'Italia, questo ricorso e' infondato: manifestamente infondato. Ma
se non e' cosi' - perche' non e' cosi' -, allora e' fondato:
manifestamente fondato, per ragioni che l'ecc.ma Corte non manchera'
di riconoscere.
6. Come si e' ripetutamente sottolineato, e' necessario
riconsiderare il significato normativo e, quindi, portata e limiti
delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 97, 117,
118 e 119 Cost. In modo particolare, per quel che riguarda il
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art.
117, comma 3, e art. 119, comma 1), che non puo' essere considerato
esclusivamente quale espressione di un potere sovraordinato; e cio',
in particolare, quando sono in gioco situazioni giuridiche soggettive
previste e garantite dalla Legge fondamentale (66) . Il termine di
riferimento non sono, in queste circostanze, il potere statale e
regionale tra loro comparati secondo una relazione di stampo
gerarchico. E neppure viene in gioco la competenza dell'uno e
dell'altro, sebbene l'uso che lo Stato fa di quel che la Costituzione
ad esso riserva. Sotto questo profilo, la Regione Veneto si limita a
contestare la violazione di clausole costituzionali generali che
valgono per tutti: persone fisiche o giuridiche che siano, a maggior
ragione quando queste ultime sono - come le Regioni sono, per
pacifica giurisprudenza di codesta Corte - enti esponenziali delle
relative comunita'. Le quali - come si precisera' tra breve - sono
destinate a veder incrementata oppure diminuita la tutela che loro
attribuisce la Costituzione a seconda che possano disporre oppure no
di maggiori risorse. Perche' - come e' noto - tutti i diritti costano
(67)
Le risorse appunto! In gioco vengono - considerate con
riferimento al nesso entrate-spese (di cui all'art. 53 Cost.) - la
"giustizia territoriale" e l'insieme delle relative implicazioni. In
particolare, oltre alle tutele specifiche da accordare a chi vive in
un dato territorio, in gioco c'e' l'avvenire della Repubblica, per
come la qualifica l'art. 114 Cost.; avvenire che esige, per non
trasformarsi in declino irreversibile, che i "territori produttivi"
non continuino ad essere danneggiati dal "parassitismo dei territori
piu' spreconi" (68) . Non si tratta di opinioni, ma di dati di fatto,
i quali impongono di declinare il dovere di solidarieta' economica;
l'eguaglianza sostanziale; il buon andamento (che e'
dell'amministrazione e della legislazione); la potesta' legislativa
concorrente; i principi di sussidiarieta', differenziazione ed
adeguatezza, nonche' l'autonomia finanziaria come un corpus unitario:
nel senso che tutti i principi devono risultare condizionanti e, al
tempo stesso, condizionati da quel che si e' definito poc'anzi come
pluralismo non piu' anarchico, ma responsabile (69) .
E' alla luce di queste premesse che sono state formulate le
eccezioni di illegittimita' costituzionale che seguono, nei confronti
degli atti legislativi del c.d. Sblocca Italia: insieme di
disposizioni, di un profilo talmente basso, da creare problemi non
marginali addirittura nell'individuazione numerica dei commi, ai fini
dell'impugnazione.
II. Sulle singole questioni di legittimita' costituzionale
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 9, d.l. n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 164/2014 per violazione degli artt. 2, 3, 97, 114, comma 1,
117, comma 3, 118 e 119 della Costituzione.
L'art. 4 d.l. n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 164/2014, rubricato "Misure di semplificazione per le opere
incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore
degli Enti territoriali", dispone, per quanto qui interessa e
comunque in estrema sintesi (rinviando alla lettura delle
disposizioni per ogni ulteriore dettaglio), quanto segue:
(i) al fine di favorire la realizzazione delle opere
segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2
al 15 giugno 2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe nazionale
delle opere pubbliche incompiute di cui all'art. 44-bis d.l. n.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 (70)
, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra
amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, e' data
facolta' di riconvocare la conferenza di servizi funzionale al
riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera e cio'
anche se la conferenza di servizi fosse gia' stata definita in
precedenza. In ogni caso i termini relativi al procedimento della
conferenza di servizi sono ridotti alla meta' (comma 1);
(ii) nel caso del mancato perfezionarsi del procedimento in
ragione di ulteriori difficolta' amministrative, e' data facolta' di
avvalersi, a scopo consulenziale-acceleratorio, dell'apposita cabina
di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
(comma 2);
(iii) "i pagamenti connessi agli investimenti in opere
oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno
2014, sono esclusi dal patto di stabilita' interno alle seguenti
condizioni, accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli
Uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
concludere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto:
a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono
essere state preventivamente previste nel Programma Triennale delle
opere pubbliche;
b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso
di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei
lavori da parte dell'ente locale richiedente;
c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del
patto di stabilita' devono essere effettuati entro il 31 dicembre
2014;
c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione
dal patto di stabilita' devono riguardare prioritariamente l'edilizia
scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto
idrogeologico, la sicurezza stradale" (comma 3);
(iv) sulla base dell'istruttoria condotta dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con d.p.c.m. sono individuati i Comuni
che beneficiano della esclusione dal patto di stabilita' interno e
l'importo dei pagamenti da escludere (comma 4);
(v) i pagamenti sostenuti successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge relativi a debiti in conto
capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015 sono
esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per un importo
complessivo di 300 milioni di euro (200 milioni di euro relativamente
all'anno 2014 e 100 milioni relativamente all'anno 2015) (comma 5)
(71) ;
(vi) con riguardo all'anno 2014, "l'esclusione di cui al
secondo periodo dell'alinea del comma 5 e' destinata per 50 milioni
di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni sostenuti
successivamente alla data del 1° luglio 2014, ivi inclusi quelli
ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di
entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e
1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (72) ,
superiori a 100 milioni". Ai fini della distribuzione del rimanente
importo dell'esclusione tra i singoli enti territoriali, i Comuni, le
Province e le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze gli spazi finanziari di cui necessitano. "Con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette
comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono
individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei
pagamenti da escludere dal patto di stabilita' interno
rispettivamente nel 2014 e 2015" (comma 6);
(vii) la modifica del comma 9-bis dell'art. 31 legge n.
183/2011, il quale comunque si riferisce solo a Comuni e Province
(comma 7);
(viii) le specifiche modalita' di compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
derivanti dai commi 3, 5 e 8 dell'art. 4 d.l. n. 133/2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014, pari a
complessivi 450 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per
l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017
(comma 9) (73) .
La suddetta disposizione normativa, nei vari commi in cui e'
articolata che sono qui impugnati, e' in contrasto con la
Costituzione per una molteplicita' di profili.
Innanzitutto, essa appare violare gli artt. 3 e 97 Cost. e l'art.
114, comma 1, Cost. Quest'ultimo precetto costituzionale dispone,
come noto, che "la Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato".
La Regione, dunque, e' ente che si pone sullo stesso piano dei
Comuni, unici destinatari delle misure di semplificazione e
finanziarie (di forte agevolazione) previste dall'art. 4 del decreto
c.d. Sblocca Italia. Pur tuttavia, la Regione e' sostanzialmente
esclusa dalle misure di agevolazione previste dai commi 1, 2, 3, 4 e
9 dell'art. 4 e cio' in modo assolutamente contrario al fondamentale
canone costituzionale di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost. (a
sua volta, da leggersi in combinato disposto con l'art. 97 Cost., in
base al quale la legge deve assicurare il buon andamento della
pubblica amministrazione). Indici di tale irragionevolezza normativa
sono, tra gli altri:
a) il fatto che l'art. 4, comma 1, si prefigga lo scopo di
favorire la realizzazione delle sole opere segnalate dai Comuni alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri nel solo periodo compreso tra
il 2 e il 15 giugno 2014: il 2 giugno non e' forse la Festa della
Repubblica? E, allora, quali Comuni mai possono avere segnalato opere
pubbliche incompiute quel giorno? E perche' mai limitare
l'agevolazione alle opere incompiute segnalate in un arco temporale
cosi' breve?;
b) il fatto che le opere pubbliche incompiute iscritte
nell'elenco-anagrafe di cui all'art. 44-bis d.l. n. 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2011 siano iscritte
in un elenco istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il quale, a sua volta, e' articolato a livello regionale:
e' forse ragionevole configurare una disposizione normativa che si
rivolge alle sole opere pubbliche incompiute di competenza comunale e
non anche a quelle di competenza regionale, che generalmente sono di
maggiore impatto e rilievo per la collettivita?;
c) il fatto che, in base al comma 3 dell'art. 4, siano
esclusi dal patto di stabilita' interno i soli pagamenti connessi
agli investimenti in opere di competenza dei Comuni oggetto di
segnalazione entro il 15 giugno 2014: perche' mai tale previsione non
e' estesa anche ai pagamenti connessi agli investimenti in opere di
competenza delle Regioni? Opere che, peraltro, sono, per lo piu', di
maggiore estensione, impatto e rilievo per la collettivita?
L'irragionevolezza della disciplina normativa si traduce,
altresi', nella violazione dell'art. 2 Cost., secondo cui la
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. La
Regione, come noto, ha una pluralita' di competenze ed esercita una
pluralita' di funzioni amministrative. Si pensi, per esempio, alle
competenze ed alle funzioni esercitate in materia di "tutela della
salute" ed alle opere che alle stesse sono connesse (ampliamento,
ristrutturazione, adeguamento tecnologico di strutture ospedaliere,
per esempio). Non agevolare la realizzazione di opere simili, anche
mediante l'esclusione dal patto di stabilita' interno dei pagamenti
connessi agli investimenti in opere del genere, finisce per ledere
uno dei fondamentali diritti inviolabili dell'uomo: quello alla
salute. Non puo' dimenticarsi, poi, che la Regione e' titolare di
molte funzioni amministrative attratte alla stessa (e sottratte, in
ragione di cio', a Comuni, Province e Citta' metropolitane) al fine
di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni stesse (in puntuale
rispetto dell'art. 118, comma 1, Cost.).
E' appena il caso di rilevare che la Regione Veneto e' pienamente
legittimata a denunciare la violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost.,
perche', pur trattandosi di precetti costituzionali che formalmente
non attengono al riparto delle competenze legislative tra Stato e
Regione, cionondimeno la loro violazione comporta, nel caso di
specie, una compromissione delle attribuzioni regionali
costituzionalmente garantite o, comunque, ridonda sul riparto di
competenze legislative (in questo senso, e' pacifica la
giurisprudenza della Corte costituzionale: si vedano le sentt. nn. 33
e 128/2011 e 52 e 156/2010). Non senza aggiungere che la Corte
costituzionale ha gia' dichiarato costituzionalmente illegittime, per
manifesta irragionevolezza, disposizioni di legge statale che
fissavano termini perentori allo scadere dei quali scattavano effetti
irreversibili (si veda, sebbene con riguardo ad una fattispecie
diversa, ma per i principi pacificamente estensibili al caso in
questione, Corte cost., sent. 24 luglio 2013, n. 236).
L'art. 4 si rivela, poi, costituzionalmente illegittimo anche per
violazione del fondamentale riparto di competenze legislative tra
Stato e Regione di cui all'art. 117 Cost.
Come noto, i lavori pubblici non sono riconducibili ad una sola
materia tra quelle enumerate nell'art. 117 Cost., dal momento che i
medesimi e l'intera attivita' contrattale della pubblica
amministrazione si qualificano in base all'oggetto cui afferiscono.
Pertanto, non e' configurabile ne' una materia relativa ai lavori
pubblici nazionali, ne' una materia attinente ai lavori pubblici di
interesse regionale, ne' e' possibile tracciare il riparto di
competenze legislative tra Stato e Regioni secondo un criterio
soggettivo, distinguendo tra gare indette da amministrazioni statali
e regionali o sub-regionali. In questo senso, si e' espressa la Corte
costituzionale, a far data dalla nota sent. 23 novembre 2007, n. 401
(e con altre successive, tra cui la sent. 1° agosto 2008, n. 322,
relativa alla Regione Veneto, e la sent. 17 dicembre 2008, n. 411).
Ebbene, la disciplina del comma 1 dell'art. 4 (e cosi' quella di
cui ai commi 2, 3, 4 e 9), finalizzata, com'e', a favorire la
realizzazione di opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri o inserite nell'elenco-anagrafe, di cui
all'art. 44-bis d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 213/2011, per le quali non si sia raggiunta un'intesa
in sede di conferenza di servizi, deve essere certamente ascritta
alla "programmazione di lavori pubblici" ed all'"approvazione dei
progetti a fini urbanistici ed espropriativi", le quali rientrano
nella materia di cui all'art. 117, comma 3, Cost. "governo del
territorio", che, nella lettura datane dalla Corte costituzionale a
far data dalla sent. 7 ottobre 2003, n. 307, "comprende, in linea di
principio, tutto cio' che attiene all'uso del territorio e alla
localizzazione di impianti o attivita'". Non senza aggiungere,
peraltro, che proprio l'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 163/2006 -
giudicato conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 401/2007 - dispone che, "relativamente alle materie
oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' normativa nel rispetto
dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice,
in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici,
approvazione dei progetti a fini urbanistici ed espropriativi,
organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile
del procedimento, sicurezza del lavoro". Essendo la materia "governo
del territorio" una materia di potesta' legislativa concorrente,
l'art. 4 del decreto c.d. Sblocca Italia appare del tutto illegittimo
nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento legislativo della
Regione, alla quale, invece, spetta, in tale materia, la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Nella parte in cui esclude dal Patto di stabilita' interno i
pagamenti connessi agli investimenti in opere di competenza dei
Comuni oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014, il comma 3
dell'art. 4 si pone in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost., la'
dove ascrive alla competenza legislativa concorrente la materia
"coordinamento della finanza pubblica". E' noto che la Corte
costituzionale ha inquadrato nella materia "coordinamento della
finanza pubblica" il c.d. Patto di stabilita' interno, vale a dire
quell'insieme di disposizioni legislative statali (spesso caotiche e
contraddittorie, contenute nella legge finanziaria - oggi di
stabilita' - o anche in altri provvedimenti legislativi, per lo piu'
emergenziali, se non altro nella forma) finalizzate a garantire il
rispetto da parte dell'Italia del Patto europeo di stabilita' (e
crescita). Sebbene la Corte costituzionale abbia dato
un'interpretazione piuttosto estensiva dei "principi fondamentali",
che lo Stato ha il potere di fissare in tale materia (anche
valorizzando gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.), e' vero pure,
tuttavia, che, "quanto ai requisiti delle norme statali recanti
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, questa
Corte ha individuato due condizioni: 'in primo luogo, che si limitino
a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di
un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della
spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo
strumenti o modalita' per il perseguimento dei suddetti obiettivi
(sent. n. 237 del 2009). I vincoli derivanti dal Patto di stabilita'
interno si applicano in modo uniforme a tutti gli enti territoriali
di una certa dimensione, trattandosi di una misura in qualche modo di
emergenza, che tende a realizzare, nell'ambito della manovra
finanziaria annuale disposta con legge, un obiettivo di carattere
nazionale (sentenza n. 36 del 2004)" (cosi', tra le piu' recenti,
Corte cost., sent. 6 novembre 2009, n. 384).
Se questi sono i principi che le disposizioni normative sul c.d.
Patto di stabilita' interno debbono rispettare, e' evidente che i
medesimi non sono affatto ottemperati dal comma 3 dell'art. 4,
peraltro anche qui per il completo esautoramento della Regione
dall'esercizio delle competenze legislative ad essa spettanti in
quella che, indubitabilmente, e' una materia di potesta' legislativa
concorrente.
Alla violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. consegue, de plano,
quella dell'art. 118 Cost., specialmente per il fatto che, prevedendo
una simile misura di agevolazione per i soli Comuni, l'art. 4 del
decreto c.d. Sblocca Italia finisce per ledere la potesta'
amministrativa regionale nel momento in cui la Regione intenda
attrarre al livello regionale le funzioni amministrative
astrattamente spettanti ai Comuni al fine di assicurarne l'esercizio
unitario e sempre nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
Analoghe censure devono essere rivolte al comma 5 dell'art. 4 del
decreto c.d. Sblocca Italia, laddove si avesse a ritenere che
l'espressione "enti territoriali" non si riferisca alle Regioni, ma
solo agli enti locali (Comuni, Province, Citta' metropolitane).
Quanto al comma 6, poi, evidente e' la sostanziale disparita' di
trattamento della disciplina tra le Regioni del Mezzogiorno e le
Regioni non del Mezzogiorno.
Come si e' visto, il comma 6 dell'art. 4 dispone che, con
riguardo all'anno 2014, "l'esclusione di cui al secondo periodo
dell'alinea del comma 5 e' destinata per 50 milioni di curo ai
pagamenti dei debiti delle regioni sostenuti successivamente alla
data del 1° luglio 2014, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici
gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti
dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni".
Ebbene, le entrate di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 20 d.lgs.
n. 625/1996 derivano dal versamento da parte dei titolari di
concessione di coltivazione di idrocarburi di un'aliquota del
prodotto della coltivazione. Ora, mentre alle Regioni a Statuto
ordinario non del Mezzogiorno e' corrisposta un'aliquota pari al 55%,
alle Regioni a Statuto ordinario del Mezzogiorno, invece, "e'
corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione
negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota
destinata allo Stato".
Stando cosi' le cose, evidente e' la disparita' di trattamento
(e, dunque, la violazione dell'art. 3 Cost.) tra la Regione Veneto
(Regione a Statuto ordinario non del Mezzogiorno) e le Regioni a
Statuto ordinario del Mezzogiorno, le quali piu' facilmente avranno
entrate rivenienti dall'applicazione dell'art. 20, commi 1 e 1-bis,
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100
milioni, e cio' in ragione del fatto che l'aliquota che il titolare
della concessione di coltivazione di idrocarburi dovrebbe
corrispondere allo Stato la versa alla Regione.
L'illegittimita' costituzionale del comma 9 dell'art. 4 discende
da quella dei commi 3 e 5, impugnati, dal momento che il comma 9
disciplina le modalita' di compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti, per quanto
qui interessa, dai commi 3 e 5.
Proprio la disparita' di trattamento tra le Regioni del
Centro-nord e quelle del Mezzogiorno consente di articolare, in
chiusura, la censura di violazione dell'art. 119 Cost., una
violazione che e' dato rinvenire, a parere della difesa,
nell'esorbitante residuo fiscale della Regione Veneto.
Come noto, "il residuo fiscale coglie il 'saldo' fra cio' che
ciascuna Regione riceve in termini di spesa pubblica e il suo
contributo in termini di prelievo fiscale, dove tale 'saldo'
sintetizza la diversa capacita' fiscale delle Regioni e, al tempo
stesso, i flussi redistributivi che livellano gli squilibri derivanti
dall'incapacita' di coprire la spesa geografica di pertinenza
(incapacita' dietro la quale si evidenziano i divari nello sviluppo
socio-economico)" (74) .
"Emblematico in tal senso e' [proprio] il caso del Veneto, che e'
stato oggetto di approfondita e dettagliata disamina in vari studi
condotti da Unioncamere del Veneto, da cui e' emerso come la
[p]ubblica [a]mministrazione spenda in servizi per il cittadino
residente in Veneto circa € 10.117 pro capite, a fronte di un
prelievo (pro capite) pari ad € 13.522 (media 2007-2009; Grafico 3).
Cio' significa che un cittadino del Veneto versa allo Stato [,]
tramite le imposte [,] una somma superiore di € 3.405 rispetto a
quanto (non) riceva dallo Stato stesso poi in termini di spesa
pubblica.
Per valore del residuo fiscale il Veneto si colloca al terzo
posto della graduatoria delle Regioni italiane in avanzo finanziario,
alle spalle della Lombardia (7.198 euro pro capite) e dell'Emilia
Romagna (4.203 euro pro capite). ... [Del] gruppo delle Regioni che
vantano un saldo fiscale positivo fanno parte anche Piemonte, Lazio,
Toscana e Marche. Fatta eccezione per Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige, Liguria, Umbria e Abruzzo, che registrano un
residuo fiscale molto contenuto (che indica un sostanziale equilibrio
fra entrate e spese), tutte le altre Regioni evidenziano un saldo
negativo.
Per comprendere appieno la stortura di tale sistema, e'
sufficiente raffrontare il dato del Veneto [,] appena segnalato [,]
con quello di una Regione del Mezzogiorno [,] come la Calabria; tale
Regione ha un residuo fiscale negativo, pari a € 2.797, ovverosia
ogni cittadino calabro versa allo Stato molto meno rispetto a quanto
riceve successivamente all'intervento perequativo.
Cio' significa che se i contribuenti veneti potessero trattenere
tutte le imposte che versano, potrebbero contare su una
disponibilita' di spesa media aggiuntiva pari a 16,6 miliardi
all'anno.
La maggiore disponibilita' di spesa produrrebbe l'aumento degli
investimenti del surplus di risorse sul territorio, con una
conseguente crescita del PIL locale, unitamente ad una presumibile
maggiore efficienza in tutti i settori.
Supponendo di 'spalmare', infatti, il residuo fiscale veneto
sulle varie funzioni di spesa, potremmo verificare che, volendo
citare solo qualche dato ipotetico, la spesa per la sanita' e
l'assistenza sociale potrebbe passare da € 1.344 pro capite a quasi
2.400; il budget investito in trasporti locali e infrastrutture
potrebbe aumentare dagli attuali € 399 pro capite sino a oltre € 700.
Il tutto senza aggravio per il contribuente.
Tale situazione si verifica a causa della normativa attuale in
tema di perequazione, che non riesce a sganciarsi da parametri come
quello della spesa storica, criterio che sembra premiare, piuttosto
chi spende di piu'.
Le risorse prelevate da Regioni ["]virtuose["] quali Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto vanno, infatti, a finanziare il fondo
perequativo[,] che viene utilizzato per ripianare i disavanzi
maturati dalle Regioni poco virtuose come Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria (75) .
Tutto cio', al fine di chiarire che, nel momento in cui il
residuo fiscale di una Regione raggiunge livelli quali quelli
materializzatisi nella Regione Veneto, ove, come si e' visto, il
singolo cittadino versa in media allo Stato oltre 3.500 € in piu'
rispetto a quello che riceve dallo Stato stesso, si verifica una
indiscutibile violazione dell'art. 119 Cost., il quale, pur
prevedendo meccanismi perequativi (commi 3 e 5), purtroppo abusati da
parte del legislatore statale (76) , chiaramente stabilisce al comma
2, e per quanto qui interessa, che le Regioni "dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio". Il comma 2 dell'art. 119 Cost., dunque, ha inteso
prevedere "un legame certo tra le risorse finanziarie e il territorio
che le ha prodotte, sia per ragioni di trasparenza, sia per questioni
che afferiscono alla maggiore responsabilizzazione da parte degli
amministratori" (77) .
Nel dare attuazione all'art. 119 Cost., il legislatore statale ha
voluto rendere espliciti i contenuti normativi di principio con la
legge 5 maggio 2009, n. 42. Nel fare cio', ha previsto, tra l'altro,
che l'uguaglianza e la solidarieta' non si concretizzino mai in
egualitarismo e in irresponsabilita'. Per questo, ha stabilito - in
particolare all'art. 2 - che il coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario rispetti l'esigenza di una "maggiore
responsabilizzazione" (comma 2, lett. a); sia coerente con il
"principio di territorialita'" e con il "rispetto del principio di
solidarieta' e dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed
adeguatezza" (comma 2, lett. e); consenta "proprie politiche di
bilancio da parte di Regioni ..." (comma 2, lett. f); sia funzionale
al "superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio
della spesa storica" (comma 2, lett. m), "in modo da favorire la
corrispondenza tra responsabilita' finanziaria e amministrativa"
.(comma 2, lett. p). Dunque, autonomia e responsabilita', che
presuppongono il rispetto di principi - anche formalmente di rango
costituzionale - quali sono i "principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza" (art. 118, comma 1, Cost.). E'
appena il caso di osservare che la lesione di queste regole
fondamentali comporta la violazione pure degli artt. 2, 3 e 97 Cost.:
vale a dire di solidarieta' attiva, di non-discriminazione e di
imparzialita', che grava sull'intero sistema delle autonomie locali.
Cio' si verifica, senza dubbio, quando il legislatore trascura le
differenze. Quanto alla Regione Veneto, ad esempio, per quel che
attiene all'apporto che la comunita' regionale da' alla Repubblica ex
art. 53 Cost., che determina un rilevante residuo fiscale, e per
quanto riguarda le politiche regionali aventi di mira la mitigazione
del rischio idrogeologico (vedi infra). La carenza di risorse
"adeguate", rispetto all'apporto positivo" dato dalla Regione Veneto
in termini di fiscalita', genera un cortocircuito, prodotto dalla
prassi, mai superata dallo Stato, di procedere "linearmente": a
prescindere da qualunque presupposto concreto, valutabile e
riscontrabile.
Evidente e', dunque, per tornare all'art. 4 del decreto-legge
c.d. Sblocca Italia qui impugnato, che, nel momento in cui si esclude
la Regione dal novero dei soggetti (tutti in posizione paritaria,
secondo la logica dell'art. 114, comma 1, Cost.) che possono fruire
di determinate agevolazioni finanziarie in ordine alla realizzazione
di opere pubbliche, prevedendosi, invece, che di tali agevolazioni
possano fruire solo i Comuni (qualunque sia la Regione di
appartenenza), si finisce per ledere, oltre ai precetti
costituzionali sopra richiamati, anche l'art. 119 Cost., tanto piu'
quando, come nel caso della Regione Veneto, la stessa abbia un
consistente residuo fiscale, vale a dire (e volendo usare
un'espressione piu' immediata) un consistente credito nei' confronti
dello Stato: piu' precisamente, della Repubblica.
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 2 e 3, d.l. n.
133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014, per
violazione degli artt. 2, 3, 97, 114, comma 1, 117, comma 3, 118 e
119 della Costituzione.
L'art. 7, del decreto-legge c.d. Sblocca Italia, (faticosamente)
rubricato "Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche
urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il
superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e
2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10
aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani;
finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi
d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di
esondazione e alluvione", reca due commi (2 e 3) che, secondo la
Regione Veneto, sono del tutto incostituzionali, per violazione dei
parametri indicati nell'epigrafe del presente motivo.
Il comma 2 dell'art. 7 stabilisce, in estrema sintesi, quanto
segue (si rinvia alla lettura integrale della disposizione per ogni
ulteriore dettaglio, vista anche la formulazione piuttosto
farraginosa):
(i) "a partire dalla programmazione 2015, le risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di
programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce
altresi' la quota di cofinanziamento regionale";
(ii) gli interventi in materia di mitigazione del rischio
idrogeologico "sono individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare";
(iii) "le risorse sono prioritariamente destinate agli
interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio
sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita',
ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e
della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei
rischi di alluvioni";
(iv) "a questo tipo di interventi integrati ... in ciascun
accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del
20 per cento delle risorse" e "nei suddetti interventi assume
priorita' la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture
potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumita'";
(v) "l'attuazione degli interventi e' assicurata dal
Presidente della Regione in qualita' di Commissario di Governo contro
il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalita', la
contabilita' speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
(vi) "gli interventi sul reticolo idrografico non devono
alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua,
bensi' tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di
adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale
adeguata".
Il comma 3 dell'art. 7 dispone, in estrema sintesi, quanto segue
(anche qui si rinvia alla lettura della norma per ogni ulteriore
dettaglio):
(i) "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole
dell'Autorita' di distretto territorialmente competente, provvede
alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e
agli altri enti con ... decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri ... per la realizzazione di interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non
e' stato pubblicato il bando di gara o non e' stato disposto
l'affidamento dei lavori, nonche' per gli interventi che risultano
difformi dalle finalita' suddette";
(ii) "l'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i
sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014";
(iii) "le risorse rivenienti dalle suddette revoche
confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono
riassegnate per la medesima finalita' di mitigazione del rischio
idrogeologico".
Il comma 2 dell'art. 7 del decreto legge c.d. Sblocca Italia
appare, innanzitutto, costituzionalmente illegittimo per violazione
dell'art. 117, comma 3, Cost., che ascrive alla potesta' legislativa
concorrente statale e regionale la materia "governo del territorio"
(la potesta' legislativa spetta alla Regione, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata allo Stato).
E' evidente, infatti, che disposizioni legislative statali in
materia di mitigazione del rischio idrogeologico, quali quelle
dell'art. 7 del decreto-legge c.d. Sblocca Italia sopra richiamate,
non possano essere inquadrate esclusivamente nella materia di
potesta' legislativa esclusiva dello Stato "tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali" (art. 117, comma 2, lett. s,
Cost.), come pur qualche giurisprudenza costituzionale ha ritenuto,
poiche' esse indubbiamente intersecano anche la materia - di potesta'
legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, Cost. - del "governo
del territorio": e' dimostrato, per esempio, dal fatto che il comma 2
dell'art. 7 puntualizza espressamente che, negli interventi integrati
cui fa riferimento, "assume priorita' la delocalizzazione di edifici
e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica
incolumita'".
Quando ci si trova dinnanzi ad intrecci di materie, di potesta'
legislativa esclusiva statale, da una parte, e di potesta'
legislativa concorrente (o residuale regionale), dall'altra, si
richiede il coinvolgimento della Regione attraverso opportune forme
di collaborazione della Regione interessata (cosi', si e' espressa la
Corte costituzionale in una pluralita' di sentenze, tra cui le nn.
62/2005, 247/2006, 278/2010 e 33/2011). Tanto impone il principio di
leale collaborazione, un principio che trova la sua genesi piu'
autentica proprio nell'art. 114, comma 1, Cost., il quale, stabilendo
che "la Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato", ha posto sullo
stesso piano Stato e Regioni (e finanche Comuni, Province e Citta'
metropolitane, i quali costituiscono un sistema di "autonomie
costituzionali") e, per l'effetto, ha improntato una "concezione
orizzontale-collegiale dei reciproci rapporti piu' che ... una
visione verticale-gerarchica degli stessi" (cosi', Corte cost., sent.
1° febbraio 2006, n. 31).
Il comma 2 dell'art. 7 viola certamente il principio
costituzionale di leale collaborazione tra Stato e Regione poiche'
dispone che gli interventi in materia di mitigazione del rischio
idrogeologico "sono individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare". Cio' vuol dire, evidentemente, che
non vi e' alcun coinvolgimento della Regione nell'individuazione
degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico.
A cio' si aggiunga che, proprio perche' ci si trova dinnanzi ad
una disposizione legislativa che intercetta la materia "governo del
territorio", in cui allo Stato e' preclusa la funzione legislativa di
dettaglio, non prevedendo la disposizione in questione alcuna forma
di coinvolgimento regionale, risultano ancor piu' costituzionalmente
illegittime sub-disposizioni alquanto dettagliate, tutte contenute
nel comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge c.d. Sblocca Italia, quali
le seguenti: "In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico
non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi
d'acqua, bensi' tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base
di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale
adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di
garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il
miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela
degli ecosistemi e della biodiversita', in ciascun accordo di
programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per
cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorita' la
delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente
pericolosi per la pubblica incolumita'".
Analoghe censure debbono essere rivolte al comma 3 dell'art. 7
del decreto-legge c.d. Sblocca Italia, in base al quale il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare revoca le
risorse assegnate alle Regioni "per la realizzazione di interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30
settembre 2014 non e' stato pubblicato il bando di gara o non e'
stato disposto l'affidamento dei lavori, nonche' per gli interventi
che risultano difformi dalle finalita' suddette". Prevede, inoltre,
la disposizione che "l'ISPRA assicura l'espletamento degli
accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30
novembre 2014".
In ordine a tale comma, deve essere evidenziata, peraltro, la
violazione degli artt. 3 e 97 Cost., perche' - si badi bene alle date
-, con decreto-legge del 12 settembre 2014, convertito, con
modificazioni, in data 11 novembre 2014, si individua come perentorio
il termine del 30 settembre 2014, stabilendosi che, se a tale data,
non si sia provveduto a pubblicare il bando di gara per l'affidamento
di lavori di realizzazione di interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico o non si siano affidati i relativi lavori, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla
revoca delle risorse assegnate alle Regioni per la realizzazione di
tali interventi. Nessuna verifica concreta in contraddittorio con la
Regione, nessuna considerazione dell'apporto positivo dato, ex art.
53 Cost., al concorso alle spese pubbliche. Si dispone solamente che
l'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi
necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Ora e'
ragionevole ritenere che l'ISPRA possa, in poco piu' di due mesi,
espletare tali accertamenti e sopralluoghi? Non e' forse ragionevole
ritenere che si trattera', nella migliore delle ipotesi, di
accertamenti e sopralluoghi piuttosto sommari e che si aprira' la
strada ad un contenzioso piuttosto acceso? V'e' piu' di una ragione
per ritenere che il disposto del comma 3 dell'art. 7 del
decreto-legge c.d. Sblocca Italia sia manifestamente irragionevole e
debba, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo (si
veda, a questo riguardo, Corte cost., sent. n. 236/2013).
Evidente e' pure la violazione del fondamentale art. 2 Cost., in
base al quale "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo", dal momento che la configurazione di un
potere sostanzialmente illimitato di revoca delle risorse assegnate
alle Regioni, per la realizzazione di interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico, mette in serio pericolo i diritti inviolabili
dei cittadini (e dei non cittadini), primo tra tutti il diritto alla
vita e quello alla salute (in ordine alla piena legittimazione della
Regione Veneto a sollevare censure di violazione degli artt. 2, 3 e
97 Cost., si rinvia a tutto quanto precisato a margine del primo
motivo).
Alla denunciata violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. consegue
de plano quella dell'art. 118 Cost.
In ordine, poi, alla violazione dell'art. 119 Cost., debbono
intendersi qui richiamate integralmente tutte le considerazioni sopra
svolte a margine del primo motivo di ricorso, rilevando che tale
precetto costituzionale e' indubbiamente leso nel momento in cui ci
si trova dinanzi ad una disposizione di legge statale che attribuisce
un potere sostanzialmente illimitato allo Stato di revoca di risorse
assegnate alle Regioni per la realizzazione di interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, senza prevedere alcuna
verifica concreta in contraddittorio con la Regione interessata e
senza tenere conto dell'eventuale residuo fiscale della Regione in
questione (residuo fiscale che, nel caso della Regione Veneto, e'
piuttosto consistente: pari a circa € 3.500 pro capite).
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 42, commi 1, 2, 3 e 4,
d.l. n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
164/2014, per violazione degli artt. 2, 3, 97, 117, comma 3, 118 e
119 della Costituzione.
I primi quattro commi dell'art. 42 del decreto-legge c.d. Sblocca
Italia recano una serie di disposizioni alquanto puntuali e
dettagliate "in materia" - cosi' recita la rubrica dell'art. 42 - "di
finanza delle Regioni".
Il comma 1 aggiunge, per quanto qui particolarmente interessa,
all'art. 46 (Concorso delle regioni e delle province autonome alla
riduzione della spesa pubblica) del d.l. n. 66/2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 89/2014, i commi 7-bis, 7-ter e
7-quater.
Il comma 7-bis dell'art. 46 d.l. n. 66/2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 89/2014, stabilisce che le Regioni a
Statuto ordinario sono tenute, per l'anno 2014, ad effettuare, fermo
restando il rispetto dei vincoli del Patto di stabilita' interno,
spese nei confronti dei beneficiari a valere su una serie di
autorizzazioni di spesa variamente previste dalla legislazione in
vigore (si rinvia alla lettura integrale della disposizione in
questione, vista anche la farraginosita' della stessa).
A sua volta, stando al comma 7-ter del medesimo art. 46, le
Regioni che risultino non aver effettuato integralmente la spesa,
versano all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non
effettuata.
In base al successivo comma 7-quater del medesimo art. 46, per
l'anno 2014 non si applicano le esclusioni dai vincoli del Patto di
stabilita' interno previste da una serie di disposizioni legislative
statali (anche qui si rinvia all'integrale lettura della disposizione
in questione per evitare di appesantire l'esposizione delle
doglianze).
E' evidente che ci si trova dinnanzi a disposizioni legislative
statali dettate in materia di "coordinamento della finanza pubblica",
ma eccedenti la natura di principi fondamentali e, pertanto,
costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 117, comma 3,
Cost., che attribuisce alla potesta' legislativa concorrente di Stato
e Regione la materia "coordinamento della finanza pubblica".
Non solo. Nel momento in cui si stabilisce - al comma 7-bis - che
le Regioni a Statuto ordinario sono tenute, per l'anno 2014 ad
effettuare spese nei confronti dei beneficiari a valere
sull'autorizzazione di spesa per le istituzioni scolastiche paritarie
(art. 46, comma 7-bis, lett. a), sull'autorizzazione di spesa per il
diritto allo studio (art. 46, comma 7-bis, lett. b) e
sull'autorizzazione di spesa per contributi e benefici a favore degli
studenti anche con disabilita' (art. 46, comma 7-bis, lett. c) - solo
per citarne alcune -, e' evidente che la disposizione legislativa in
questione interferisce con l'esercizio della potesta' legislativa
regionale nella materia - che e' concorrente e relativamente alla
quale allo Stato spetta solo la determinazione dei principi
fondamentali ex art. 117 comma 3 Cost. - dell'istruzione.
Venendo, poi, ai commi 7-ter e 7-quater dell'art. 46 del d.l. n.
66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, come
modificato dall'art. 42 d.l. n. 133/2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.164/2014, e' innegabile che essi ledono
l'autonomia finanziaria regionale nel momento in cui impongono alla
Regione di versare allo Stato la quota di spesa non effettuata tra
quelle di cui al comma 7-bis, tutte spese - come si e' visto -
afferenti a materie di potesta' legislativa concorrente. Ulteriore
lesione si ha nel momento in cui si dispone, per l'anno 2014, la non
applicazione di talune esclusioni dai vincoli del Patto di stabilita'
interno previste dalla vigente legislazione.
Insomma, l'autonomia finanziaria regionale, di cui all'art. 119
Cost., e' drasticamente mutilata, al punto tale da ridurre la Regione
Veneto, indipendentemente da qualunque valutazione circa i suoi
meriti e demeriti, ad una sorta di ordinatore secondario di spesa.
Pure a questo proposito si debbono richiamare integralmente tutte
le argomentazioni sopra svolte a margine del primo motivo di ricorso,
rilevando che l'art. 119 Cost. e' indubbiamente violato nel momento
in cui ci si trova dinanzi ad una disposizione di legge statale che
stabilisce, puntualmente e dettagliatamente, quel che la Regione puo'
e non puo', deve e non deve spendere in ambiti di materie riferibili
alla sua potesta' legislativa, anche solo concorrente; e cio' senza
prevedere alcuna verifica concreta, in contraddittorio con la Regione
interessata, e senza tenere conto dell'eventuale residuo fiscale
della Regione medesima. Il che - all'evidenza - si traduce in una
violazione degli artt. 3 e 97 Cost.: perche' l'omessa considerazione
di cio' che rappresenta un impiego produttivo delle risorse e' in
danno sia della Regione Veneto sia dello Stato: piu' precisamente,
della Repubblica.
Alla violazione degli artt. 117, comma 3, e 119 Cost. consegue,
de plano, la violazione dell'art. 118 Cost.
Le differenze di stile, ricostruttive e argomentative, esistenti
tra le premesse in diritto e le singole contestazioni rivelano che
ormai il degrado raggiunto dalla legislazione, priva di un qualunque
riferimento sistematico, rende pressoche' impossibile collegare tra
loro disposizioni di principio e disposizioni di dettaglio (78) . Il
dettaglio, infatti, ha preso il sopravvento, perche' e' prossimo a
quel che si puo' serenamente definire mansionario. E' nelle pieghe di
un mansionario che si insinuano le misure di favore oppure di
disfavore, le cui giustificazioni sono sempre rintracciabili in un
dato retorico, che non ha nulla a che fare con la realta'. Cosi',
rimane sistematicamente inevasa una domanda: possiamo continuare
ancora a sottrarre risorse ai territori produttivi? Evidentemente
si', se e' vero che l'art. 42, comma 5 e seguenti, del c.d. Sblocca
Italia si occupa, a parte, della Regione Sardegna e della Regione
Sicilia: quest'ultima, ormai ai limiti del collasso finanziario,
intenta, per altro, a pagare una legione di dirigenti. Perche' - come
si e' scritto di recente - "la Sicilia nei propri beni ha piu'
dirigenti del ministero - 306 contro 191 - comprese sovraintendenze e
siti. 'Colpa di una legge che in una notte del Duemila ha promosso
mille funzionari a dirigenti'" (79) . Ma non c'e' il vaglio di
costituzionalita? Ma non esiste il potere statale di coordinamento
della finanza pubblica? Non e' vero che questo genere di
"fattispecie" sono a carico - in nome di una solidarieta' nobile,
declinata in modo perverso - anche del contribuente che vive e paga
le imposte nella Regione Veneto e nelle altre Regioni? Non e' vero,
ancora, che tutto cio' distrugge ricchezza nazionale e impedisce gli
investimenti necessari per superare difficolta' oggi enormi? E poi -
dulcis in fundo - queste promozioni-provvidenze non hanno,
oltretutto, l'effetto di umiliare la stessa politica regionale
siciliana in materie che dovrebbero essere un volano dell'economia?
Domande retoriche, le cui risposte avviliscono. Intendiamoci: la
Regione Veneto non vuole dare lezioni a nessuno. Si e' limitata a
collegare tra loro riscontri che si possono considerare oggettivi. Lo
ha fatto pensando al Paese, oltre che a se stessa, in nome non tanto
di virtu' (80) , quanto di risultati valutabili in termini di dare ed
avere, intesi come interessi-valori da tutelare a livello
costituzionale.
E' qui che si inseriscono, appunto, le questioni di legittimita'
costituzionale che hanno di mira un dato disposto. Questioni che
rivelano la loro natura e la loro manifesta fondatezza se le si
colloca nell'ambito non tanto del confronto con un singolo parametro,
quanto con i capisaldi costituzionali dell'ordinamento. E le si
riporta, per valutarne il fondamento, a una realta' che ci dice -
sono, come si e' visto, le parole di Luca Ricolfi, ma anche di tanti
altri - di "un saccheggio silenzioso e invisibile che non puo' non
fiaccare la capacita' delle Regioni del Nord di produrre ricchezza,
ossia precisamente la materia prima su cui poggia la redistribuzione
a favore delle regioni deboli" (81) . Perche', alla fine, sara' un
danno - e una dannazione - per tutti.
(1) V., rispettivamente, M. Bertolissi, Contribuenti e parassiti in
una societa' civile, Jovene, Napoli, 2012, nonche' L. Hinna - M.
Marcantoni, Spending Review. E' possibile tagliare la spesa
pubblica italiana senza farsi male?, Donzelli, Roma, 2012.
(2) Paolo Sylos Labini, Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani, Ugo La
Malfa, Alessandro Pizzorno, Giorgio Galli e Alessandra Nannei,
Franco Reviglio, Roberto Convenevole. V. la successiva nota 3.
(3) L. Ricolfi, Il sacco del Nord. Saggio sulla giustizia
territoriale, Guerini e Associati, Milano, 2012, 91 e 92, il
quale prosegue richiamando una severa puntualizzazione di Giorgio
Galli e Alessandra Nannei: ' Le risorse assorbite dal lavoro
improduttivo sono state una delle cause determinanti del processo
involutivo che caratterizza il nostro Paese, e senza il loro
ridimensionamento non sara' possibile ripercorrere la strada
dello sviluppo ' (Il capitalismo assistenziale, 1976). I nomi
citati alla nota 2 sono ripresi da questo articolatissimo ed
argomentato saggio di Luca Ricolfi, al quale si fara' costante
riferimento nella redazione del presente atto. Lo scopo e' quello
di non far perdere di vista la realta', con cui deve fare i
conti, per primo, anche il giurista, secondo il limpido
insegnamento di C. Vivante, La riforma del codice di commercio,
in Nuova Antalogia, 1923, spec. 161-162. V. la nota 7. Per
sgombrare il campo da equivoci assai diffusi, che divengono,
molto spesso, argomenti difensivi dell'Avvocatura generale dello
Stato, e' bene non dimenticare che la lievitazione patologica del
debito pubblico (divenuto enorme) non puo' essere imputata alla
riforma costituzionale del 2001, essendosi formato, nella misura
a tutti nota, negli anni Ottanta del secolo scorso: v., ad es.,
I. Musu, Il debito pubblico. Quando lo Stato rischia
l'insolvenza, il Mulino, Bologna, 2012, e A. Friedman, Ammazziamo
il Gattopardo, Rizzoli, Milano, 2014, spec. 32 ss. V., altresi',
L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 94, la' dove scrive: Di qui
deficit pubblici sempre piu' ampi, che nel giro di una ventina
d'anni, grosso modo dal 1972 al 1992, porteranno il debito al
120% del PIL e l'Italia sull'orlo della bancarotta'
(4) F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, Tascabili
Newton, Roma, 1993, 373, nel capitolo dedicato a Machiavelli. La
frase intera suona cosi': Il fondamento scientifico di questo
mondo e' la cosa effettuale, come te la porge l'esperienza e
l'osservazione. Quanto a Machiavelli, e' appena il caso di
osservare che egli era a diretto contatto con la realta',
perche', ammoniva: Molti si sono immaginati repubbliche e
principati che non si sono mai visti ne' conosciuti nel mondo
reale. Ma c'e' una tale differenza tra come si vive e come si
dovrebbe vivere, che colui il quale trascura cio' che al mondo si
fa, per occuparsi invece di quel che si dovrebbe fare, apprende
l'arte di andare in rovina, piu' che quella di salvarsi (in Il
Principe, Bur, Milano, 1996, 78, nella versione in italiano
moderno, curata da P. Melograni)..
(5) Riflessioni critiche notevoli si possono leggere in L. Canfora,
Intervista sul potere, a cura di A. Carioti, Laterza, Roma-Bari,
2013. Le istituzioni non vivono librate in aria; stanno sulla
terra e danno ad essa un senso, che e' quello delle persone
fisiche e giuridiche che la calpestano.
(6) V., peraltro, alcuni severi giudizi espressi da L. Paladin,
Diritto regionale, Cedam, Padova, 2000, passim. V., soprattutto,
il magistrale saggio di G. Berti, Art. 5, in Commentario della
Costituzione, a cura di G. Branca, Zanichelli-Il Foro italiano,
Bologna-Roma, 1975, 277 ss., nonche' F. Benvenuti, Il nuovo
cittadino. Tra liberta' garantita e liberta' attiva, Marsilio,
Venezia, 1994.
(7) Qui si assume, dati i tempi ed i problemi da affrontare e
risolvere, il punto di vista reso esplicito da C. Vivante, La
riforma del codice di commercio, cit., 161-162, la' dove scrive
come, 'dopo tanto sforzo dialettico dei civilisti bisognava
riprendere il contatto colla realta' vivente. lo, e i miei
colleghi e discepoli, abbiamo considerato il diritto commerciale
come una scienza di osservazione; vivendo nei porti fra i
capitani, nelle aziende di assicurazione fra gli assicuratori;
nelle societa' fra amministratori ed azionisti, raccogliendo
tutti i frammenti che l'attivita' umana ci offriva, reputando che
nulla sia estraneo al diritto, perche' e' composto di tutti gli
elementi della vita. Abbiamo cercato la conoscenza dei fatti
fuori della logica, per poter poi costruire saldamente a rigore
di logica'. Dunque, prima di tutto, la conoscenza dei fatti, ad
es., attraverso le indagini condotte da Luca Ricolti, del quale
v., altresi', Illusioni italiche. Capire il Paese in cui viviamo
senza dar retta ai luoghi comuni, Mondadori, Milano, 2010, e La
Repubblica delle tasse. Perche' l'Italia non cresce piu',
Rizzoli, Milano, 2011.
(8) L. Paladin, Diritto regionale, cit., 233 ss., nonche' la
fondamentale sent. n. 271/1986 della Corte costituzionale. In
generale, per una visione d'insieme dei problemi cruciali del
regionalismo, ignorando i quali c'e' un unico sbocco: il
fraintendimento di ogni questione, v. G. Amato, Il sindacato di
costituzionalita' sulle competenze legislative dello Stato e
della Regione (alla luce dell'esperienza statunitense), Giuffre',
Milano, 1963; F. Bassanini, L'attuazione delle Regioni, La Nuova
Italia, Firenze, 1970; A. Barbera, Regioni e interesse nazionale,
Giuffre', Milano, 1973. Risalenti, al pari di altri, ma
fondamentali! .
(9) Chi scrive non ha mai creduto nella versione a sub tempo data del
federalismo fiscale: v., infatti, M. Bertolissi, Federalismo
fiscale: una nozione giuridica, in Fed fisc., n. 1/2007, 9 ss.;
Fiscalita' e forma di Stato: un appunto, ivi, n. 2/2007, 109 ss.;
La delega per l'attuazione del federalismo fiscale: ragionamenti
in termini di diritto costituzionale, ivi, n. 2/2008, 89 ss.; La
'funzione sovrana' del tributo, ivi, n. 1/2009, 15 ss.; Il
federalismo fiscale e la sua cronaca, ivi, n. 2/2010, 123 ss.; Un
imperativo categorico: spendere bene, ivi, 171 ss.; Il
bilanciamento tra solidarieta' e responsabilita' nell'ambito del
federalismo fiscale, n. 1/2011, 9 ss.; Stato sociale e
federalismo fiscale, ivi, n. 1-2/2012, 7 ss.
(10) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 179.
(11) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 180.
(12) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 181, il quale nota,
altresi', dopo aver ripreso una eloquente puntualizzazione di
Vilfredo Pareto: 'I territori che vivono di trasferimenti hanno
finito per soffocare i territori che producono. Il problema
pero', e' che per uscirne avremo bisogno di una classe politica
coraggiosa, capace di prendere atto del nocciolo del problema. E
il nocciolo del problema ... e' che il divario Nord-Sud e' solo
un divario di produzione, non di consumi e di tenore di vita.
Detto brutalmente: il Mezzogiorno non ha alcun interesse
immediato a cambiare uno stato di cose che, finora, gli ha
permesso di vivere largamente al di sopra dei propri mezzi'.
Luca Ricolfi - come lui dice di se' medesimo - ha avuto come
maestro Claudio Napoleoni; e' uno studioso ed intellettuale di
sinistra, ma non si riconosce nella posizione di quanti
ritengono che vi siano 'territori che hanno una sorta di diritto
naturale alla solidarieta' e territori che hanno il dovere di
concederla, sempre e comunque' (ivi, 25 e 27).
(13) L. Paladin, Presentazione di AA.VV., La prima legislatura
regionale 1970-1975, Giuffre', Milano, 1976, 3 ss.
(14) M. Draghi, Considerazioni finali, in Documenti de Il Sole 24
Ore, 1° giugno 2008, 11-12: 'Sul ritardo del Mezzogiorno pesa la
debolezza dell'amministrazione pubblica, l'insufficiente
attitudine alla cooperazione e alla fiducia, un costume diffuso
di noncuranza delle norme. Per il progresso della societa'
meridionale l'intervento economico non e' separabile
dall'irrobustimento del capitale sociale. La politica regionale
in favore del Mezzogiorno ha potuto contare nello scorso
decennio su un ammontare di risorse finanziarie comparabile con
quello dell'intervento straordinario soppresso nel 1992. I
risultati sono stati inferiori alle attese. La spesa pubblica e'
tendenzialmente proporzionale alla popolazione, mentre le
entrate riflettono redditi e basi imponibili pro capite che nel
Meridione sono di gran lunga inferiori. Si stima che il
conseguente afflusso netto verso il Sud di risorse intermediate
dall'operatore pubblico, escludendo gli interessi sul debito,
sia sull'ordine del 13 per cento del prodotto del Mezzogiorno,
il 3 per cento di quello nazionale. E' un ammontare imponente;
per il Sud, e' anche il segno di una dipendenza economica
ininterrotta'. Sic! Un tal genere di puntualizzazioni tronca sul
nascere ogni polemica. Del resto lo stesso Presidente della
Repubblica e' stato severo censore: v. G. Battistini, Napolitano
striglia i politici: 'Colpa vostra il degrado al Sud', in la
Repubblica, 3 dicembre 2008, 12; C. Giannini, Napolitano: il Sud
faccia autocritica o e' fuori gioco, in Il Gazzettino, 3
dicembre 2008, 4, nonche' A. Garibaldi, Napolitano: il Sud non
ha retto alla prova dell'autogoverno, in Corriere della Sera, 4
ottobre 2009, 8. Certo, oggi la politica, tutta, e' all'angolo,
come osserva A. Schiavone, Non ti delego. Perche' abbiamo smesso
di credere nella loro politica, Rizzoli, Milano, 2013. Ma,
proprio per questo, e' necessario che la Magistratura che e'
garante della Costituzione dia il suo contributo, rivedendo
orientamenti consolidati non piu' idonei a porre rimedio ai
problemi del Paese: che sono di tutti e la Regione Veneto li
espone cosi'.
(15) E' piu' che sufficiente rinviare, senza commento di sorta, a F.
Fubini, Capitale brucia-miliardi. 'Cosi' Roma affonda in un
default pagato da tutta Italia', in la Repubblica, 28 novembre
2014, 1 e 30. Questo e' il frutto malato di una solidarieta' a
senso unico, irresponsabile, che ha consentito a Roma-capitale,
come rileva la Corte dei conti, di continuare 'a spendere
troppo, lo Stato si e' accollato i suoi debiti ma la citta' ha
fallito il risanamento. E divora oltre cinquecento milioni
l'anno dei contribuenti nazionali'. Vogliamo cambiare registro?
V. P. Buttafuoco, Bruttissima Sicilia. Dall'autonomia a
Crocetta, tutta una rovina, Bompiani, Milano, 2014. Le prime
parole sono queste: 'Adesso basta. Qualcuno - Matteo Renzi? -
dica basta, perche' l'autonomia sara' cosa santa e giusta
ovunque ma in Sicilia no, e' un flagello e trascina nel baratro
l'Italia. Li' l'autonomia regionale, fonte di sprechi e
burocrazia, e' l'acqua che nutre l'arretratezza economica e
sociale di un pezzo importante del Meridione. Ed e' la fogna in
cui nuota la mafia'. Nessuno ha in tasca la verita', ma si
tratta di discorsi che risalgono alla notte dei tempi: v., ad
es., tenendo conto della questione qui affrontata, G. Demaria, I
motivi fondamentali della industrializzazione regionale, in
AA.VV., Gli squilibri regionali e l'articolazione
dell'intervento pubblico, Lerici editori, Milano, 1962, 13 ss.
Tra l'altro, nel criticare talune prese di posizione della Corte
costituzionale di allora, notava che 'il terreno formale su cui
sta sorgendo l'edificio della nuova economia deve essere ben
diverso e deve in ogni caso essere piu' forte l'influenza
esercita dalla situazione e dagli obiettivi economici' (ivi,
25): perche' sono questi ultimi che vanno salvaguardati.
(16) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 14-15.
(17) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 20.
(18) M. Bertolissi, Federalismo fiscale: una nozione giuridica, cit.,
27 ss..
(19) F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, cit., 373..
(20) E' il sottotitolo - come si e' visto - di L. Ricolfi, Il sacco
del Nord, cit.
(21) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 181.
(22) I tempi attuali registrano evidenti motivi di malessere nei
confronti dei poteri locali. Le inchieste ne pongono in luce una
mala gestio davvero diffusa ed ingiustificabile. Purtroppo,
pero', questo e' un problema che coinvolge l'Italia in ogni sua
componente: riguarda tutte le istituzioni territoriali della
Repubblica e - cio' che conta - il cittadino, il quale e', ad
es., evasore oltre il limite della decenza. V. infra.
(23) Da parte di chi ha stimato in 50 miliardi di euro l'anno le
cifre 'degli sprechi, dell'evasione fiscale, e soprattutto
dell'immane trasferimento di risorse da Nord a Sud': L. Ricolfi,
Il sacco del Nord, cit., 15. Quel che conta non e' che la
quantificazione sia esatta - ve ne sono tante, tutte opinabili,
da questo punto di vista -, ma che un rilevante differenziale
esista; e questo nessuno lo mette in discussione, come ha notato
M. Draghi, Considerazioni finali, cit., 11-12 (v., infatti, la
nota 14).
(24) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 15.
(25) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 17.
(26) Si riprenderanno - lo si e' gia' dichiarato - alcune rilevazioni
di L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., perche' sono suffragate
da rigorosi riscontri e perche' sono, oltre cio' che e'
opinabile, trasparenti. In ogni caso, e' la realta' che parla, a
chiunque, senza mediazioni. La realta' e' quella rappresenta,
con un vigore che fa riflettere, ad es., da F. Camon, Un popolo
che ha ucciso la speranza, in il mattino di Padova, 28 dicembre
2014, 8 (la sintesi e': 'Niente meritocrazia, corruzione
dilagante. Sta crescendo una generazione di emigranti'). E' meta
diritto? E' diritto il combinato disposto?
(27) Per dirla con S. Trentin, La crisi del Diritto e dello Stato,
prima edizione italiana a cura di G. Gangemi, Gangemi Editore,
Roma, 2006, 198.
(28) 'E abbiamo bisogno di scegliere una prospettiva: non esiste mai
il paesaggio in se', ma solo il paesaggio osservato da una certa
angolatura, con una certa luce, con un certo strumento di
osservazione piu' o meno sofisticato, dall'occhio umano fino
agli occhiali a raggi infrarossi. Ecco, l'idea centrale di
questo libro non e' di fornire una spiegazione per i mali
dell'Italia, e nemmeno di suggerire una terapia, ma
semplicemente di offrire al lettore uno strumento nuovo di
osservazione, un paio di lenti che permettano di vedere cose
che, con gli strumenti di osservazione tradizionali proprio non
si vedono'. Cosi', L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 35, il
quale aggiunge: 'Per 'strumenti di osservazione tradizionali'
intendo, essenzialmente, gli schemi con cui la contabilita'
nazionale rappresenta e descrive i suoi squilibri territoriali.
La mia idea e' che, finche' si adottano tali schemi, e'
impossibile vedere quel che c'e' da vedere. La contabilita'
nazionale mostra tante cose, ma ne nasconde molte altre, proprio
quelle piu' importanti. Di qui l'idea di cambiare occhiali,
ossia di passare a uno schema di contabilita' nazionale diverso:
la contabilita' nazionale liberale'. Ecco: la Regione Veneto,
per il tramite della sua odierna difesa, chiede alla Corte
costituzionale di 'cambiare occhiali'. In questa prospettiva,
poco o nulla valgono i precedenti.
(29) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 36.
(30) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 37.
(31) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 43. Annota, quindi: ' Il
punto e' che, grazie al tasso di parassitismo ?, e grazie agli
indici di interposizione pubblica ad esso strettamente connessi,
molte cose che nelle pieghe della contabilita' standard restano
nascoste diventano immediatamente visibili. Ad esempio un
sistema economico-sociale soffoca perche' il suo tasso di
parassitismo e' salito troppo. Quando un paese vive al di sopra
dei suoi mezzi, perche' il suo reddito disponibile eccede il
reddito da esso prodotto. Quando un territorio sembra produrre
reddito, ma in realta' consuma il reddito prodotto da altri
territori '.
(32) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 45, ove si legge, altresi':
'Per non parlare dell'aspetto territoriale del problema: se mai
qualcuno dovesse prendere sul serio la missione ultima del
federalismo, ossia riportare in equilibrio i conti dei
territori, difficilmente potrebbe esimersi dal ristabilire un
minimo di uniformita' nei tassi di evasione fiscale,
possibilmente conducendoli verso quelli dei territori virtuosi'.
A proposito dell'evasione, v. A. Santoro, L'evasione fiscale.
Quanto, come e perche', cit., nonche' M. Bertolissi,
Contribuenti e parassiti, cit.; AA.VV., Evasione fiscale e 'tax
compliance', a cura di A. Gentile e S. Giannini, il Mulino,
Bologna, 2012, e G. Bergonzini, Evasione fiscale: un problema di
diritto costituzionale, in Fed. fisc., n. 2/2011, 153 ss. Ma la
lezione piu' alta e' di P. Gobetti, La rivoluzione liberale.
Saggio sulla lotta politica in Italia, Einaudi, Torino, 1974,
157 ss.
(33) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 49. Quel che accade in
sanita' e' noto a tutti, con l'aggravante che a maggiori spese
corrispondono, il piu' delle volte, peggiori servizi. In ogni
caso sul punto - della sottoproduzione e dello spreco - 'la
contabilita' nazionale e' muta' e cio' impedisce 'una
riorganizzazione della spesa'. Al riguardo, c'e' qualche segnale
positivo manifestatosi 'ultimamente' (ivi, 49 e 50).
(34) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 52. Ma 'le differenze di
prezzo ... contano molto. Se si vuole fornire una ricostruzione
accurata degli squilibri territoriali, non si puo' fare come se
non esistessero o fossero trascurabili. A maggior ragione se il
federalismo fiscale dovesse basarsi, come sembra, anche su
principi di solidarieta' e perequazione fra aree forti e deboli.
In qualsiasi politica di riequilibrio che si proponesse di
aiutare o compensare le zone piu' svantaggiate, un ragionevole
calcolo dell'entita' dello 'svantaggio' dovrebbe certo tenere
conto dei consumi pubblici, che sono sensibilmente attenuati
da σ (il tasso di sottoproduzione e spreco), ma anche dei
consumi privati, che sono sensibilmente modificati da λ, il
livello dei prezzi' (ivi, 54). Tutto cio' non ha costituito,
sino ad ora, argomento di discussione, ancorche' riguardi il
'tenore di vita di una popolazione' (ivi, 52): detto nella
prospettiva e con il linguaggio del diritto costituzionale,
ancorche' riguardi le liberta' e i diritti previsti e garantiti
dalla Parte I della Legge fondamentale, alla cui tutela la
Regione partecipa - e' obbligata a partecipare - quale
componente essenziale della Repubblica (art. 114 Cost.), secondo
l'ordine delle sue attribuzioni-funzioni costituzionali. Questa
e' la prospettiva di chi pensa, piuttosto che a un Paese
formalmente unitario, a un Paese sostanzialmente coeso: che e'
ben altro!
(35) Quella, ad es., che L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., spec.
61 ss., denomina - come si e' accennato - 'contabilita'
nazionale liberale'.
(36) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 61-62, spiega perche' la
contabilita' nazionale ignora questi problemi.
(37) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 65 e 67.
(38) Spiegato, con dovizia di argomenti, da L. Ricolfi, Il sacco del
Nord, cit., 75 ss., e con grande onesta' intellettuale. Infatti
- osserva -, 'chiarito che il prodotto per abitante del
Mezzogiorno e' poco piu' della meta' di quello del Centro-nord,
ci resta da capire l'origine di questa minore capacita' di
generare ricchezza. Su questo, ovvero sul perche' in
centocinquant'anni il Sud non sia riuscito ne' a colmare ne' ad
accorciare sensibilmente il divario con il Nord, le opinioni
divergono, spesso in funzione delle convinzioni ideologiche di
chi le esprime. Il guaio, pero', e' che anche i dati divergono'
(ivi, 78). Tuttavia, vi sono dati che contengono in se' un
qualche principio di prova e di spiegazione. Ad es., perche', a
parita' di popolazione, i 'costi della politica' (trasferimenti
a organi istituzionali) sono di oltre 137 milioni di euro l'anno
per la Sicilia, mentre il Veneto spende poco piu' di 39 milioni?
Perche' la Calabria destina - sempre nel 2014 - a manifestazioni
e convegni quasi 6 milioni di euro e il Veneto 415.050 euro? V.,
infatti, E. Lauria, Spese delle Regioni. Sicilia maglia nera ma
per le consulenze record in Piemonte, in La Repubblica, 27
dicembre 2014, 13. Qui, ancora una volta, non c'e' alcun intento
polemico. Si evidenziano piccole differenze, cui possono
corrispondere grandi differenze, causate dal modo - lineare ed
irresponsabile - con cui lo Stato pensa e compone la finanza
delle Regioni, a tutto danno della produttivita' dei territori a
forte vocazione innovativa. Non e', forse, un caso di palese
violazione della potesta' statale di coordinamento della finanza
pubblica (artt. 117, comma 3, e 119, comma 1, Cost.), che non a
caso la Legge fondamentale attribuisce allo Stato, che questo
ossessivamente rivendica, e che, poi, in concreto non attua o
attua malamente?
(39) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 83.
(40) M. Draghi, Considerazioni finali, cit., 11-12.
(41) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 86. Per togliere spazio ad
ogni polemica preconcetta, si pensi alla migrazione in sanita':
al fenomeno per cui l'abitante di una Regione si trasferisce,
per curarsi (per rendere concreto il diritto costituzionale alla
tutela della propria salute, ex art. 32 Cost.), in altra
Regione.
(42) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 89. Del resto - e' un
rilievo che proviene da chi ha grande dimestichezza con la
societa' e le istituzioni italiane -, si e' sottolineato che 'la
pubblica amministrazione e' stata travolta dalla
'meridionalizzazione dello Stato' ... I meridionali sono
portatori di una cultura giuridica che prevede il primato della
forma sul contenuto. Il risultato non conta. E' una cultura
impastata di garanzie e di tranquillita', di non decisioni e di
scarsa responsabilita', di molta burocrazia e poca efficienza,
di continuita' e mai di rottura. Siamo, in una parola, alla
negazione dei valori borghesi, al loro esatto contrario. Scrive,
in proposito, Giuliano Amato: 'il nostro peccato originale e'
stato quello di una borghesia che non ha considerato suo il
problema dello Stato e lo ha abbandonato nelle mani dei figli
dei poveri'. Si tratta di un giudizio che, a una prima lettura,
puo' sembrare ingeneroso e sommario, ma ... lo Stato
ottocentesco ... si e' trasformato in un contenitore di
funzioni, facile da occupare, dove tutto si e' appiattito verso
il basso': cosi' G. De Rita - A. Galdo, L'eclissi della
borghesia, Laterza, Roma-Bari, 2011, 28.
(43) Consideri, l'ecc.ma Corte, che l'atto normativo primario che si
impugna contiene pure disposizioni di favore per la Sicilia e la
Sardegna: le quali sono si Regioni speciali, ma non esentate dal
rispetto di cio' che dispongono, ad es., gli artt. 2 e 3 Cost.
(44) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 95 e 96. Incide sulle
attivita' produttive dei territori gravati dal parassitismo di
altri oppure no? E' naturale che si!
(45) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 98.
(46) Lo sanno tutti.
(47) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 99-100. Poco oltre si
occupa di un''obiezione molto frequente fra i difensori delle
buone ragioni del Mezzogiorno', osservando che si fonda su una
'lettura vagamente sovietica della Costituzione', fondata
sull'art. 2 Cost. (ivi 101), e discute criticamente 'quattro
piccoli trucchi statistici che permettono di pilotare il
risultato, costruendo la sorpresa di un Sud che, anziche'
assorbire risorse eccessive, ne riceve invece troppo poche'
(ivi, 102). E' da ricordare - perche' e' di rilievo
discriminante - che la contabilita' nazionale liberale non
considera tutta la spesa pubblica corrente, ma soltanto quella
discrezionale (e se ne spiegano le ragioni: ivi, 104 e passim).
Cio' consente di rendere evidente che 'nel Sud sono elevati, al
tempo stesso, la quota di spesa pubblica allocata in stipendi e
sussidi, il parassitismo puro, i tassi di sottoproduzione e
spreco. Nel Nord accade esattamente il contrario: spesa pubblica
orientata agli acquisti, basso parassitismo, sprechi contenuti.
Al Nord si spreca poco, e la spesa pubblica pro capite e'
modesta non solo rispetto al prodotto pro capite ma anche in
cifra assoluta' (ivi, 105-106).
(48) Si chiede e risponde L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 115.
(49) Delle quali vi e' un'encomiabile consapevolezza: L. Ricolfi, Il
sacco del Nord, cit., 115 ss.
(50) Ovviamente, i dati non sono del 2014, perche' risalgono
addirittura a prima della crisi del 2007-2008. Tuttavia, poiche'
sono in molti a sostenere che l'evasione e' addirittura
cresciuta negli anni piu' recenti, dal momento che si evade
anche per sopravvivere e perche' la tassazione complessiva e'
divenuta ormai insostenibile, ne viene che le stime qui riprese
sono ancor piu' significative: infatti, gli squilibri
territoriali non possono essere che aumentati. Merita una
attenta considerazione quel che ha scritto F. Gallo, Le ragioni
del fisco. Etica e giustizia nella tassazione, il Mulino,
Bologna, 2007, 15-17, in specie la' dove nota che 'la pressione
fiscale 'effettiva' sui contribuenti 'onesti' sarebbe, poi, del
50,70% a fronte di quella 'apparente' del 41,42%'. Eravamo nel
2007!
(51) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 119.
(52) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 119-120.
(53) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 121-122. V., inoltre, A.
Santoro, L'evasione fiscale, cit., in specie la' dove sottolinea
quale e' stata 'l'influenza che l'evasione ha avuto nel nostro
paese sulla crescita del debito pubblico' (ivi, 26). E' un
problema di diritto costituzionale o no?.
(54) V. la nota 4.
(55) E. Passerin D'Entreves, Gli aspetti storici degli squilibri
regionali, in AA. VV., Gli squilibri regionali, cit., 271. Si
deve osservare, poi, che 'questi dati [sull'evasione fiscale]
non sarebbero cosi' drammatici se, nel suo complesso, la
pressione fiscale fosse in Italia a livelli ragionevoli. In tal
caso il peso che le regioni del Nord sopportano per sostenere i
consumi, pubblici e privati, del resto del Paese potrebbe essere
considerato un doveroso tributo alla solidarieta' e alla
coesione sociale. Ma il punto e' che la pressione fiscale
corrente [non e' quella del 2014, ancora superiore] e'
enormemente aumentata nell'ultimo trentennio, passando dal 31,3%
del 1980 al 42,7% del 2008 secondo la contabilita' ufficiale'.
V. la nota 50.
(56) Qui, infatti, quel che conta sono il problema e l'esistenza di
forti scostamenti tra cio' che un territorio e un contribuente
danno e ricevono. Se le somme sono, nei fatti, a saldo attivo
oppure negativo, e' chiaro che si pongono questioni
costituzionali evidenti. Si citeranno varie fonti - oltre a
quelle elaborate da Luca Ricolfi - e si vedra' che, a
prescindere dalle quantificazioni variabili, quel che appare una
costante e' l'esistenza di squilibri territoriali, nei termini
suesposti. In ogni caso, secondo L. Ricolfi, Il sacco del Nord,
cit., 159, 'definito in modo non sempre identico in tutti gli
studi, il residuo fiscale pro capite di un territorio e' la
differenza fra cio' che il suo cittadino medio paga sotto forma
di tasse e contributi e cio' che riceve sotto forma di spesa
pubblica'. Ricorda, con l'occasione, uno studio esemplare della
Fondazione Agnelli, elaborato su dati del 1989.
(57) Staderini e Vadala', di cui parla L. Ricolfi, Il sacco del Nord,
cit., 161. Per non dire di una ricerca Formez su dati 1986 e di
un lavoro di Francesco Forte su dati del 1973. Il volume di AA.
VV., Gli squilibri regionali, cit., raccoglie indagini risalenti
al 1961! Di recente, se ne e' occupato L. Antonini, Federalismo
all'italiana, Marsilio, Venezia, 2013.
(58) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 161.
(59) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 162-163, ne spiega i
difetti e chiarisce perche' preferisce, a quella nozione, quella
di 'teoria della giustizia territoriale'.
(60) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 163. Analogamente,
nell'ottica del diritto costituzionale, M. Bertolissi,
Federalismo fiscale: una nozione giuridica, cit.
(61) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 163 e 164. Quanto di piu'
scontato vi sia!
(62) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 164-165.
(63) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 168.
(64) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 168 e 169.
(65) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 172, il quale sottolinea la
circostanza che 'le regioni attive sono tutte al Nord eccetto
Toscana e Marche, mentre il Sud ha solo regioni passive. La
regione con il credito piu' alto (11,4% del proprio PIL market)
e' la Lombardia, seguita da Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, e
poi - molto vicine al pareggio - Toscana, Marche, Friuli-Venezia
Giulia. Le due regioni con il debito maggiore (22,3%) sono le
due isole, Sicilia e Sardegna, entrambe a statuto speciale,
seguite a ruota da Calabria, Basilicata, Valle d'Aosta, Molise,
e poi - con debiti via via decrescenti - Campania, Puglia,
Lazio, Liguria, Umbria, Trentino-Alto Adige e infine Abruzzo, la
regione meridionale con i conti meno in disordine'. Queste
conclusioni sono suffragate da altre ricerche che divergono
soltanto per quantita' numeriche, come e' naturale avvenga in
questo genere di contesti. Salva rerum substantia, pero!
(66) Ci si permette di rinviare a M. Bertolissi, L'autonomia
finanziaria regionale. Lineamenti costituzionali, CEDAM, Padova,
1983.
(67) S. Holmes - S.R. Sunstein, Il costo dei diritti. Perche' la
liberta' dipende dalle tasse, il Mulino, Bologna, 2000.
(68) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 14 ss.
(69) V. sub 4.
(70) In base a tale disposizione, per 'opera pubblica incompiuta' si
intende l'opera non completata: a) per mancanza di fondi; b) per
cause tecniche; c) per sopravvenute nuove norme tecniche o
disposizioni di legge; d) per il fallimento dell'impresa
appaltatrice; e) per il mancato interesse al completamento da
parte del gestore; f) in tutti i casi in cui un'opera non
risponda a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal
relativo progetto esecutivo e che non risulti fruibile dalla
collettivita' (art. 44-bis, commi 1 e 2, d.l. n. 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2011).
(71) 'I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto
capitale: a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31
dicembre 2013; b) per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013; c)
riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che
presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita'
entro la medesima data'.
(72) Il d.lgs. 25 novembre 1996, n. 625, recante 'Attuazione della
direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di
esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi', dispone, ai commi 1 e 1-bis
dell'art. 20 (rubricato 'Destinazione delle aliquote alle
regioni a statuto ordinario'), quanto segue: '1. Per le
produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ciascuna
concessione di coltivazione situata in terraferma il valore
dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 [il cui comma 1
dispone che, 'per le produzioni ottenute a decorrere dal 1°
gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di
coltivazione e' tenuto a corrispondere allo Stato il valore di
un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della
quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in
terraferma, e al 7% della quantita' di idrocarburi gassosi e al
4% della quantita' di idrocarburi liquidi estratti in mare'] e'
corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il
15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo
sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche,
all'incremento industriale e ai interventi di miglioramento
ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche
e le coltivazioni. 1-bis. A decorrere al 1° gennaio 1999, alle
regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno e' corrisposta, per
il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata
nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata
allo Stato'.
(73) Alle suddette compensazioni si provvede come segue: 'a) quanto a
29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente
utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla
sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli
articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi
da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini
dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta
sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato; b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno
2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai
pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite
di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per
l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno
2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni; d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2014, a
valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30
giugno 2014 di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183'.
(74) Cosi' B. Baldi, Differenziazione regionale e federalismo
fiscale, in (a cura di) L. Vandelli - F. Bassanini, Il
federalismo alla prova: regole, politiche, diritti nelle
Regioni, il Mulino, Bologna, 2012, 423 ss., spec. 435.
(75) 'Cosi' G. A. Bellati, Il riparto del gettito. Problemi e
prospettive, in (a cura di) F. Palermo - M. Nicolini,
Federalismo fiscale in Europa. Esperienze straniere e spunti per
il caso italiano, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012,
201 ss., spec. 207 ss., il quale rileva, altresi', quanto segue:
'E, nonostante i maggiori trasferimenti, il livello di sviluppo
economico del Sud non e' certo migliorato. Secondo il rapporto
Svimez 2009 [SVIMEZ, Rapporto 2009 sull'economia del
Mezzogiorno, Roma 2009, in www.svimez.it] dall'inizio del
decennio il Sud e' cresciuto meno del Centro-Nord, cosa che non
e' mai accaduta dal dopoguerra ad oggi, e il divario in termini
di PIL pro capite e' rimasto sostanzialmente invariato, attorno
al 58,6% di quello del Centro Nord, anziche' ridursi come
sarebbe logico aspettarsi da un sistema di flussi redistributivi
fra le aree piu' ricche e quelle meno ricche del Paese. Inoltre,
sempre secondo Svimez, se nel 1951 nel Mezzogiorno veniva
prodotto il 23,9% del Pil nazionale oggi la quota e' rimasta
sostanzialmente immutata (23,8%). In sostanza in sessant'anni il
Sud, pur crescendo circa agli stessi ritmi del Centro-Nord, non
e' riuscito e non riesce a recuperare il gap di sviluppo.
Quest'enorme 'spreco' di risorse non si e', quindi, tradotto in
un vero aiuto alle realta' produttive e sociali, ma ha
alimentato inefficienza, sprechi e rendite di vario tipo. E'
questo, soprattutto, che rende inaccettabile l'assetto attuale:
sotto la giustificazione della solidarieta' si cela, spesso,
tutt'altro'. Dati dello stesso tenore di quelli raccolti da
Unioncamere del Veneto si rinvengono in Baldi, Differenziazione
regionale e federalismo fiscale cit., 435 ss. Sul punto si
vedano anche (sempre per i dati economico-statistici di
riferimento) A. Staderini - E. Vadala', Bilancio pubblico e
flussi redistributivi interregionali: ricostruzione e analisi
dei residui fiscali nelle Regioni italiane, in (a cura di) L.
Cannari, Mezzogiorno e politiche regionali, Banca d'Italia
Eurosistema, novembre 2009, 597 ss.
(76) Si veda sul tema, tra gli altri, C. Tubertini, Risorse
economiche come elemento di uniformazione, in Il federalismo
alla prova, cit., 407 ss.
(77) Cosi', G.A. Bellati, Il riparto del gettito cit., 213. Si veda,
in argomento, anche E. Corali, Federalismo fiscale e
Costituzione. Essere e dover essere in tema di autonomia di
entrata e di spesa di Regioni ed Enti locali, Giuffre', Milano,
2010, 127 ss.
(78) V., in proposito, le riflessioni, tanto limpide quanto
persuasive, delineate da V. Italia, Le malattie delle leggi,
Giuffre', Milano, 2014.
(79) A. Fraschilla, Sicilia, l'ultima beffa. 300 dirigenti nei musei
ma non ci sono soldi per le lampadine, in la Repubblica, 16
novembre 2014, 21. Tuttavia, e' bene ammettere che vale sempre
l'ammonimento evangelico del 'Chi e' senza peccato scagli la
prima pietra!'. Infatti, se puo' affermare G. Santilli,
Mezzogiorno con il motore al minimo, in Il Sole 24 Ore, 30
dicembre 2014, 10, e' vero, altresi', che puo' scrivere G.
Ferraino, Dipendenti pubblici, a Trento costano il triplo che a
Catanzaro, in Corriere della Sera, 7 gennaio 2015, 30, a
testimonianza del fatto che, dovunque, possono annidarsi rendite
di posizione. Ma altro e' - come si e' accennato - l'ordine
'nazionale' dei problemi qui posti, in una prospettiva sia
generale (sub I) sia particolare (sub II), che puo' essere letta
in termini di residuo fiscale oppure, ancor meglio, di teoria
della giustizia territoriale. Spunti di sicuro interesse si
possono ricavare dalla lettura del Rapporto sulla situazione
sociale del Paese 2014, elaborato dal Censis, Franco Angeli,
Milano, 2014. Vale la pena di riprendere un passo delle
Considerazioni generali, che non e' neppure il caso di
commentare, data la sua estrema evidenza: 'In una societa' senza
ordine sistemico i singoli soggetti sono a dir poco a disagio:
non capiscono dove si collocano, negli anfratti o nei relitti di
un assetto sistemico che essi ritengono comunque necessario;
soffrono tutti gli effetti negativi, anche psicologici, della
crisi radicale delle giunture sistemiche; e si sentono alla fine
abbandonati a se stessi (vale per il singolo imprenditore come
per la singola famiglia), in una obbligata solitudine. - Il
sistema finisce per esser vissuto come cosa estranea e resta
solo potenziale oggetto di rancore e di denuncia. Con la
conseguenza inevitabile che tale estraneita' porta a un
fatalismo quasi cinico (tanto, tutto e' fuori controllo e
nessuno riesce a padroneggiarlo) e talvolta anche a episodi di
secessionismo sommerso, ormai spesso presente in varie regioni e
realta' locali, specie al Sud'. Sic!
(80) 'Virtuoso e no' sono attributi del lessico ordinario, dovuti a
cio' che la quotidianita' rivela. Qualcuno puo' anche
rammaricarsi. Ma il rammarico va ricondotto alle cause che hanno
generato simili nuovi atteggiamenti psicologici ed espressioni
un tempo ignote.
(81) L. Ricolfi, Il sacco del Nord, cit., 172, gia' ripreso sub 5, in
fine.
P.Q.M.
La Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta regionale, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata,
Chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia:
dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9; 7, commi 2 e 3; 42, commi 1, 2, 3 e 4,
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, rubricato "Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive", convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata nel Supplemento ordinario
n. 85 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262
dell'11 novembre 2014, per violazione degli artt. 2, 3, 97, 114,
comma 1, 117, comma 3, 118 e 119 della Costituzione.
Padova-Venezia-Roma, 8 gennaio 2015
prof. avv. Mario Bertolissi - avv. Ezio Zanon - avv. Luigi Manzi