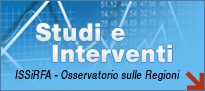Ricorso n.29 del 10 giugno 2016 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 giugno 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 29 del 2016-07-20)
Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, e' domiciliato per legge contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, con sede a L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, 6 (Palazzo I. Silone) per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 31 maggio 2016, degli articoli 1, comma 1, lettere a), b) e c) e 4 della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 59 del 14 aprile 2016.
Premesse di fatto
In data 14 aprile 2016, sul n. 59 del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, e' stata pubblicata la legge regionale 13 aprile 2016, n. 11, intitolata «Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011».
In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art. 1 della legge contiene modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 25, recante «Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche»; l'art. 4, invece, arreca modificazioni alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, rubricata quale «legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa».
Le norme contenute, rispettivamente, negli articoli 1, comma 1, lettere a), b) e c) e 4 della legge abruzzese n. 11/2016 eccedono le competenze regionali, invadono quelle statali e sono percio' violative di previsioni costituzionali e comunitarie: esse vengono pertanto impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti
Motivi di diritto
A
L'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale Abruzzo n. 11/2016
1. Si premette che l'art. 1 della legge regionale Abruzzo n. 11/2016 - d'ora in avanti, per brevita', la legge - disciplina, come, del resto, la legge regionale sulla quale interviene - la legge regionale n. 25/2011 - il canone dovuto per le utenze di acqua pubblica e, segnatamente, il sistema di determinazione della sua misura.
Com'e' noto, a norma dell'art. 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 - testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici - le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo «regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno» (art. 35, comma 3, testo unico cit.).
A sua volta, la forza motrice nominale - o potenza nominale - di un impianto elettrico e' «calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore» (art. 35, comma 2, testo unico cit.).
L'art. 6 del medesimo testo unico distingue le utenze di acqua pubblica a seconda che abbiano ad oggetto grandi o piccole derivazioni le quali, quanto a quelle destinate alla produzione di forza motrice, si differenziano tra loro a seconda che abbiano una potenza nominale media annua superiore o meno a kW 3.000.
E' altresi' noto che, ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 118, le regioni e gli enti locali competenti per territorio provvedono alla gestione dei beni del demanio idrico: nell'esercizio di tale funzione le regioni provvedono pertanto alla determinazione e all'introito dei canoni rivenienti dalla utilizzazione di detti beni.
In particolare, le regioni - e le Province autonome di Trento e di Bolzano - provvedono alla determinazione e all'incasso dei canoni derivanti dalla concessione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.
Tutte le regioni adottano canoni parametrati alla potenza nominale media di concessione, con valori oscillanti tra i 13 e i 37 euro/kW: la Regione Abruzzo, come meglio si dira' in prosieguo, parametra invece il canone di concessione idroelettrica alla potenza efficiente dell'impianto.
Tale diversa grandezza di riferimento conduce, in concreto, alla determinazione di canoni concessori di gran lunga superiori a quelli determinati sulla base della potenza nominale media dell'impianto con effetti, come si dira', distorsivi della concorrenza e, quindi, violativi dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Carta fondamentale.
2. L'art. 1 della legge modifica l'art. 12 della legge regionale n. 25/2011: in particolare, la lettera a) del comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 12 fissando il costo unitario per l'uso idroelettrico di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, in euro 35,00 per ogni Kw di potenza efficiente, oltre ai relativi aggiornamenti al tasso di inflazione programmata.
La successiva lettera b) sostituisce invece il comma 1-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 25/2001 prevedendo, per la definizione di potenza efficiente, il rinvio «alla definizione ufficiale utilizzata per la potenza efficiente netta dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI)».
La lettera c) sostituisce infine il comma 1-ter dell'art. 12 della legge regionale n. 25/2011 stabilendo che «il canone annuo, calcolato applicando il valore riportato al comma 1 per ogni Kw di potenza nominali» sia versato, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 93 della legge regionale n. 7/2003, entro il 28 febbraio di ciascun anno anticipatamente e a titolo di acconto. La norma prevede altresi' le modalita' con cui la potenza efficiente deve essere certificata da organismo terzo e comunicata al competente Servizio regionale nonche' al Gestore della rete di trasmissione ovvero al Gestore dei servizi energetici: sulla base della potenza efficiente misurata e certificata dall'organismo terzo il medesimo Servizio regionale provvede quindi a «quantificare l'importo complessivo a conguaglio, secondo le modalita' di cui al comma 1», che deve essere versato entro 60 giorni dalla relativa richiesta.
La disposizione prosegue stabilendo che nel caso in cui il dato della potenza efficiente - sulla base del quale viene calcolato il conguaglio dovuto - risulti inferiore alla potenza nominale - sulla cui base e' stato computato l'acconto versato anticipatamente - «nulla e' dovuto al concessionario a titolo di rimborso».
E' previsto poi che, «in caso di mancata comunicazione della potenza efficiente il canone dovuto e' triplicato rispetto al canone dovuto calcolato sulla potenza nominale media di concessione»: tale ultima previsione - di natura sanzionatoria - e' analoga a quella gia' contenuta nell'art. 12, comma 1-quinquies, legge regionale n. 25/2011 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2015, n. 36, e ora abrogata dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 della stessa legge regionale n. 11/2016).
La lettera d) della norma in commento prevede infine che il termine stabilito dalla lettera precedente - quello fissato per il versamento dell'acconto di canone - per l'anno 2016 e' stabilito al 31 maggio 2016.
3. Le norme teste' descritte riproducono sostanzialmente le analoghe disposizioni in precedenza contenute nelle leggi regionali 3 novembre 2015, n. 36, e 19 gennaio 2016, n. 5, entrambe oggetto di impugnativa da parte del Governo (rispettivamente, n. r.r. 2/2016 e 21/2016), e presentano quindi i medesimi profili di illegittimita' costituzionale.
La disposizione censurata, intervenendo nuovamente sul criterio di determinazione del canone di concessione di derivazione di acqua pubblica per uso idroelettrico gia' oggetto dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 36 del 2015 e dell'art. 11, comma 6, lettera b) della legge regionale n. 5/2016, introduce infatti una «nuova» definizione di potenza efficiente sostanzialmente equivalente a quella contenuta nelle impugnate leggi regionali nn. 36/2015 e 5/2016.
L'art. 1, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 36 del 2015 definiva infatti la potenza elettrica efficiente, sulla base della quale calcolare l'ammontare del canone idroelettrico, come «la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto».
Il riferimento alla potenza efficiente come parametro per la determinazione della misura del canone concessorio idroelettrico era peraltro gia' previsto - con rinvio alla definizione del GSE (Gestore dei servizi energetici) - dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, la quale, modificando la legge regionale n. 25/2011 in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche, aveva previsto l'aumento da 27,50 ?¬ a 35,00 ?¬ del costo unitario per l'uso idroelettrico e, per quel che qui specificamente interessa, aveva stabilito, come parametro di riferimento per la quantificazione dell'ammontare del canone, non piu' la potenza nominale concessa o riconosciuta, bensi' la potenza efficiente riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente dal GSE (tale disposizione, che aveva superato il vaglio di costituzionalita' avendo codesta Corte rilevato che non era stato dimostrato «come il riferimento alla potenza efficiente influisca sui costi e quale sia il "verso economico" di tale effetto» - sentenza 10 aprile 2014, n. 85 -, e' stata peraltro poi soppressa, in parte qua, dall'art. 1, comma 2, lettera a) della citata legge regionale n. 36/2015).
L'art. 11, comma 6, lettera b) della successiva legge regionale n. 5/2016, stabilendo che il costo unitario per l'uso idroelettrico per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw fosse ragguagliato alla potenza efficiente e rinviando per la definizione di potenza efficiente alla definizione ufficiale utilizzata dal GSE e dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), aveva poi solo apparentemente modificato la legge regionale n. 36/2015 perpetuando la medesima illegittimita' gia' riscontrata e denunciata con il ricorso avverso tale ultimo atto normativo. La definizione di «potenza efficiente» che, ai sensi della delibera AEEG 179/2014/R/EPR, il GSE e l'AEEG adottano dal 2014 e' infatti la stessa contenuta nella legge regionale n. 36/2015, intendendosi per «potenza efficiente o massima potenza elettrica di un impianto di produzione di (una sezione) ... la massima potenza elettrica, con riferimento esclusivo alla massima potenza attiva che puo' essere prodotta con continuita' durante un dato intervallo di tempo sufficientemente lungo di funzionamento (almeno quattro ore per gli impianti idroelettrici) supponendo tutte le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza di portata e di salto nel caso degli impianti idroelettrici».
Anche le modifiche apportate dalla legge impugnata con il presente atto non mutano, al pari di quelle recate dalla legge regionale n. 5/2016, la sostanza della definizione di potenza efficiente gia' contenuta nella legge regionale n. 36/2015 quale «la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto».
La disposizione ora contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 11/2016 si differenzia infatti dalle norme in precedenza impugnate per il solo fatto che essa: a) espunge dalla definizione di potenza efficiente il rinvio alla definizione ufficiale di potenza efficiente utilizzata dal GSE (gia') presente nell'art. 11, comma 6, lettera b) della legge regionale n. 5/2016, mantenendo tuttavia il richiamo alla definizione utilizzata dall'AEEG - ora AEEGSI: Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico - e
b) fa riferimento alla potenza efficiente netta.
La differenza tra le due disposizioni e' pero' soltanto apparente perche':
ad a) anche la definizione ufficiale di potenza efficiente utilizzata dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico identifica «la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell'impianto in finzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto»; e
a b) la potenza efficiente netta si differenzia da quella lorda per il solo fatto che la prima e' misurata all'uscita dell'impianto, al netto, cioe', della potenza assorbita dai servizi ausiliari dell'impianto e delle perdite nei trasformatori dell'impianto, mentre la seconda e' misurata all'entrata dell'impianto di produzione di energia elettrica - piu' precisamente, ai morsetti dei generatori elettrici -: peraltro, poiche' sia la potenza efficiente netta sia la potenza efficiente lorda identificano entrambe la massima potenza elettrica realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento (4 ore), per la produzione esclusiva di potenza attiva, supponendo che tutte le parti dell'impianto siano interamente in efficienza e, nel caso di un impianto idroelettrico, che siano disponibili le piu' favorevoli condizioni di portata e di salto, e' evidente che il valore che risulta dal riferimento alla potenza efficiente netta si discosta soltanto di pochi punti percentuali da quello risultante dal riferimento alla potenza efficiente lorda.
Da tanto consegue che, essendo rimasto immutato anche nella nuova disposizione il riferimento alla nozione di potenza efficiente, lo scostamento di valori riveniente dal riferimento alla potenza efficiente netta contenuto nella norma che si impugna e', rispetto a quello risultante dalle precedenti definizioni e previsioni normative, assolutamente marginale e privo, come tale, di una reale ed effettiva significativita': con la conseguenza che la misura del canone risultante dall'applicazione della (apparentemente nuova) definizione recata dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 11/2016 e', all'atto pratico, sostanzialmente identica a quella riveniente dall'applicazione delle previsioni normative impugnate con i precedenti ricorsi.
Anche in questo caso, la determinazione del canone si fonda inoltre sulla potenza di targa della macchina anziche' sulla potenza nominale media di concessione utilizzata da tutte le altre regioni e comporta percio' i medesimi negativi effetti, discriminatori e anticoncorrenziali, a danno degli operatori idroelettrici operanti in Abruzzo gia' denunciati con le precedenti impugnative.
4. Da quanto si e' sin qui venuti esponendo risulta altresi' di tutta evidenza che l'abrogazione dell'art. 11, comma 6, della legge regionale n. 5/2016 da parte dell'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 11/2016 e la contestuale riproduzione del suo contenuto nella norma oggetto del presente ricorso si risolve nel tentativo del legislatore regionale abruzzese di eludere la definizione dei giudizi di legittimita' costituzionale instaurati con i ricorsi proposti avverso le leggi regionali nn. 36/2015 e 5/2016.
Ed infatti, posto che, come piu' sopra illustrato, l'ultimo intervento legislativo e' solo apparentemente modificativo dei termini della questione - i quali rimangono invece sostanzialmente invariati -, merita sul punto richiamare la sentenza 29 ottobre 2009, n. 272, con la quale codesta Corte, confermando la propria consolidata giurisprudenza, ha affermato che «il principio di effettivita' della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione non tollera che, attraverso l'uso distorto della potesta' legislativa, uno dei contendenti possa introdurre una proposizione normativa di "contenuto" equivalente a quella impugnata e nel contempo sottrarla al gia' instaurato giudizio di legittimita' costituzionale. Si impone pertanto, in simili casi, il trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quella oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo (sentenze n. 168/2008 e n. 533/ 2002)».
Tale orientamento e' stato anche di recente ribadito dalla sentenza 7 novembre 2014, n. 249 - resa proprio con riferimento ad altra legge della Regione Abruzzo (la n. 14 del 2014) - nella quale si e' stabilito che, «poiche', nella specie, ricorrono tali condizioni - avendo, come si e' detto, la Regione sostituito il testo originario con una variante avente analogo contenuto lesivo del precetto comunitario - le censure proposte in riferimento all'art. 38 della legge regionale Abruzzo n. 55 del 2013 debbono ritenersi trasferite al nuovo testo, con la conseguente pronuncia di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2014 per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.» (v. anche la sentenza 11 febbraio 2010, n. 40 e, da ultimo, la stessa gia' citata sentenza n. 85/2014).
5. Tanto chiarito, questa Difesa non ignora che, come s'e' detto in precedenza, con sentenza 10 aprile 2014, n. 85, codesta Corte ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge regionale n. 1/2012 - estesa alla sopravvenuta disposizione modificativa contenuta nella legge regionale 17 luglio 2012, n. 34, di contenuto sostanzialmente analogo -, il quale aveva sostituito la potenza efficiente alla potenza nominale quale parametro di riferimento per la determinazione della misura del canone concessorio idroelettrico: e che, in particolare, la questione e' stata dichiarata inammissibile sia perche' non e' stato dimostrato «come il riferimento alla potenza efficiente influisca sui costi e quale sia il "verso economico" di tale effetto» sia perche' nulla e' stato riferito «sui presupposti di fatto della lamentata violazione delle regole della concorrenza, se non il generico riferimento al testo unico n. 1775 del 1933» (paragrafo 4.4).
Nel proporre alla Corte Ecc.ma una parziale rimeditazione dei principi che, nella richiamata sentenza n. 85/2014, hanno condotto al rigetto in parte qua del ricorso proposto contro la legge regionale Abruzzo n. 1/2012, mette conto ricordare che, anche in quell'occasione, la disposizione regionale era stata impugnata dal Governo sul presupposto che la stessa violasse le competenze statali in materia, tra l'altro, di tutela della concorrenza, creando uno squilibrio tra gli operatori economici insediati nel territorio della Regione Abruzzo e quelli aventi sede in altra Regione (art. 117, comma 2, lettera e) Cost).
La materia e' stata peraltro oggetto di ulteriore esame nella sentenza 25 febbraio 2014, n. 28, depositata pero' in data successiva all'udienza di trattazione dell'impugnazione definita con la decisione n. 85/2014, e che non sembrerebbe essere stata valutata in quella sede.
Nell'affrontare problematiche connesse alle concessioni del settore idroelettrico, infatti, veniva asserita la inderogabile necessita' che l'attivita' di generazione idroelettrica sia ispirata al principio secondo il quale deve essere garantito «l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale» (cio', ai fini dell'affermazione della competenza statale proprio in applicazione della devoluzione operata dall'art. 117, comma 2, lettera e) Cost.).
Simili affermazioni sono altresi' contenute nella sentenza 1° aprile 2014, n. 64, ove si ribadisce che «in tale settore il legislatore statale ha espressamente affrontato l'esigenza di tutelare la concorrenza garantendo l'uniformita' della disciplina sull'intero territorio nazionale»; e che la necessita' di «agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale», attuata, a livello nazionale, attraverso la normativa posta con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, porta a ritenere la disciplina delle utenze idroelettriche oggi attratta «nell'ambito della lettera e) del secondo comma dell'art. 117 Cost.».
L'art. 37, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede infatti che, «al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e parita' di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicita' e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico».
E se e' vero che tale norma demanda alla legislazione regionale di dettaglio la concreta fissazione, all'interno dei valori massimi stabiliti dallo Stato, dei canoni delle concessioni idroelettriche, e' pero' altrettanto vero che essa costituisce la piu' evidente dimostrazione del fatto che la tutela della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica - e, di riflesso, la parita' di trattamento tra gli operatori economici - costituisce principio non soltanto di rilievo comunitario, ma trova esplicito riconoscimento anche a livello nazionale.
Se tali devono ritenersi i principi che regolano il riparto delle competenze nella materia che ne occupa, non puo' dunque da essi prescindersi nell'esaminare il regime cui, per effetto della norma che qui si impugna (e di quelle che con variegate formulazioni l'hanno preceduta), la materia della determinazione dei canoni concessori dovuti dagli operatori idroelettrici e' oggi sottoposta nella Regione Abruzzo.
E tale esame conduce, ad avviso di questa Difesa, a ritenere che la norma abbia l'effetto di alterare le condizioni concorrenziali sul territorio nazionale, discriminando gli operatori idroelettrici insediati in Abruzzo e cosi' violando l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
6. Come s'e' detto in apertura del presente scritto, tutte le regioni italiane parametrano il canone alla potenza nominale media di concessione, con valori oscillanti tra i 13 e i 37 euro/kW (segnatamente: Veneto 29,68 euro/kW; Sardegna, 14,35 euro/kW; Lombardia 31,09 euro/kW; Basilicata 13,85 euro/kW; Campania 13,89 euro/kW; Campania 13,89 euro/kW; Calabria 14,05 euro/kW; Molise 37,91 euro/kW; Sicilia 14,46 euro/kW; Toscana 15,26 euro/kW; Emilia-Romagna 14,3 euro/kW; Piemonte 28,24 euro/kW).
La Regione Abruzzo, invece, determina il canone di concessione idroelettrica sulla base della potenza efficiente dell'impianto.
Tale diversa grandezza di riferimento conduce, in concreto, alla determinazione di canoni concessori di gran lunga superiori a quelli determinati sulla base della potenza nominale media dell'impianto con effetti, come si vedra', distorsivi della concorrenza e, quindi, violativi dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Carta fondamentale.
La potenza efficiente alla quale fa da tempo riferimento il legislatore regionale abruzzese non si identifica infatti ne' con la potenza realmente prodotta dall'impianto idroelettrico ne' con quella media producibile nell'anno, ma, come s'e' visto, consiste nella potenza che sarebbe teoricamente producibile durante quattro ore di ipotetico funzionamento, in condizioni ottimali di portata e di salto, sfruttando la massima efficienza possibile dell'impianto.
Si tratta, com'e' evidente, di un parametro che, avendo riguardo al funzionamento dell'impianto in condizioni «estreme» - massima efficienza di tutte le parti dell'impianto e condizioni ottimali di portata e di salto - e temporalmente circoscritte - 4 ore -, e' non solo completamente avulso dalla realta' produttiva quotidiana ma altresi' scarsamente significativo della reale capacita' «economica» del concessionario/produttore che finisce, quindi, come si dimostrera', per esserne gravemente danneggiato.
Perche' se e' vero che, come ha sottolineato codesta Corte nella pluricitata sentenza n. 85/2014, nel quadro competenziale delineato dal decreto legislativo n. 112/1998 lo Stato «non puo' limitare l'autonomia legislativa regionale e provinciale acquisita in materia» di determinazione della misura dei canoni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico, e' pero' altrettanto vero che, come parimenti evidenziato da codesto Consesso, «l'unico principio fondamentale della materia e' quello della onerosita' della concessione e della proporzionalita' del canone alla entita' dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilita' economica che il concessionario ne ricava».
E, sotto questo profilo, il parametro prescelto dalla Regione Abruzzo per quantificare il canone dovuto dal concessionario idroelettrico non e', come s'e' detto e come si provera', proporzionato ne' «alla entita' dello sfruttamento della risorsa pubblica» ne', soprattutto, «all'utilita' economica che il concessionario ne ricava».
7. E, invero, come e' evidente anche per un soggetto sprovvisto di particolari cognizioni tecniche, il parametro della potenza efficiente, per di piu' identificata attraverso i dati di targa del macchinario installato, puo' discostarsi di molto dal valore della potenza nominale di concessione.
Il che vale specialmente per gli impianti dotati di lago o bacino di accumulo dell'acqua, che utilizzano grandi quantita' d'acqua in periodi limitati dell'anno e che hanno, dunque, necessita' di macchinari con una potenza efficiente molto maggiore di quella media annua di concessione.
Un impianto a bacino di grandi dimensioni con potenza media di concessione pari a 50 mW, avra', tipicamente, una potenza efficiente - secondo la definizione introdotta dalla disposizione censurata - di circa 150 mW (una potenza efficiente pari dunque a 3 volte circa quella di concessione).
L'incidenza economica della disposizione sulle imprese ubicate in Abruzzo e' conseguente e direttamente proporzionale: fermo restando il valore di euro 35 per kW ora ribadito dall'art. 1 della legge, l'applicazione dello stesso ad una grandezza (potenza efficiente) sino a 3 volte maggiore (di quella media di concessione) comporta, molto semplicemente, la triplicazione della misura del canone concessorio.
8. E per apprezzare come a tale aumento del canone, introdotto in via diretta dalla legge regionale in esame, consegua una sperequazione fra le imprese ubicate in Abruzzo e quelle ubicate in altre regioni, e' sufficiente considerare il prezzo di vendita del bene prodotto, cioe' dell'energia elettrica.
Restando all'esempio del grande impianto di bacino, il canone, calcolato in base alla legge in esame, puo' arrivare a pesare sino a 21 euro per ogni MW/h prodotto, mentre sarebbe di soli 7 euro per MW/h se fosse calcolato sulla base della potenza media di concessione. Tale grandezza va confrontata con l'attuale prezzo di mercato dell'energia elettrica per impianti a bacino, il quale puo' oscillare tra i 50 e i 90 euro per MW/h: ne consegue che l'importo del canone puo' arrivare ad «assorbire» circa un terzo del prezzo di vendita dell'energia.
9. Quanto precede dimostra, al di la' di ogni ragionevole dubbio, che la disposizione che oggi si impugna incide - e incide assai fortemente - sulla capacita' delle imprese di operare in condizioni di parita' sul mercato unico dell'energia elettrica: e, ad avviso di questo Patrocinio, offre, sia detto per inciso, quella prova di «come il riferimento alla potenza efficiente influisca sui costi e quale sia il "verso economico" di tale effetto» che aveva indotto codesta Ecc.ma Corte a dichiarare inammissibile la analoga questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 16 della legge regionale n. 1/2012 e decisa con la sentenza n. 85/2014.
Le imprese operanti in Abruzzo, gravate di un canone pari a 21 euro per MW/h, si troveranno infatti a competere con analoghi impianti che avendo, invece, un canone molto piu' basso (oscillante tra i 4 e i 7 MW/h) sono in grado di offrire sul mercato dell'energia prezzi piu' bassi di quelli degli impianti abruzzesi.
Le imprese aventi impianti di produzione di energia idroelettrica ubicati in Abruzzo sono cioe' costrette a pagare un canone che, essendo ragguagliato alla potenza efficiente dell'impianto, e' di molto superiore a quello corrisposto dalle imprese del settore operanti in altre regioni le quali pagano invece un canone che, essendo determinato, come s'e' detto, sulla base della potenza nominale dell'impianto, e' di regola molto piu' basso.
E poiche' il prezzo di vendita di un bene - nella fattispecie, dell'energia elettrica - e' determinato in funzione dei costi di produzione e varia in relazione al variare di questi, e' evidente che la misura del canone di concessione idroelettrica - il quale costituisce uno dei principali, se non il principale costo di produzione - e' decisiva ai fini della formazione e della misura del corrispettivo offerto all'utenza finale: con la conseguenza che i produttori idroelettrici abruzzesi, costretti a pagare un canone piu' elevato per effetto dell'applicazione dei criteri recati dalla legge qui impugnata, non sono, sotto questo profilo, e coeteris paribus, in grado di competere con gli operatoti stabiliti in altre regioni italiane i quali, per effetto dei canoni piu' bassi corrisposti, sono in condizione di produrre a costi piu' contenuti e, quindi, di offrire sul mercato dell'energia elettrica prezzi proporzionalmente inferiori a quelli degli impianti abruzzesi.
Per le ragioni esposte, l'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale Abruzzo n. 11/2016 contrasta con i principi in materia di tutela della concorrenza contenuti nell'art. 37, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e conseguentemente viola l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
B
L'art. 4 della legge regionale Abruzzo n. 11/2016
1. L'art. 4 della legge interviene invece su alcune disposizioni della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa), rispettivamente, gli articoli 8 - rubricato «norme transitorie di salvaguardia», 9 - contenente la definizione e l'articolazione in zone dei parchi naturali regionali - e 19 - dedicato alla definizione e classificazione delle riserve naturali regionali.
In particolare, la norma che qui si impugna, al dichiarato fine di «favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'incremento del turismo cinofilo», consente lo svolgimento di attivita' cinofile e cinotecniche per otto mesi l'anno su una superficie non inferiore al cinquanta per cento delle zone B, C e D dei parchi naturali regionali e non inferiore al trenta per cento di quella delle riserve naturali regionali guidate, controllate e speciali; inoltre, nelle more dell'adeguamento alle nuove disposizioni dei regolamenti o dei piani dei parchi naturali regionali ovvero del piano di assetto naturalistico, essa permette di svolgere quelle attivita' per dodici mesi l'anno sull'intera superficie delle zone B, C e D dei parchi naturali regionali e sull'intera superficie delle riserve naturali regionali.
Cosi' disponendo, la norma non solo non rispetta i vincoli posti dalla legislazione nazionale nell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - cosi' violando l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione -, ma, come si vedra', si pone pure in contrasto con gli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale e comunitario - cosi' violando l'art. 117, comma 1, della Carta.
Ma per meglio comprendere il senso e la portata delle censure che si verranno esponendo pare opportuno ricordare che:
a) all'interno di ciascun parco o riserva regionale abruzzese e', in ogni caso, vietata «la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati» (v. art. 8, comma 2, della stessa legge regionale Abruzzo n. 38/1996);
b) le zone B e C dei parchi naturali regionali individuano aree, rispettivamente, «di elevato valore naturalistico e paesaggistico (riserva generale)» (zona B) o «di protezione, per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati» (zona C) (v. art. 9, comma 2, legge regionale n. 38/1996);
c) le riserve naturali regionali sono costituite da «zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico in funzione di una speciale tutela di emergenze geomogeologiche, floristiche, faunistiche, paleontologiche e archeologiche o di altri valori ambientali» (art. 19, comma 1, legge regionale n. 38/1996); in particolare, le riserve naturali guidate sono istituite «per la conservazione e la ricostituzione di ambienti naturali nei quali e' consentita una razionale attivita' agricola, pascolava ed una selvicoltura con criteri di sfruttamento naturalistici, nonche' forme di turismo escursionistico» (art. 19, comma 2, lettera b) legge regionale n. 38/1996); quelle controllate sono istituite «per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui siano consentite le attivita' di cui alla precedente lettera b)» (art. 19, comma 2, lettera c) legge regionale n. 38/1996); quelle naturali, infine, sono istituite «per la salvaguardia rigorosa di singoli ambienti di rilevante interesse naturalistico, genetico, paesaggistico, storico, umano e geomorfogico» (art. 19, comma 2, lettera d) legge regionale n. 38/1996).
Merita infine rammentare che, a mente dell'art. 1 della legge 23 agosto 1993, n. 349, recante norme in materia di attivita' cinotecnica, «per attivita' cinotecnica si intende l'attivita' volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine».
Tanto premesso, l'art. 4 della legge, consentendo, come s'e' detto, lo svolgimento di attivita' cinofile - e, quindi, anche di gare e manifestazioni canine - e cinotecniche per gran parte dell'anno (8 mesi) o, in via transitoria, per l'intero anno all'interno dei parchi e delle riserve naturali regionali su aree che, in via transitoria, interessano o, a regime, possono arrivare ad interessare l'intera superficie delle zone individuate dei parchi (B, C e D) o l'intera superficie della riserva, pone in serio pericolo specie animali prioritarie e protette, quali, ad esempio, il lupo (che e' ubiquitario), l'orso bruno marsicano (specie minacciata di estinzione, presente nelle principali aree protette regionali e oggetto di uno specifico piano d'azione nazionale, il c.d. PATOM) ed il camoscio appenninico (di recente reintrodotto all'interno del Parco naturale regionale «Sirente-Velino»).
In tal modo, restringendo l'oggetto della tutela prevista dalle norme (nazionali, europee e internazionali) in materia di protezione della fauna di seguito indicate, la disposizione censurata viola nel contempo sia l'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. - il quale riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» - sia l'art. 117, comma 1, Cost. - il quale impone al legislatore, anche regionale, il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. In particolare, l'art. 4 legge regionale n. 11/1999 contrasta con le disposizioni di seguito elencate.
2.1 - Articoli 2, comma 2, e 12, comma 1, lettera b) e d) della direttiva 92/43/CEE - c.d. HABITAT «relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche» e art. 8, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, contenente il Regolamento di attuazione della suddetta direttiva 92/43/CEE.
L'art. 2, comma 2, della direttiva 92/43/CEE prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure «intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario».
Il successivo art. 12 stabilisce a sua volta che gli Stati membri istituiscano un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui allegato IV lettera a) della direttiva - tra le quali sono elencate, tra le altre, le seguenti specie: il lupo (canis lupus), l'orso bruno marsicano (ursus arctos marsicanus) e il camoscio appenninico (rupicapra pyrenaica ornata) -, con il divieto, fra gli altri, di: «perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione» (comma 1, lettera b); «deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo» (comma 1, lettera d).
In attuazione di tali disposizioni comunitarie, l'art. 8, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 ha introdotto a sua volta l'esplicito divieto di perturbare le specie animali individuate alla lettera a) dell'allegato D al regolamento - specie tra le quali figura il lupo, l'orso bruno marsicano e il camoscio appenninico - durante particolari fasi biologiche (segnatamente, ciclo riproduttivo, l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione).
In questa prospettiva e' percio' di tutta evidenza che la disposizione regionale impugnata, consentendo lo svolgimento di attivita' cinofila e cinotecnica all'interno delle aree naturali protette abruzzesi, e' suscettibile, ex se, di incidere assai negativamente sulle fasi biologiche di vita (sulla riproduzione, l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione) delle specie animali protette; e si pone cosi' in insanabile conflitto con le norme nazionali e sovranazionali sopra indicate - articoli 2, comma 2, e 12, comma 1, lettera b) e d) della direttiva 92/43/CEE - c.d. HABITAT - «relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche» e art. 8, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, contenente il Regolamento di attuazione della suddetta direttiva 92/43/CEE - violando nel contempo, sotto altro profilo, sia l'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. sia l'art. 117, comma 1, Cost. 2.2 - Art. 6, commi 2 e 3, della direttiva 92/43/CEE e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.
L'art. 6, comma 2, della direttiva 92/43/CEE stabilisce che «gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonche' la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva».
Il successivo comma 3 della medesima disposizione stabilisce poi che «qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorita' nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudichera' l'integrita' del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica».
In attuazione delle norme citate l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 introduce e disciplina a livello nazionale il procedimento di valutazione di incidenza ambientale ai quali e' obbligatorio sottoporre qualsiasi piano od intervento suscettibile di avere incidenze significative rispettivamente sui proposti siti di importanza comunitaria, sui siti di importanza comunitaria e sulle zone speciali di conservazione.
Ora, poiche' le attivita' cinofile e cinotecniche consentite dalla norma regionale all'esame potrebbero essere svolte anche all'interno di aree classificate come siti di importanza comunitaria (SIC), le stesse, siccome suscettibili di incidere negativamente sullo stato di conservazione dell'equilibrio ambientale delle aree, dovrebbero comunque essere approvate caso per caso e, soprattutto, solo a seguito della valutazione d'incidenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.
E non pare fuor di luogo rammentare a tale riguardo che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di codesta Corte, «la disciplina della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulle aree protette ai sensi di "Natura 2000", contenuta nell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, deve ritenersi ricompresa nella "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", rientrante nella competenza esclusiva statale, e si impone a pieno titolo, anche nei suoi decreti attuativi, nei confronti delle Regioni ordinarie» (cosi' Corte costituzionale sentenze 18 aprile 2008, n. 104 e 17 marzo 2015, n. 38).
Pertanto, l'art. 4 della legge regionale n. 11/2016, esentando indebitamente le attivita' cinofile e cinotecniche dalla valutazione di incidenza ambientale, comporta un affievolimento della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e viola cosi' sia l'art. 117, comma 1, Cost., per contrasto con la disciplina. contenuta nella direttiva 92/43/CEE sia l'art. 117, comma 2, lettera s) Cost., in riferimento all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997. 2.3 Art. 6, comma 1, lettera c) della Convenzione «relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ed eseguita in Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503.
Per le medesime ragioni indicate in precedenza la disposizione regionale impugnata si pone altresi' in contrasto con l'art. 6, comma 1, lettera c) della citata Convenzione la quale impone alle Parti contraenti di adottare le «necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere a particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II» - tra le quali figurano, ancora una volta, il lupo, l'orso e il camoscio -, vietando espressamente di «molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione».
Per questo profilo, la norma regionale che consente lo svolgimento di attivita' cinofile e cinotecniche all'interno delle aree protette abruzzesi, ponendosi in contrasto con vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, viola, ancora una volta, l'art. 117, comma 1, Cost. 2.4 Articoli 10, comma 8, lettera e), 21, comma 1, lettera b) e 30, comma 1, lettera d) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sulla disciplina dell'attivita' venatoria e art. 5, punto 1, della direttiva 30 novembre 2009/147/CE «concernente la conservazione degli uccelli selvatici» c.d. Uccelli.
Com'e' noto, poiche' lo svolgimento di attivita' cinofile e cinotecniche comprende anche l'attivita' di allevamento e addestramento dei cani per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' fuor di dubbio che, sotto questo profilo, quelle attivita' sono direttamente riconducibili alla materia della caccia (sulla riconducibilita' dell'allevamento e dell'addestramento dei cani da caccia, in quanto attivita' strumentale all'esercizio venatorio, alla materia della «caccia» v. Corte cost. 16 luglio 1991, n. 350 e, da ultimo, Corte costituzionale 17 luglio 2013, n. 193).
Da tale affermazione la sentenza da ultimo citata trae il logico corollario che l'attivita' di allevamento e addestramento di cani da caccia, rientrando nel concetto di attivita' venatoria, e' anch'essa soggetta alla pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della legge n. 157/1992 e alla modalita' e garanzie procedimentali di cui al successivo art. 18.
In questa prospettiva e in questo ambito spetta dunque allo Stato stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna selvatica, con regole che le regioni possono modificare, nell'esercizio della loro potesta' legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela (v., ex plurimis, le sentenze di codesta Corte 12 dicembre 2013, n. 303, 12 dicembre 2012, n. 278, 10 maggio 2012, n. 116 e 26 aprile 2012, n. 106): come ribadito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale - v. le sentenze 14 novembre 2003, n. 339, 16 luglio 1991, n. 350 e 28 dicembre 1990, n. 578 - e amministrativa - Consiglio di Stato, sez. VI, 7 luglio 2002, n. 717; Tribunale amministrativo regionale Campania, Napoli, sez. I, 23 ottobre 2001, n. 4639; Tribunale amministrativo regionale Liguria, sezione II, n. 368/2004) -, in questa materia le regioni sono pertanto tenute ad attenersi ai divieti previsti dalla normativa quadro statale.
Tali norme, alle quali tutte le regioni devono attenersi, sono le seguenti:
a) l'art. 10, comma 8, della legge n. 157/1992 - contenente «norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» - il quale stabilisce, per quanto qui interessa, che i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, «le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili (lett. e);
b) il successivo art. 21, comma 1, il quale pone invece, sempre per quanto qui interessa, un divieto assoluto di «esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali» (lett. b), divieto penalmente sanzionato dall'art. 30, comma 1, lettera d) della stessa legge.
Il quadro normativo di riferimento e' infine completato dalla direttiva 2009/147/CE - concernente la conservazione degli uccelli selvatici - la quale stabilisce, all'art. 5, punto 1, che gli Stati membri adottino «le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 - vale a dire degli «uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico», protezione che e' espressamente estesa «alle uova, ai nidi e agli habitat» - e che comprenda in particolare il divieto:
«a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando cio' abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura».
Da tutto quanto precede consegue che, in assenza di specifica esclusione dalle attivita' cinofile e cinotecniche consentite dall'art. 4 della legge regionale n. 11/2016 di quelle consistenti nell'allevamento e nell'addestramento di cani da caccia, la medesima norma si pone in contrasto:
a) con l'art. 10, comma 8, lettera e) della legge n. 157/1992, che, come s'e' visto, assoggetta a pianificazione l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale;
b) con l'art. 21, comma 1, lettera b) - e, di conseguenza, con l'art. 30, comma 1, lettera d) - della stessa legge statale, che vietano e sanzionano l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali;
c) con l'art. 5 della direttiva 2009/147/CE, che impone un regime di protezione generale della fauna aviaria selvatica articolantesi nei divieti ivi elencati; e, di conseguenza, viola sia la riserva di legge statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione sia l'art. 117, comma 1, della Carta.
Non e' del resto necessario disporre di particolari conoscenze e competenze in materia etologica per comprendere come le manifestazioni cinofile consentite dalla norma possano arrecare un consistente disturbo agli animali, determinare catture o distruzione di nidi e creare altre situazioni di danno e disagio alla fauna selvatica (nel periodo di nidificazione e dipendenza per gli uccelli selvatici, durante il periodo di iperfagia e letargia per l'orso bruno marsicano o lo spostamento nelle aree di svernamento per il camoscio appenninico).
La presenza di cani liberi di vagare privi di guinzaglio nelle aree protette, spinge infatti gli animali a spostarsi durante le fasi del corteggiamento e della cova, causando l'abbandono dei nidi e delle covate, esercitando un impatto negativo sulla sopravvivenza dei giovani e limitando di conseguenza il successo riproduttivo.
I cani, infatti, sono percepiti dalla fauna selvatica come veri e propri predatori: molte specie di uccelli, inoltre, nidificano a terra e la loro riproduzione puo' fallire al minimo disturbo con l'abbandono del nido; e la presenza dei cani puo' compromettere anche il letargo dell'orso.
La concretezza dei rischi evidenziati (particolarmente elevati per i galliformi - tra i quali si annoverano anche specie di specifico interesse venatorio come i fagiani, le coturnici, le quaglie, le pernici e i galli cedroni - e per la lepre italica) trova puntuale riscontro nel parere reso dall'ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - in data 22 agosto 2012 con riferimento alla poi impugnata e annullata - in parte qua - legge regionale del Veneto 10 agosto 2012, n. 31: in detto parere - richiamato nella gia' citata sentenza di codesta Corte n. 193/2013 - si legge che «l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, indipendentemente dalla loro eta', durante il periodo riproduttivo di uccelli e mammiferi selvatici determina un evidente e indesiderabile fattore di disturbo, in grado di determinare in maniera diretta o indiretta una mortalita' aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate».
E non e' quindi certo un caso che con detta sentenza - la n. 193/2013 - codesta Corte abbia dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una norma della Regione Lombardia - l'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 31 luglio 2012, n. 15 -, addirittura piu' restrittiva di quella ora adottata dalla Regione Abruzzo, perche' consentiva l'attivita' di allenamento e di addestramento dei cani sull'intero territorio regionale con esclusione, tuttavia, delle aree protette.
La norma che si impugna - la quale non ha precedenti in nessun'altra regione italiana - mette dunque a gravissimo rischio la conservazione di specie faunistiche importanti, tutelate da norme europee e nazionali. 2.5 Articoli 1, comma 3, lettera a), 11, commi 1, 3 e 4, e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «legge quadro sulle aree protette».
Com'e' noto, tale legge detta, in attuazione degli articoli 9, comma 2, e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, i «principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese» (cosi' l'art. 1, comma 1, della legge).
Il comma 2 dell'art. 1 della legge quadro chiarisce che «ai fini della ... legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomoocologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale».
Il successivo 3° comma stabilisce poi che «i territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalita':
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici».
La tutela dei valori naturali ed ambientali nonche' storici, culturali, antropologici tradizionali e' affidata all'Ente parco che tali valori persegue attraverso gli strumenti del piano per il parco (art. 12 della legge) e del regolamento del parco (art. 11) (in argomento, cfr. Corte costituzionale sentenze 12 ottobre 2011, n. 263, 11 febbraio 2011, n. 44 e 25 novembre 2008, n. 387).
Il regolamento del parco «disciplina l'esercizio delle attivita' consentite entro il tenitorio del parco», anche, se in generale, «nei parchi sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare nguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali ...» (art. 11, commi 1 e 3, lettera a) della legge n. 394/1991).
L'art. 11, comma 4, della legge n. 394/1991 precisa poi che eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3 possono essere stabilite solo dal regolamento del parco e che per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
Tali disposizioni - e, segnatamente, l'art. 11, comma 3, della legge quadro, che indica le attivita' vietate nei parchi - vincolano il legislatore regionale il quale non puo' discostarsi da esse nella misura in cui stabiliscono livelli minimi uniformi su tutto il territorio nazionale di tutela dell'ambiente e, come e in quanto tali, sono espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» ex art. 117, comma 2, lettera s), Cost. (sul punto si v., tra le tante, le sentenze della Corte 26 gennaio 2012, n. 14, 12 ottobre 2011, n. 263, 11 febbraio 2011, n. 44, 18 marzo 2005, n. 108 e 14 luglio 2000, n. 282).
Anche sotto questo profilo, lo svolgimento di attivita' cinofile e cinotecniche all'interno delle aree naturali protette mette a repentaglio i valori naturali ed ambientali la cui tutela e' affidata all'Ente parco traducendosi in attivita' oggettivamente incompatibili con la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.
Per le suesposte ragioni l'art. 4 della legge regionale Abruzzo n. 11/2016, ponendosi in contrasto con gli articoli 1, comma 3, lettera a), 11, commi 1, 3 e 4, e 12 della legge n. 394/1991 viola l'art. 117, comma 2, lettera s) Cost.
P.Q.M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, gli articoli 1, comma 1, lettere a), b) e c) e 4 della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 59 del 14 aprile 2016, come da delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 31 maggio 2016.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:
1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno 31 maggio 2016, della determinazione di impugnare la legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11, secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 59 del 14 aprile 2016.
Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.
Roma, 7 giugno 2016
Il vice Avvocato generale dello Stato: Mariani