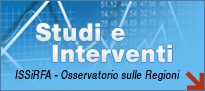| |
N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 aprile 2010. |
| |
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 20 del 19-5-2010) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il
proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma, contro la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del suo Presidente per la
dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma
2, della legge regionale Regione Friuli Venezia Giulia 17 febbraio
2010, n. 5, «Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati
nella Regione Friuli Venezia Giulia», pubblicata nel bollettino
ufficiale regionale n. 8 del 24 febbraio 2010.
Fatto e diritto
1. - La legge regionale in esame, recante «Valorizzazione dei
dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli-Venezia
Giulia», e' stata emanata, ai sensi dell'art. 1, comma primo, della
stessa legge, in dichiarata attuazione dell'art. 9 della
Costituzione.
Essa e' volta pero' alla promozione e al sostegno della
valorizzazione culturale e della conoscenza dei dialetti di origine
veneta parlati nel territorio regionale ed elencati nell'art. 2.
Piu' esattamente, il medesimo art. 1, comma primo, recita che «la
Regione valorizza i dialetti di origine veneta individuati all'art.
2, quali patrimonio tradizionale della comunita' regionale e
strumento di dialogo nelle aree frontaliere e nelle comunita' dei
corregionali all'estero».
L'art. 2, comma unico, statuisce poi che i dialetti in questione
sono «i dialetti di origine veneta nelle seguenti espressioni: il
triestino, il bisiaco, il gradese, il maranese, il muggesano, il
liventino, il veneto dell'Istria e della Dalmazia, nonche' il veneto
goriziano, pordenonese e udinese».
Infine, ai sensi dell'art. 8, comma secondo, «La Regione sostiene
gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei
settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per
l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui
all'art. 2.»
2. - E' qui appena da rammentare che, in attuazione dell'art. 6
Cost. (ai sensi del quale, come ben noto, «La Repubblica tutela con
apposite norme le minoranze linguistiche»), e' stata emanata la legge
15 dicembre 1999, n. 482, «Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche».
L'art. 2, comma primo, di essa legge statuisce che «In attuazione
dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali
stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica
tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e
il sardo».
A sua volta, l'art. 10, comma primo, prevede che «Nei comuni di
cui all'art. 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli
comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle
tradizioni e agli usi locali.».
E' altresi' appena da rammentare che l'art. 3 in questione
disciplina l'individuazione dei territori in cui si applicano le
disposizioni previste dalla legge in questione a tutela delle
minoranze culturali in essa individuate: «1. La delimitazione
dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le
disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste
dalla presente legge e' adottata dal consiglio provinciale, sentiti i
comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei
cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni
stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi
comuni. 2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni
di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque
una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'art. 2,
il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la
popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai
soggetti aventi titolo e con le modalita' previste dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali. 3. Quando le minoranze linguistiche
di cui all'art. 2 si trovano distribuite su territori provinciali o
regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento
e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facolta' di
riconoscere.»
3. - Nulla quaestio, ovviamente, che, anche secondo
l'insegnamento di codesta Ecc.ma Corte, la tutela delle minoranze
linguistiche costituisca principio fondamentale dell'ordinamento
costituzionale (sentenze n. 15 del 1996, n. 261 del 1995 e n. 768 del
1988).
In particolare, «tale principio, che rappresenta un superamento
delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell'ottocento e un
rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto
all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, e' stato
numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte,
anche perche' esso si situa al punto di incontro con altri principi,
talora definiti ''supremi'', che qualificano indefettibilmente e
necessariamente l'ordinamento vigente» (sentenze n. 62 del 1992, n.
768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983): «il principio
pluralistico riconosciuto dall'art. 2 - essendo la lingua un elemento
di identita' individuale e collettiva di importanza basilare - e il
principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione,
il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignita' sociale e
l'eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza
distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l'adozione di
norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di
fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie» (sentenza
n. 15 del 1996).
Vero e' pero' anche che «l'attuazione in via di legislazione
ordinaria dell'art. 6 Cost. in tema di tutela delle minoranze
linguistiche genera un modello di riparto delle competenze fra Stato
e Regioni che non corrisponde alle ben note categorie previste per
tutte le altre materie nel Titolo V della seconda parte della
Costituzione, sia prima che dopo la riforma costituzionale del 2001.
Infatti, il legislatore statale appare titolare di un proprio potere
di individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalita'
di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza
linguistica da tutelare, nonche' degli istituti che caratterizzano
questa tutela, frutto di un indefettibile bilanciamento con gli altri
legittimi interessi coinvolti ed almeno potenzialmente confliggenti
(si pensi a coloro che non parlano o non comprendono la lingua
protetta o a coloro che devono subire gli oneri organizzativi
conseguenti alle speciali tutele). E cio' al di la' della ineludibile
tutela della lingua italiana. ...Il legislatore statale dispone in
realta' di un proprio potere di doveroso apprezzamento in materia,
dovendosi necessariamente tener conto delle conseguenze che, per i
diritti degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza
linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri -
sul piano quindi della stessa operativita' concreta della protezione
- derivano dalla disciplina speciale dettata in attuazione dell'art.
6 della Costituzione» (sentenza n. 406 del 1999). Si tratta, inoltre,
di un potere legislativo che puo' applicarsi alle piu' diverse
materie legislative, in tutto od in parte spettanti alle Regioni»
(sentenza n. 159 del 2009, che ha giudicato illegittimo l'art. 11,
comma 5, della legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 29 del
2007, che stabiliva la facolta' per i Comuni di adottare toponimi
nella sola lingua friulana, ritenendolo in contrasto con il disegno
generale della legge n. 482 del 1999, fondato non solo sulla
valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie, ma anche
sulla preservazione del patrimonio linguistico e culturale della
lingua italiana).
Infine, «La consacrazione, nell'art. 1, comma 1, della legge n.
482 del 1999, della lingua italiana quale "lingua ufficiale della
Repubblica" non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge
da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che
prevedono l'uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano
essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali
da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica;
e cio' anche al di la' delle pur numerose disposizioni specifiche che
affermano espressamente nei singoli settori il primato della lingua
italiana (art. 4, comma 1; art. 7, commi 3 e 4; art. 8. confronta,
inoltre, l'art. 6, comma 4, del regolamento di attuazione della legge
n. 482 del 1999, emanato con il decreto del Presidente della
Repubblica 2 maggio 2001, n. 345)» (sempre sentenza n. 159 del 2009,
appena cit.).
4. - Come si e' gia' osservato, l'art. 10 della legge n. 482/1999
consente l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi
locali unicamente per le minoranze linguistiche individuate
dall'articolo 2 e nei territori individuati ai sensi dell'art. 3
della stessa legge e solo in aggiunta ai toponimi ufficiali.
Il dettato testuale della norma di cui al predetto art. 2 non
lascia dubbi di sorta: sempre come si e' gia' osservato, esso prevede
infatti la tutela della lingua e della cultura «delle popolazioni
albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo».
Appare dunque chiaro che in tale ambito non rientrano «i dialetti
di origine veneta nelle seguenti espressioni: il triestino, il
bisiaco, il gradese, il maranese, il muggesano, il liventino, il
veneto dell'Istria e della Dalmazia, nonche' il veneto goriziano,
pordenonese e udinese», in ordine ai quali statuisce la legge
regionale qui in esame, e in particolare l'art. 8, comma secondo.
E, in effetti, gia' essi non vi rientrano in base al dato
linguistico - che acquista rilevanza legislativa - secondo il quale
sono da distinguere le cc.dd. «lingue minoritarie» proprie delle
minoranze linguistiche, collegate ad un'area storica precisa (per es.
friulano, sardo, catalano e varie altre), sia dai cc.dd. «dialetti» -
da intendersi quali «varianti» di un continuum linguistico
geografico, riferito ad una precisa famiglia linguistica ovvero
«idiomi» territorialmente caratterizzati, a prescindere da qualsiasi
legame con altri eventuali idiomi geograficamente vicini o con la
lingua ufficiale (o lingue ufficiali) usata nel suo territorio di
pertinenza (come, ad esempio, la lingua lombarda, la lingua
napoletana, la lingua veneta e la lingua siciliana) - sia, e a
maggior ragione, dal «vernacolo», quale modo di parlare limitato ad
una precisa zona geografica, usata specificatamente dal popolo (e che
si differenzia dal dialetto per avere una copertura geografica e un
uso sociale piu' vasti).
Come ben noto, peraltro, l'art. 18 della legge in parola
prescrive per le Regioni a statuto speciale, che «l'applicazione
delle disposizioni piu' favorevoli previste dalla presente legge e'
disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti».
«E' quindi questo lo strumento cui la Regione poteva ricorrere
per introdurre eventuali normative volte alla «salvaguardia delle [
...] caratteristiche etniche e culturali» dei suoi cittadini
«qualunque [fosse] il gruppo linguistico» di appartenenza, che
fossero derogatorie rispetto al contenuto della legge n. 482 del
1999. A tale procedura - conformemente, del resto, a quanto previsto
dal gia' citato art. 18 della legge n. 482 del 1999 - si e' fatto
ricorso per procedere alla approvazione del d.lgs. 12 settembre 2002,
n. 223, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in
materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze
linguistiche storiche nella regione». Non si rinvengono, invece, in
alcuna parte del suddetto decreto legislativo di attuazione
disposizioni che introducano direttamente, o che autorizzino il
legislatore regionale ad introdurre normative derogatorie al
contenuto della legge n. 482 del 1999. E' tra l'altro, significativo
che lo stesso decreto definisca la legge n. 482 del 1999 (che reca il
titolo di «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche») come «"legge" per la tutela della lingua e della cultura
delle popolazioni che parlano il friulano e di quelle appartenenti
alla minoranza slovena e germanofona», usando, quindi, una
formulazione che direttamente riferisce il contenuto della legge alle
minoranze linguistiche della Regione» (sentenza n. 159 del 2009,
cit.).
L'art. 8, comma secondo, della legge regionale n. 5/2010 in
esame, che non costituisce norma di attuazione dello statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia, eccede dunque dalle competenze
regionali, attribuendo ai «dialetti di origine veneta nelle seguenti
espressioni: il triestino, il bisiaco, il gradese, il maranese, il
muggesano, il liventino, il veneto dell'Istria e della Dalmazia,
nonche' il veneto goriziano, pordenonese e udinese», con riferimento
alla toponomastica, una tutela piu' ampia di quella che il
legislatore statale, in attuazione dell'art. 6 Cost., ha riconosciuto
alle sole lingue minoritarie con la legge n. 482 del 1999, tra le
quali essi dialetti, comunque, non rientrano.
5. - La norma regionale in esame, inoltre, stabilendo altresi'
implicitamente l'uso esclusivo di tali dialetti per i cartelli
relativi alla segnaletica stradale incide nella competenza esclusiva
statale in materia di circolazione stradale, della quale la
segnaletica stradale fa parte, secondo quanto affermato da codesta
Corte nella sentenza n. 428 del 2004, e viola pertanto sia l'art. 3,
secondo comma, Cost. per la lesione del principio del rispetto della
eguaglianza dei cittadini del Paese, sia la competenza statale
esclusiva nelle materie considerate dall'art. 117, secondo comma,
lett. h).
A tal ultimo riguardo, e' bene osservare che essa contrasta in
particolare con l'art. 37, comma 2-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992,
secondo il quale i Comuni e gli altri enti indicati nel comma 1
«possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del
confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella
zona di riferimento in aggiunta alla denominazione nella lingua
italiana».
P. Q. M.
Si conclude perche' sia dichiarata la illeggittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 17
febbraio 2010, n. 5, «Valorizzazione dei dialetti di origine veneta
parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia».
Roma, addi' 19 aprile 2010
L'Avvocato dello Stato: Diego Giordano
|